

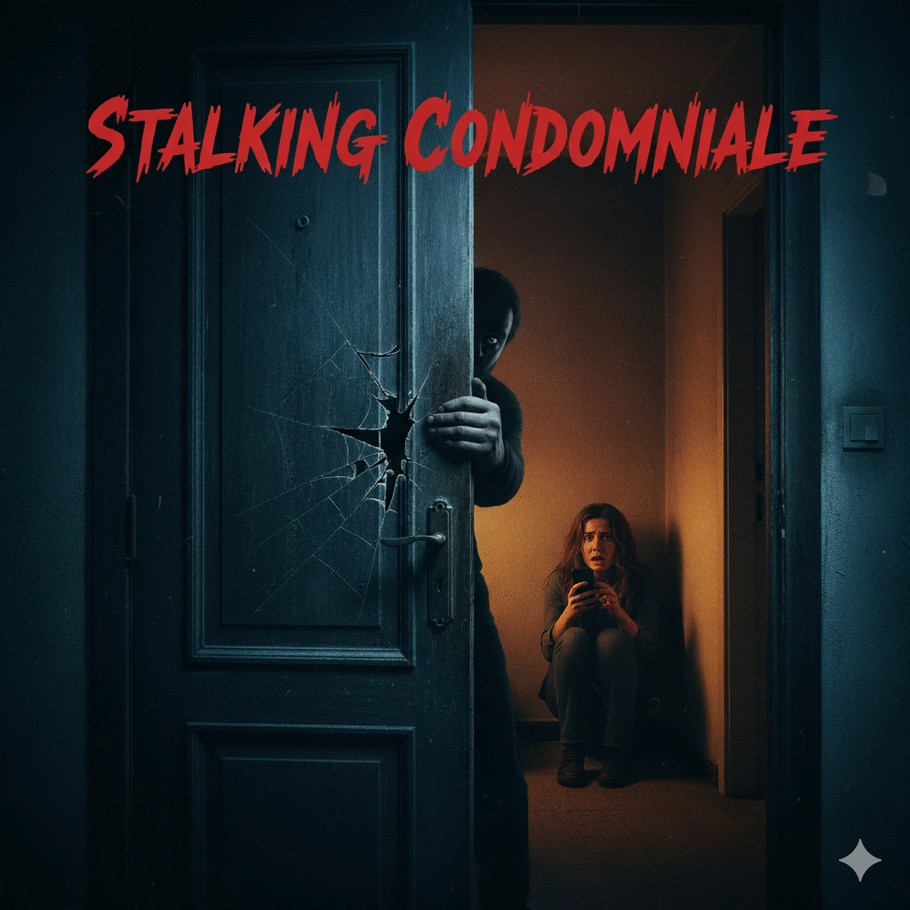
Il rapporto di vicinato, si sa, può essere difficile. Communio est mater rixarum, dicevano i latini: la convivenza forzata in uno stesso stabile spesso è “madre di liti”. Rumori molesti, musica ad alto volume a tarda notte, sporcizia intenzionale nelle aree comuni, offese gridate sul pianerottolo, danneggiamenti e minacce: sono solo esempi di comportamenti che alcuni vicini di casa mettono in atto, trasformando il condominio in un incubo quotidiano per chi li subisce. Non si tratta più di semplici dispetti o diverbi isolati: quando si instaura un clima persecutorio continuo, tale da generare uno stato di ansia e di paura, significa che il vicino molesto è diventato un persecutore. In casi del genere, la legge italiana non rimane indifferente: interviene con lo strumento penalistico dello stalking per punire chi tormenta i propri vicini.
«Nemmeno l’uomo più buono può stare in pace se ciò non garba al cattivo vicino.» – Friedrich Schiller. Questa celebre citazione evidenzia una triste realtà: la mala vicinanza può distruggere la serenità personale. Per fortuna, il nostro ordinamento oggi riconosce che le molestie ripetute in ambito condominiale non vanno tollerate e, anzi, possono integrare gli estremi di un reato grave. Vediamo dunque quando i litigi tra vicini superano il limite e diventano stalking, quali sono i requisiti previsti dalla legge e cosa ha stabilito la recente giurisprudenza in materia.
Il reato di atti persecutori, introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 612-bis del Codice Penale, è comunemente noto come stalking. In origine la norma mirava a punire le persecuzioni nell’ambito di relazioni personali (es. ex partner insistenti). Oggi, grazie a un’interpretazione evolutiva, si è compreso che anche le vessazioni tra vicini di casa possono rientrare nello stalking, purché abbiano le caratteristiche previste dalla legge.
Che cos’è lo stalking? Si configura quando una persona pone in essere condotte ripetute di minaccia o molestia tali da causare nella vittima conseguenze gravi sul piano psicologico o nelle sue abitudini di vita. In particolare, l’art. 612-bis c.p. richiede che i comportamenti persecutori provochino almeno uno dei seguenti effetti:
Un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Non basta il semplice fastidio: la vittima deve trovarsi in uno stato d’ansia intenso, continuo e superiore alla normale tollerabilità, vivendo con il timore costante di subire ulteriori molestie.
Un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. La persona offesa teme, con ragionevolezza, per la propria sicurezza fisica (o per quella di un familiare). Ad esempio, il vicino minaccioso le fa paura al punto da farle temere un’aggressione o danni gravi.
La costrizione a cambiare le proprie abitudini di vita. La vittima, per sfuggire alle persecuzioni, modifica il suo stile di vita o le routine quotidiane. Ad esempio, evita di uscire di casa da sola, cambia percorso per rientrare, installa telecamere di sorveglianza, tiene sempre chiuse le finestre, o addirittura valuta di trasferirsi.
È sufficiente anche uno solo di questi eventi per aversi stalking. Il reato, infatti, ha natura di reato abituale ad eventi alternativi: ciò significa che basta integrare una qualsiasi delle condizioni sopra descritte perché il delitto sia configurabile. Per esempio, anche se la vittima non ha modificato le proprie abitudini, sarà comunque stalking se ha subito un grave stato d’ansia oppure se ha avuto paura per la propria incolumità.
Stalking “condominiale”: un reato abituale. Bisogna sottolineare che lo stalking si realizza attraverso una serie di atti molesti o intimidatori reiterati nel tempo. Tipicamente non basta un episodio isolato: serve una pluralità di comportamenti. Tuttavia, non esiste un numero fisso di azioni persecutorie necessario. La giurisprudenza ha chiarito che anche due soli episodi possono bastare (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 26757/2025), a patto che siano sufficientemente gravi e inseriti in un contesto di perdurante vessazione. Non è dunque necessario che le molestie avvengano in modo quotidiano o ravvicinato: ad esempio, se un vicino compie un atto intimidatorio oggi e lo ripete dopo qualche mese, quei due episodi, se isolati ma molto gravi, possono comunque integrare il reato. Ciò vale specialmente nei contesti condominiali, dove a volte un singolo episodio eclatante, seguito da un altro a distanza di tempo, è sufficiente a far vivere la vittima nel terrore.
È importante evidenziare che lo stalking è un reato contro la persona: il bene giuridico tutelato è la libertà morale e la tranquillità psicologica dell’individuo. Proprio per questo, la Cassazione ha precisato che l’illecito riguarda le persone fisiche e non entità collettive. In altre parole, non si può parlare di “stalking” ai danni di un condominio inteso come comunità o come soggetto unitario: saranno i singoli condòmini eventualmente a rivestire il ruolo di persone offese. Ad esempio, se un condomino molesta tutti i suoi vicini, le vittime del reato saranno le singole famiglie o persone molestate, non il condominio in sé (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 20386/2025). Questo è importante anche ai fini processuali: ogni vittima potrà sporgere querela e costituirsi parte civile per i danni subiti, ma non potrà farlo l’assemblea condominiale in quanto tale.
Negli ultimi tempi le corti italiane – e in particolare la Corte di Cassazione – sono intervenute più volte per delineare i confini applicativi dello stalking in ambito condominiale, fornendo chiarimenti sugli elementi costitutivi del reato e sulle condizioni in cui le liti tra vicini travalicano in condotte penalmente rilevanti. Ecco alcuni principi chiave affermati dalla giurisprudenza recente:
Bastano poche condotte, se gravi. Come già accennato, la Cassazione ha ribadito che non occorre una lunga serie di azioni moleste: anche due soli comportamenti persecutori possono configurare il delitto, anche se avvenuti a distanza di anni l’uno dall’altro, purché la loro gravità sia tale da produrre gli effetti tipici di cui all’art. 612-bis c.p. (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 26757/2025). Questo orientamento smentisce la diffusa convinzione che serva un numero elevato di episodi ravvicinati: ciò che conta è l’effetto complessivo sulla vittima. Dunque, anche episodi isolati ma particolarmente traumatici (es. il vicino che in un’occasione abbatte la porta di casa o aggredisce verbalmente con violenza) possono rientrare nello stalking se gettano la vittima in uno stato d’ansia perdurante.
Conflitti reciproci e ambiente litigioso: attenzione, può esserci comunque stalking. Spesso la vita condominiale è fatta di litigi reciproci, piccoli dispetti incrociati e un clima di tensione in cui entrambe le parti si accusano a vicenda. In passato qualcuno riteneva che, se le ostilità erano reciproche, non si potesse parlare di stalking (che presuppone normalmente un “persecutore” e una “vittima” ben distinte). La Cassazione ha però chiarito che la conflittualità condominiale di per sé non esclude la configurabilità del reato. Anche in un contesto litigioso, bisogna verificare se talune condotte abbiano superato il limite, producendo nella controparte quelle conseguenze di paura o di alterazione di vita tipiche dello stalking. In sostanza, il giudice deve accertare con rigore l’effettivo evento di danno subito dalla persona offesa (ansia, paura, turbamento stabilizzato) e, se tale evento sussiste ed è causato dalle azioni dell’altro, poco importa che ci fossero screzi reciproci (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 36576/2025). Un ambiente rissoso quindi non scrimina chi adotti condotte persecutorie gravi: l’eventuale “do ut des” di dispetti potrà semmai influire sulla valutazione probatoria, ma non impedisce di ritenere integrato il reato se vi è prova che una delle parti ha realmente subito un serio pregiudizio psicologico a causa dell’altra.
È sufficiente uno degli eventi di reato (ansia, timore o modifica delle abitudini). Un altro chiarimento importante fornito dalla Suprema Corte riguarda gli effetti richiesti dall’art. 612-bis c.p. Si è ribadito che questi eventi (stato d’ansia, paura per l’incolumità, cambiamento di vita) hanno natura alternativa: ne basta uno solo perché lo stalking sia configurabile (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 32506/2025). Ad esempio, non è necessario che la vittima provi di essere arrivata al punto di trasferirsi o cambiare radicalmente routine, se già può dimostrare di aver vissuto in un perdurante stato di angoscia e timore a causa del vicino molesto. Spesso, nei casi di stalking condominiale, la vittima continua a vivere nella propria casa ma in una condizione di costante ansia: questo basta per integrare l’elemento oggettivo del reato, senza bisogno di ulteriori cambiamenti esteriori. Ciò che conta è che la sofferenza psicologica sia reale, seria e documentabile (ad esempio tramite testimonianze, referti medici per lo stress subito, ecc.).
Il condominio non è “parte offesa”: lo sono le singole persone. Come anticipato, la giurisprudenza ha tenuto a precisare chi possa dirsi vittima dello stalking condominiale. Con una pronuncia del 2025 la Cassazione ha escluso che il condominio in quanto entità collettiva possa essere destinatario degli atti persecutori: questo reato tutela individui specifici, dunque solo i singoli condòmini possono essere riconosciuti come persone offese (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 20386/2025). In pratica, non esiste un “stalking contro il condominio” generalizzato: bisogna individuare una o più persone precise verso cui erano rivolte le condotte moleste (il vicino del piano di sotto, la famiglia dell’appartamento accanto, ecc.). Tale chiarimento evita confusioni e indica la strada corretta per le azioni legali: saranno i singoli vicini perseguitati a dover denunciare e a poter chiedere eventualmente i danni.
Queste sentenze tracciano un quadro più nitido dello stalking condominiale, confermando che la legge può e deve intervenire anche nei contesti di vicinato quando certe situazioni degenerano. La sostanza è che i vicini “prepotenti” e assillanti non godono di impunità solo perché le loro vittime vivono alla porta accanto: al contrario, i giudici stanno adottando un approccio severo (tolleranza zero verso i vicini molesti), riconoscendo pienamente la tutela penale in favore di chi subisce tali condotte. Per usare una formula efficace: anche tra le mura di casa, la legge fa sentire la sua voce.
Chi subisce molestie gravi e reiterate da parte di un vicino non è impotente: esistono diversi strumenti legali per difendersi. In presenza di comportamenti persecutori che rientrano nello schema dello stalking, la via principale è quella penale. Ecco i passi che una vittima di stalking condominiale può compiere:
Raccolta delle prove: è fondamentale documentare gli episodi molesti. Conviene annotare date e orari degli eventi, descrivere per iscritto ciò che accade (rumori, minacce, atti vandalici…), conservare eventuali messaggi o biglietti minatori, registrare audio o video se possibile (ad esempio, registrare con il telefono le urla o i colpi contro il muro), far constatare i danni (foto degli oggetti rovinati, ecc.). Inoltre, è utile coinvolgere altri condòmini come testimoni, qualora abbiano assistito ai fatti. Un diario dettagliato delle vessazioni e ogni elemento di prova saranno preziosi per sostenere la denuncia.
Intervento immediato delle forze dell’ordine: se la situazione degenera in minacce serie o atti di aggressione, è opportuno chiamare subito le forze dell’ordine (Polizia/Carabinieri) nell’immediatezza del fatto. Un intervento sul posto può calmare gli animi e soprattutto verrà redatto un verbale che documenta l’accaduto. In caso di danneggiamenti o pericoli, chiamare il 112 senza esitazione.
Querela per stalking: trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte (salvo alcune aggravanti), la vittima deve presentare una denuncia-querela entro sei mesi dall’ultimo episodio persecutorio. La querela va sporta presso un qualunque ufficio di Polizia o stazione dei Carabinieri, oppure direttamente in Procura. È importante dettagliare tutti i comportamenti subiti e i relativi effetti (ansia, paura, etc.), allegando le prove raccolte. Nella querela si possono indicare i testimoni (ad esempio altri vicini) e richiedere eventualmente l’adozione di misure cautelari urgenti a protezione (come il divieto di avvicinamento).
Misure cautelari a protezione della vittima: già in fase di indagini, il giudice su richiesta del PM può emettere provvedimenti per tutelare chi denuncia. Le misure più comuni nei casi di stalking sono il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (per monitorare gli spostamenti dell’indagato). Tali misure possono applicarsi anche allo stalker condominiale, impedendogli ad esempio di avvicinarsi all’abitazione della vittima o di sostare nelle parti comuni quando c’è la vittima presente. La Cassazione ha ritenuto legittimo, se ben motivato, l’uso congiunto di entrambe queste misure (obbligo di firma e contestuale divieto di avvicinamento) nei casi più seri di vicinato persecutorio (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 36576/2025). Ciò dimostra la sensibilità dei giudici nel garantire protezione effettiva a chi subisce stalking: lo scopo è scongiurare ulteriori molestie durante il procedimento penale.
Ammonimento del Questore (misura preventiva): prima ancora di arrivare nelle aule giudiziarie, esiste uno strumento amministrativo di prevenzione: l’ammonimento. Si tratta di un provvedimento di diffida formale che il Questore può emettere, su istanza della persona molestata, intimando al presunto stalker di cessare immediatamente le condotte pena conseguenze più gravi. L’ammonimento può essere richiesto quando ancora non si è presentata querela (ed è alternativo alla querela stessa: se si opta per l’ammonimento e lo stalker persevera, a quel punto scatta la procedibilità d’ufficio del reato). Nella pratica condominiale, l’ammonimento può servire a mettere in guardia il vicino molesto: è un ultimatum ufficiale da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Spesso, il solo fatto di ricevere la visita della Polizia con un ammonimento formale induce il molestatore a smettere, evitando di passare guai peggiori. Se ciò non bastasse, come detto, un successivo perdurare delle molestie renderà possibile procedere penalmente in modo più incisivo.
Azione civile per il risarcimento danni: lo stalking, oltre a costituire reato, comporta gravi danni non patrimoniali (stress, depressione, disturbi del sonno, peggioramento della qualità della vita, ecc.) e talvolta anche danni materiali (es. spese per installare sistemi di sicurezza, per trasferirsi altrove, o lesioni fisiche subite in aggressioni). La vittima ha tutto il diritto di chiedere un risarcimento. Questo può avvenire costituendosi parte civile nel processo penale contro lo stalker, oppure avviando una causa civile autonoma. In entrambi i casi, sarà necessario provare il nesso tra le condotte persecutorie e i pregiudizi subiti. Le sentenze di condanna penale per stalking solitamente liquidano anche un risarcimento o una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte civile. In sede civile, il giudice potrà riconoscere una somma per danno morale e esistenziale patito dalla vittima, tenendo conto della durata e dell’intensità delle sofferenze inflitte dal vicino persecutore.
Altre tutele e interventi ulteriori: nei casi meno gravi, che magari non arrivano a integrare lo stalking, esistono comunque rimedi legali. Ad esempio, per i rumori molesti al di fuori della normale tollerabilità si può agire civilmente ex art. 844 c.c. (immissioni intollerabili) chiedendo un provvedimento inibitorio del giudice civile. Oppure, se il vicino tiene comportamenti contrari al regolamento condominiale, si possono coinvolgere l’amministratore e l’assemblea per sanzionarlo. Inoltre, certi fatti specifici potrebbero configurare reati minori del codice penale: es. il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) per chi provoca schiamazzi notturni, o danneggiamento (art. 635 c.p.) se il vicino rompe intenzionalmente cose altrui, o minaccia (art. 612 c.p.) se proferisce frasi intimidatorie singole. Questi reati possono essere denunciati a parte. Tuttavia, quando ci si trova di fronte a una sistematicità di comportamenti ostili, conviene inquadrare tutto nel più grave reato di atti persecutori, così da avere un intervento più efficace e una risposta sanzionatoria adeguata.
In sintesi, lo “stalking condominiale” è oggi riconosciuto e perseguibile: i vicini particolarmente molesti e aggressivi che con la loro condotta rovinano la vita altrui possono essere chiamati a rispondere penalmente. Le più recenti sentenze hanno aperto la strada a una maggiore tutela delle vittime, chiarendo che basta anche un numero limitato di episodi – se essi generano ansia o paura – per far scattare il reato. Chi si sente perseguitato in casa propria non deve rassegnarsi né isolarsi nella sofferenza: la legge offre strumenti per reagire, dalle misure protettive immediate fino alla punizione del colpevole e al risarcimento dei danni. Non esiste giustizia fai-da-te che tenga: la risposta deve essere legale e avvenire nelle sedi opportune, per porre fine alle prepotenze in modo sicuro e definitivo. Se vi riconoscete in queste situazioni, sappiate che non siete soli e che potete far valere i vostri diritti.

Redazione - Staff Studio Legale MP