

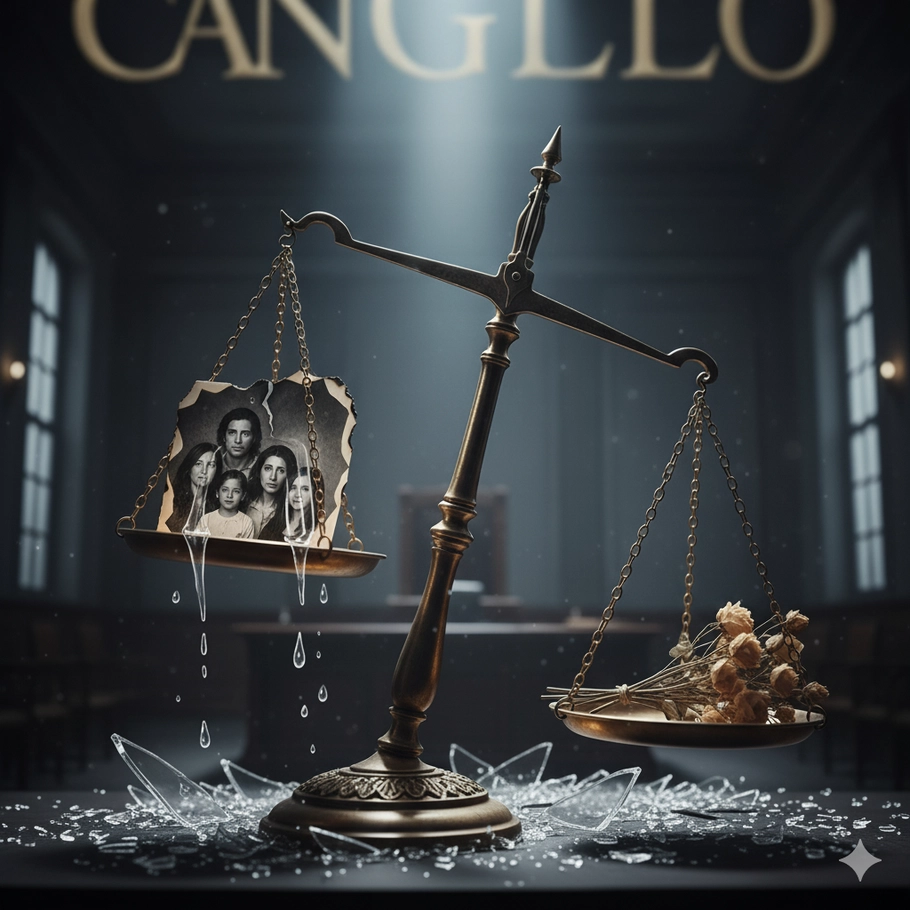
Introduzione: il “danno parentale” e il suo riconoscimento
La perdita di un familiare per un fatto illecito altrui (ad esempio un incidente stradale mortale o un caso di malasanità) provoca nei congiunti un dolore immenso e un vuoto incolmabile. In ambito legale, questo pregiudizio è definito danno da perdita del rapporto parentale – una forma di danno non patrimoniale che comprende sia la sofferenza interiore (danno morale) sia gli sconvolgimenti nella vita quotidiana e affettiva (danno dinamico-relazionale). Fino a pochi anni fa, ottenere il risarcimento di questo danno non era scontato: ai parenti della vittima era richiesto di dimostrare in giudizio l’intensità del legame affettivo e l’effettiva sofferenza subita, spesso attraverso testimonianze o altri elementi probatori. Oggi lo scenario è cambiato. La Corte di Cassazione, con alcune importanti pronunce, ha semplificato questo percorso riconoscendo che il dolore per la morte di un congiunto stretto è talmente naturale da essere presunto “in re ipsa” – cioè evidente di per sé – salvo prova contraria. «Date parola al dolore: il dolore che non parla sussurra al cuore e gli dice di spezzarsi.» – Shakespeare. Questa frase letteraria ben esprime l’inevitabilità e la profondità del dolore, concetto che anche la giustizia ha iniziato a fare proprio nelle aule dei tribunali. Vediamo allora come le sentenze recenti stanno rafforzando la tutela dei familiari delle vittime, sia sul piano probatorio sia sul piano della quantificazione del risarcimento.
La presunzione del dolore dei congiunti: inversione dell’onere della prova
Tradizionalmente, madre, padre, figli, coniuge e perfino fratelli della vittima dovevano provare di aver subito un grave dolore e uno sconvolgimento esistenziale per ottenere il risarcimento. Questo approccio però cozzava con una realtà di comune esperienza: è pressoché certo che la morte di una persona amata provochi sofferenza nei familiari prossimi. La Cassazione ha dunque operato un vero cambio di rotta a tutela dei danneggiati. Con l’ordinanza n. 6500 dell’11 marzo 2025 (Cass. civ., Sez. III), la Suprema Corte ha stabilito che il legame affettivo tra fratelli è oggetto di presunzione semplice: in caso di morte di un fratello, l’altro ha diritto al risarcimento del danno morale senza dover dimostrare l’effettività del vincolo affettivo, che si presume esistente finché non venga prova del contrario. In altre parole, la sofferenza dei familiari stretti è presunta (in termini giuridici si parla di presunzione iuris tantum ex art. 2727 c.c.), e spetta al responsabile civile – ad esempio l’assicurazione del soggetto che ha causato l’evento – l’onere di provare il contrario, cioè che tra la vittima e il parente superstite vi fosse indifferenza o addirittura odio al punto da escludere un patimento. Questa decisione s’innesta in un filone evolutivo che riguarda non solo i fratelli ma tutti i congiunti più prossimi. Poche mesi dopo, infatti, la Cassazione ha ribadito il principio estendendolo in generale alla famiglia nucleare e d’origine: con l’ordinanza n. 28255 del 24 ottobre 2025 (Cass. civ., Sez. III) si è confermato che la morte di una persona cara fa presumere di per sé un dolore morale nei suoi stretti familiari (coniugi, figli, genitori e fratelli), a prescindere dalla convivenza o da quanto si frequentassero. Anche in questo caso, l’assenza di convivenza o la lontananza non possono essere utilizzate per negare il diritto al risarcimento – semmai potranno incidere solo sulla quantificazione, come vedremo oltre. Questo significa che oggi il familiare che agisce in giudizio per il danno parentale parte da una posizione di netto vantaggio rispetto al passato: non deve più “dimostrare di aver sofferto”, perché il suo dolore è umano, normale e viene legalmente riconosciuto come tale. Tocca al convenuto semmai dimostrare che non vi fu alcun rapporto affettivo degno di tutela. Di fatto, è un’inversione dell’onere probatorio che rende più agevole per le vittime ottenere giustizia. È importante sottolineare però che la presunzione riguarda essenzialmente la sofferenza interiore (il turbamento morale). Quanto invece agli aspetti più concreti del danno (il cosiddetto danno relazionale, cioè le ripercussioni sulla vita quotidiana, sulle abitudini e sull’organizzazione familiare), rimane necessario provare la consistenza e intensità del rapporto che legava il superstite al defunto: convivenza, frequentazione assidua, supporto reciproco, dipendenza affettiva o economica, e così via. Questi elementi servono più che altro a determinare quanto elevato debba essere il risarcimento entro i parametri previsti, non a escluderlo. In sintesi, oggi la legge afferma che il dolore morale per la morte di un congiunto stretto è, di norma, intrinseco alla perdita stessa, mentre eventuali particolarità del rapporto (ad es. rapporti molto freddi o assenti) possono essere valutate solo per ridurre o negare il danno in casi eccezionali in cui si provi l’assenza di legame affettivo.
Chi ha diritto al risarcimento? Legami di sangue e relazioni affettive stabili
Un’altra domanda frequente riguarda quali soggetti possano ottenere il risarcimento del danno parentale. La regola generale include il coniuge, i figli, i genitori e, come visto, anche i fratelli e le sorelle della vittima. Ma la giurisprudenza da tempo riconosce tutela anche a chi, pur non essendo legato da vincolo di sangue o parentela stretta, dimostri di avere avuto con il defunto un rapporto affettivo stabile e significativo. Pensiamo ai casi di conviventi di fatto (partner non sposati) oppure di figure come un patrigno o una matrigna che abbiano cresciuto il figliastro come un proprio figlio. La Cassazione ha chiarito che il legame biologico non è imprescindibile: ciò che conta è la relazione affettiva concreta. Ad esempio, è stato riconosciuto il risarcimento al compagno della madre per la morte della figlia di lei, una bambina di 4 anni, perché quest’uomo aveva convissuto per anni col nucleo familiare e fatto da “padre putativo” alla piccola, vista l’assenza totale del padre naturale. In tale caso, pur mancando la consanguineità, si è accertato in giudizio che il compagno della madre avesse instaurato con la bambina un rapporto di cura e amore parentale del tutto analogo a quello paterno: ciò è bastato perché gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno parentale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5984/2025). La Cassazione aveva già affermato con la sentenza n. 31867/2023 che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva”. Ovviamente, in assenza di un legame presunto come quello familiare tradizionale, chi chiede il risarcimento dovrà fornire la prova di questa relazione di fatto (ad esempio la convivenza, la durata e qualità del legame, la frequenza dei rapporti, l’apporto reciproco, etc.). In conclusione su questo punto: la cerchia dei possibili danneggiati risarcibili si estende oltre i confini anagrafici della parentela, abbracciando tutti coloro che possano essere considerati, per la loro effettiva vicinanza affettiva, “famiglia” della vittima. Questo è molto importante nell’era delle famiglie di fatto e delle unioni non tradizionali, perché garantisce giustizia anche al di fuori degli schemi classici.
Criteri di liquidazione: come si calcola il risarcimento del danno parentale?
Una volta accertato il diritto al risarcimento, resta da determinare quanto spetta a ciascun familiare. Qui entrano in gioco le cosiddette tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, strumenti creati dalla giurisprudenza per assicurare una certa uniformità su base nazionale. Negli ultimi anni c’è stata un’evoluzione anche sotto questo profilo. I due principali modelli tabellari in Italia sono quelli del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, ma la Cassazione ha più volte indicato come preferibile il sistema elaborato a Milano, soprattutto dopo l’aggiornamento del 2022 che ha introdotto il criterio “a punti”. Le tabelle milanesi recenti, aggiornate al 2024, prevedono infatti per ogni categoria di congiunto un valore base di risarcimento e dei punteggi per modulare l’importo a seconda di vari fattori (età della vittima, età del superstite, intensità del legame, convivenza, presenza di altri familiari, ecc.). Ad esempio, per la perdita di un genitore o di un figlio, la Tabella di Milano 2024 indica un importo base indicativo intorno a 195.000 euro, con possibilità di aumento fino a circa 390.000 euro in caso di massima personalizzazione (rapporto eccezionalmente intenso, morte prematura e improvvisa, ecc.). Importi simili sono previsti anche per il coniuge superstite. Per la perdita di un fratello, le cifre base sono più basse (nell’ordine di qualche decina di migliaia di euro) ma comunque aumentabili in presenza di legami particolarmente stretti. È bene chiarire che queste non sono somme fisse imposte dalla legge, bensì criteri orientativi: il giudice ha il potere di adeguare l’importo al caso concreto. Ciò premesso, le tabelle milanesi fungono da riferimento principale e garantiscono che, in casi analoghi, i risarcimenti siano simili su tutto il territorio nazionale, evitando disparità troppo marcate. La Cassazione nel 2025 è intervenuta anche su questo tema. In particolare, con l’ordinanza n. 14285 del 29 maggio 2025 (Cass. civ., Sez. III), ha stabilito che se un giudice d’appello liquida il danno parentale usando una tabella superata o meno favorevole (ad esempio il sistema “a forbice” anziché quello “a punti”), il familiare danneggiato può impugnare la decisione per chiedere l’applicazione della tabella più vantaggiosa, purché ne motivi la maggiore convenienza. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva utilizzato un importo forfettario senza esplicitare se avesse adottato la versione aggiornata della Tabella di Milano; la vedova, in Cassazione, si era lamentata che non si fossero applicati i nuovi parametri introdotti nel 2022, potenzialmente a lei più favorevoli. Ebbene, la Cassazione le ha dato ragione, affermando il principio che il danneggiato ha diritto a vedersi riconosciuto il metodo di calcolo più aggiornato ed equo: se la liquidazione è avvenuta con criteri antiquati o meno precisi, egli può chiedere la riforma della sentenza affinché siano adottate le tabelle più recenti (come quelle “a punti”) che di norma portano a un importo maggiore e più aderente alla realtà del danno subito. Questa pronuncia conferma l’orientamento della Suprema Corte verso una standardizzazione in senso migliorativo: le tabelle “a punti” sono ritenute preferibili perché assicurano maggiore trasparenza e completezza nella valutazione, tenendo conto di tutte le variabili rilevanti. In definitiva, oggi chi si rivolge alla giustizia per il risarcimento del danno parentale può contare su parametri più chiari per calcolare il valore economico della perdita: ciò riduce il rischio di valutazioni arbitrarie e rende più prevedibile l’esito delle cause, nell’ottica di garantire a tutti i familiari delle vittime un trattamento omogeneo e proporzionato al loro effettivo dolore.
Conclusioni: maggior tutela per le vittime secondarie e importanza di un’assistenza legale qualificata
Le novità giurisprudenziali degli ultimi tempi segnano un significativo progresso nella tutela dei diritti dei familiari colpiti da un lutto provocato da fatto illecito. In sintesi: la Cassazione ha riconosciuto che la sofferenza dei parenti stretti è un fatto intrinseco alla perdita (“costituisce un danno in sé”), sollevando queste vittime secondarie dall’onere gravoso di dover dimostrare in tribunale il proprio dolore. Contestualmente, si è preoccupata di garantire che il risarcimento sia determinato con criteri il più possibile uniformi e adeguati alla gravità dell’evento, evitando sia sotto-risarcimenti offensivi sia eccessi infondati. Tuttavia, nonostante l’importante “mano tesa” delle recenti pronunce, ottenere giustizia in questi casi resta un percorso complesso: bisogna comunque affrontare un giudizio, quantificare correttamente le pretese, raccogliere le prove necessarie per la personalizzazione del danno e navigare tra aspetti tecnici (polizze assicurative, massimali, eventuali concause o responsabilità concorrenti, ecc.). Per questo motivo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in materia di risarcimento danni. Lo Studio Legale MP di Verona è a vostra completa disposizione per valutare il vostro caso con sensibilità e competenza, e per assistervi in ogni fase della richiesta risarcitoria, forte dell’aggiornamento costante sulle ultime novità normative e giurisprudenziali. Se avete perso una persona cara in un incidente stradale, sul lavoro, per malasanità o altro fatto ingiusto, non siete soli: potete rivolgervi allo Studio Legale MP per ottenere un primo parere orientativo gratuito e capire come procedere. In un momento così difficile, poter contare su un supporto legale affidabile è essenziale per far valere i vostri diritti e ottenere il giusto ristoro: “Dura lex, sed lex”, la legge è severa ma, quando applicata con rigore e umanità, sa riconoscere e compensare – per quanto possibile in termini economici – il dolore di chi resta.

Redazione - Staff Studio Legale MP