

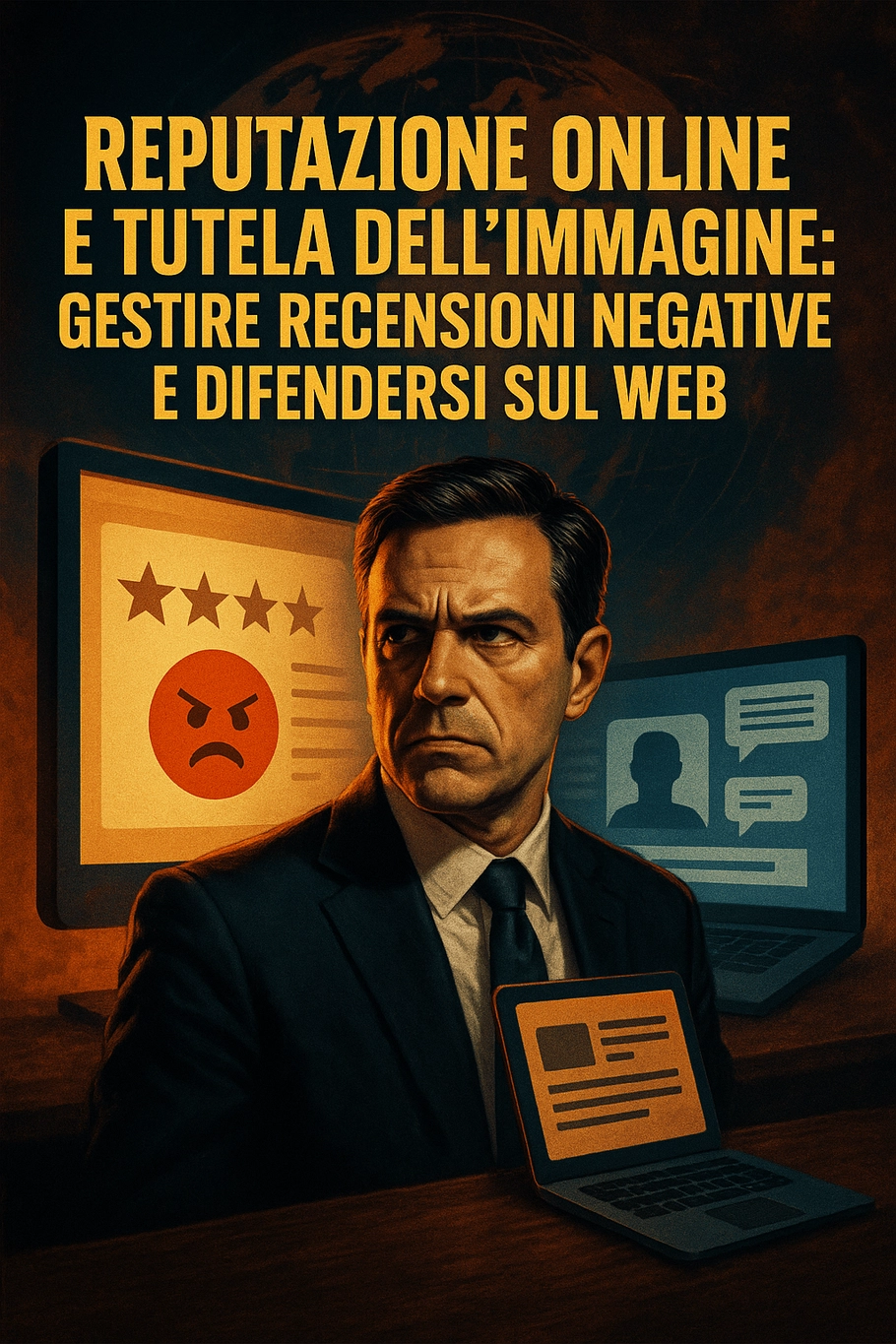
Come proteggere la reputazione digitale e l’immagine personale o aziendale: guida legale aggiornata tra diritto all’oblio, diffamazione online e gestione delle recensioni negative.
In un’era dominata da internet, reputazione e immagine personali o aziendali sono beni di valore incalcolabile – “il buon nome, mio caro signore, sia per l’uomo che per la donna, è la gemma più preziosa dell’anima”, scrive Shakespeare in Otello. Una singola recensione negativa o un contenuto lesivo sul web può propagarsi in un attimo, causando danni duraturi. Come dicevano i latini, Verba volant, scripta manent: le parole volano, ma ciò che è scritto (online) rimane. La velocità e la memoria di Internet fanno sì che una notizia o diceria diffamatoria possa diffondersi ovunque in pochi istanti – “Fama, malum qua non aliud velocius ullum”, avvertiva Virgilio: nessun male corre più rapido del pettegolezzo. Proteggere la reputazione online è dunque cruciale sia per i privati cittadini sia per le aziende e i professionisti, al fine di evitare ripercussioni su vita personale, opportunità lavorative e fiducia dei clienti.
L’ordinamento italiano riconosce e tutela il diritto all’onore, al decoro e alla reputazione (articoli 2 e 3 Cost.; articoli 2043 e 2059 c.c.). Chi subisce attacchi ingiusti alla propria immagine può reagire sia sul piano civile (chiedendo il risarcimento del danno, anche morale o da perdita di chance lavorative) sia sul piano penale. Il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) punisce infatti chiunque offenda la reputazione altrui comunicando con più persone. Se l’offesa avviene tramite mezzi di pubblicità o mass media – come appunto Internet, social network o testate online – scatta la circostanza aggravante (art. 595 co.3 c.p.): il fatto diventa diffamazione aggravata a mezzo stampa o internet, punita più severamente. Ad esempio, pubblicare su Facebook o su un forum accuse infamanti verso qualcuno configura normalmente diffamazione aggravata, in quanto il messaggio raggiunge un pubblico vasto e indeterminato. In ambito civile, la divulgazione illecita dell’immagine altrui (foto o video pubblicati senza consenso in contesti lesivi della dignità) può violare l’art. 10 c.c. e la normativa privacy, dando luogo ad azioni per inibire ulteriori diffusioni e per ottenere il risarcimento del danno d’immagine. In casi gravi di lesione della reputazione online, è possibile anche ricorrere a provvedimenti d’urgenza (ad esempio un’ingiunzione di rimozione ex art. 700 c.p.c.) quando la permanenza di un contenuto lesivo in rete comporti un pregiudizio imminente e irreparabile.
Un capitolo centrale della tutela della reputazione sul web riguarda le recensioni online, in particolare le recensioni negative su servizi e prodotti. Si pensi ai commenti su Google, Facebook, TripAdvisor o portali simili: il loro impatto può determinare il successo o il fallimento di un’attività commerciale. Occorre però distinguere tra critica legittima e diffamazione. Il diritto di critica consente ad ogni cittadino di esprimere liberamente giudizi anche aspri, purché veritieri, pertinenti e non meramente offensivi sul piano personale. Pertanto, una recensione negativa basata su un’esperienza reale – ad esempio un cliente che lamenta servizio scadente o qualità del prodotto insufficiente – rientra di norma nella liceità, anche se usa toni duri: la legge tutela la libertà di espressione e il diritto del consumatore di recensire un servizio. Il giudizio deve sempre riguardare il servizio ricevuto e mai la sfera privata o la dignità personale del titolare: non sono ammessi attacchi gratuiti alla persona del professionista o dell’imprenditore.
Di converso, accuse false o insulti puramente denigratori in una recensione travalicano il diritto di critica e possono integrare diffamazione. Scrivere una falsa recensione negativa al solo scopo di danneggiare la reputazione altrui costituisce reato: si tratta appunto di diffamazione aggravata se il messaggio raggiunge più persone tramite internet. In tali casi, il titolare bersaglio della recensione può sporgere querela: si avvierà un procedimento penale contro l’autore del commento, nel quale la vittima potrà anche costituirsi parte civile e chiedere i danni. Un esempio pratico: nel 2023 ha fatto notizia la vicenda di una trattoria salentina che aveva denunciato due ex dipendenti per le dure recensioni negative pubblicate su Google. Le recensioni accusavano il titolare di comportamento aggressivo e il locale di scarsa igiene (“pesce scaduto fatto passare per fresco”). Ebbene, il Tribunale di Lecce ha assolto le autrici dei commenti ritenendo che “scrivere in una recensione negativa che cibo e servizio non sono piaciuti rientra nell’esercizio del diritto di critica e non è diffamazione”, anche se il tono è offensivo, purché i fatti narrati risultino veri. In quel caso le indagini avevano riscontrato riscontri oggettivi alle lamentele (altri clienti “esterrefatti” dalla scarsa pulizia, testimonianze sull’aggressività abituale del proprietario), confermando la fondatezza delle critiche. Dunque la legge ammette espressioni dure se corrispondono a realtà e mirano a tutelare un interesse pubblico (informare i consumatori).
Diversamente è destinato a rispondere chi lancia accuse infondate o insulti personali. Emblematico è il caso di una stroncatura diffamatoria ai danni dello chef Carlo Cracco: nel 2021 un autore di recensioni fu condannato per diffamazione aggravata dopo aver pubblicato online commenti gravemente denigratori (definendo la cucina dello chef “una delusione totale, meglio un kebab” e lui “in caduta verticale”). Il tribunale ritenne quei commenti non una legittima critica gastronomica, ma un attacco lesivo della reputazione professionale dello chef, privo di adeguata base fattuale. L’autore dovette pagare una multa salata e risarcire il danno d’immagine. La linea di confine è quindi sottile ma netta: si possono esprimere opinioni negative, anche in tono acceso, però senza sconfinare nella diffamazione, che ricorre quando si attribuiscono fatti non veri o epiteti gratuiti lesivi dell’onore.
Un altro aspetto cruciale è la responsabilità dei gestori di siti e piattaforme (come social network, portali di recensioni o testate online) rispetto ai contenuti lesivi pubblicati dagli utenti. In Italia (recependo la normativa europea), vige il principio del “hosting provider passivo”: i fornitori di servizi online che ospitano contenuti di terzi non hanno un obbligo generale di sorveglianza preventiva sui materiali immessi dagli utenti (D. Lgs. 70/2003, attuativo della Dir. 2000/31/CE). Ciò significa che, finché il gestore si limita a fornire lo spazio web e non interviene attivamente sul contenuto, non è ritenuto responsabile in via diretta per eventuali post diffamatori o illegali. Il provider deve però attivarsi per rimuovere o disabilitare l’accesso a contenuti illeciti non appena ne abbia conoscenza ufficiale, ad esempio tramite ordine dell’autorità giudiziaria. Questa impostazione è stata confermata da recenti pronunce giudiziali: una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (31 gennaio 2023), riguardante una recensione negativa su TripAdvisor, ha stabilito che la piattaforma non è tenuta a rimuovere un commento critico salvo che sia riconosciuto come illecito dall’autorità competente. In quel caso un ristorante aveva citato in giudizio TripAdvisor per diffamazione a causa di una recensione sfavorevole, chiedendone la cancellazione e un risarcimento danni. Il tribunale non solo ha escluso la responsabilità del portale, ma ha ritenuto non diffamatorio il contenuto della recensione, trattandosi di giudizi di mediocre qualità del cibo espressi senza trascendere in offese gratuite. Il risultato? La richiesta del ristorante è stata rigettata e l’esercente condannato a pagare le spese legali. Questo precedente scoraggia le azioni temerarie contro piattaforme o clienti per semplici opinioni negative: se il commento rientra nel diritto di critica, la via giudiziaria può ritorcersi contro chi l’ha intrapresa (oltre a generare pubblicità negativa, il cosiddetto effetto Streisand).
Gestione delle recensioni negative: dal punto di vista pratico, un’azienda o professionista che riceve feedback negativi deve agire con cautela e strategia. Se la critica è ragionevole e magari costruttiva, conviene rispondere con professionalità, scusandosi e offrendo rimedio, mostrando così attenzione al cliente. Se invece la recensione contiene falsità gravi o insulti, è opportuno raccogliere prove (screenshot, link, eventuali testimonianze) e segnalare il contenuto al gestore della piattaforma chiedendone la rimozione perché contrario alle policy (quasi tutti i siti di recensioni vietano esplicitamente contenuti diffamatori o offensivi). Qualora il gestore non rimuova il post e il danno d’immagine sia consistente, si può valutare con il legale un’azione legale mirata: dalla diffida formale all’autore e al provider, fino alla querela per diffamazione o alla citazione in giudizio per illecito civile. Ricordiamo che in base alla legge italiana il provider non è obbligato a cancellare contenuti su semplice richiesta privata: di norma occorre una decisione dell’Autorità (es. un giudice) che accerti la diffamatorietà del contenuto. Anche per questo, la prevenzione e il monitoraggio sono fondamentali: impostare alert di Google o servizi di web monitoring consente di accorgersi subito di nuovi commenti o articoli sul proprio conto, così da intervenire prontamente. Inoltre, investire in buona comunicazione online e cura dei clienti può ridurre il rischio di recensioni negative o almeno mitigarne gli effetti (ad esempio ottenendo molte più recensioni positive autentiche che “diluiscano” l’impatto di poche valutazioni negative).
Un fenomeno correlato è quello delle false recensioni pilotate, sia negative (per colpire un concorrente) sia positive (per esaltare indebitamente sé stessi). Oltre a costituire condotte eticamente scorrette, le recensioni fake sono ora esplicitamente vietate da norme sopravvenute. Nel 2023 l’Unione Europea ha introdotto la Direttiva “Omnibus” (2019/2161), recepita in Italia con il D. Lgs. 26/2023, proprio per contrastare le recensioni ingannevoli online. Questa normativa impone maggiore trasparenza: ad esempio i siti di e-commerce devono indicare se i feedback provengono da consumatori verificati e vieta di pubblicare o commissionare recensioni false. Le aziende sorprese a manipolare le valutazioni dei clienti rischiano pesanti sanzioni amministrative: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può infliggere multe fino al 4% del fatturato annuo ai trasgressori. In parallelo resta operante la tutela penale: come accennato, chi pubblica scientemente una falsa recensione negativa per nuocere a un professionista può essere perseguito per diffamazione aggravata; parimenti, confezionare false recensioni positive dietro compenso o altro vantaggio configura, in certe circostanze, addirittura il reato di truffa ai danni dei consumatori (oltre che un illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quando un’azienda paga per recensioni fittizie). Si tratta di evoluzioni normative e giurisprudenziali recenti che evidenziano l’attenzione crescente delle istituzioni verso la reputazione commerciale online: la fiducia del pubblico nelle recensioni deve essere salvaguardata sia punendo le frodi sia tutelando le vittime di campagne diffamatorie.
Quando una informazione negativa sul proprio conto permane online a distanza di anni, nonostante abbia perso attualità, entra in gioco il diritto all’oblio. Questo diritto, consolidato sia dalla Corte di Giustizia UE sia dalla Corte di Cassazione italiana, consente a un soggetto di ottenere la rimozione o l’oscuramento dai motori di ricerca di notizie obsolete che continuano a pregiudicare la sua reputazione o riservatezza. Non si tratta di cancellare la storia, ma di bilanciare il diritto alla privacy e all’onore con il diritto di cronaca. Ad esempio, una persona assolta da vecchie accuse potrebbe chiedere che gli articoli sui suoi passati guai giudiziari non siano più immediatamente accessibili tramite Google. Proprio di recente la Corte di Cassazione (Sent. n. 14488/2025) è tornata sul tema, definendo il diritto all’oblio come “diritto a non rimanere esposti indefinitamente a una rappresentazione non più attuale della propria persona, che possa pregiudicare reputazione e riservatezza”. La Suprema Corte ha ribadito che, nel valutare se una notizia online debba essere oscurata, il tempo trascorso dalla pubblicazione originaria è un fattore decisivo. In linea con i principi già affermati a livello europeo, si è chiarito che i motori di ricerca (es. Google) sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei risultati e hanno la responsabilità di bilanciare il diritto dell’individuo all’oblio con l’interesse pubblico all’informazione.
In concreto, il soggetto interessato può inoltrare a Google (o al gestore del sito web che ospita la notizia) una richiesta di deindicizzazione o rimozione, motivando perché quella pagina, riferita a fatti molto remoti o non più rilevanti, gli causa un danno ingiusto. Se il gestore rifiuta, ritenendo tuttora di pubblico interesse l’accessibilità della notizia (come spesso accade quando la persona ha tuttora un ruolo pubblico o vi sono altre condanne in essere), resta la possibilità di rivolgersi all’Autorità Garante Privacy oppure al giudice. La Cassazione nel 2025 ha sottolineato che in ogni caso è fondamentale garantire l’aggiornamento e la contestualizzazione delle informazioni online: qualora non si ritenga di doverle eliminare, è quantomeno opportuno che gli articoli vengano integrati con note sull’esito finale delle vicende, così da fornire un quadro completo e veritiero al lettore. Ad esempio, nel caso affrontato, alcuni URL collegavano il nome del ricorrente ad un’indagine per associazione mafiosa dalla quale egli era poi risultato totalmente estraneo; la Corte ha ritenuto imprescindibile indicare accanto a quei risultati che l’interessato era stato assolto, se proprio non si procedeva alla rimozione integrale. Questa soluzione intermedia (la deindicizzazione sui motori di ricerca senza cancellare l’articolo originario, oppure l’annotazione dell’avvenuta assoluzione) permette di tutelare la reputazione attuale della persona senza eliminare le notizie dall’archivio storico. Il diritto all’oblio, dunque, costituisce un importante strumento di riabilitazione mediatica: garantisce che trascorso un congruo periodo, gli errori del passato (soprattutto se seguiti da esiti favorevoli per l’interessato) non continuino a perseguitarlo indefinitamente online.
La reputazione online si costruisce in anni ma può essere lesa in un giorno. È fondamentale adottare un atteggiamento proattivo: sorvegliare la propria presenza digitale, curare la comunicazione e intervenire tempestivamente davanti a potenziali lesioni. In caso di attacchi all’onore o all’immagine, le leggi offrono vari rimedi – dal reclamo ai gestori del sito, all’azione legale per diffamazione o per tutela della privacy, fino alla richiesta ai motori di ricerca di dimenticare certi dati. Ogni situazione va valutata con attenzione, bilanciando i diritti in gioco: libertà di espressione e diritto di critica da un lato, e tutela della dignità e verità dall’altro. Affidarsi a professionisti legali esperti in diritto dell’informatica e mediazione dei conflitti reputazionali può fare la differenza, aiutando a scegliere la strategia migliore caso per caso (spesso una diffida ben calibrata può risolvere il problema senza arrivare in tribunale). Come ricorda un detto attribuito a Publio Gizio, “Audacter calumniare, semper aliquid haeret”: calunnia pure con audacia, qualcosa resterà sempre attaccato. Purtroppo una smentita non cancella del tutto gli effetti di una falsa accusa. Per questo è meglio prevenire che curare: educare i propri dipendenti e collaboratori a una condotta rispettosa online, instaurare un dialogo con i clienti insoddisfatti per gestire i reclami in privato, e all’occorrenza agire in sede legale con decisione ma anche con la consapevolezza che una causa per diffamazione va intrapresa solo quando ve ne siano i presupposti solidi. In definitiva, la tutela della reputazione digitale è divenuta parte integrante della tutela della persona e dell’impresa nel XXI secolo: va esercitata con tutti gli strumenti offerti dalla tecnologia e dal diritto, con serietà, tempestività e competenza.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.