

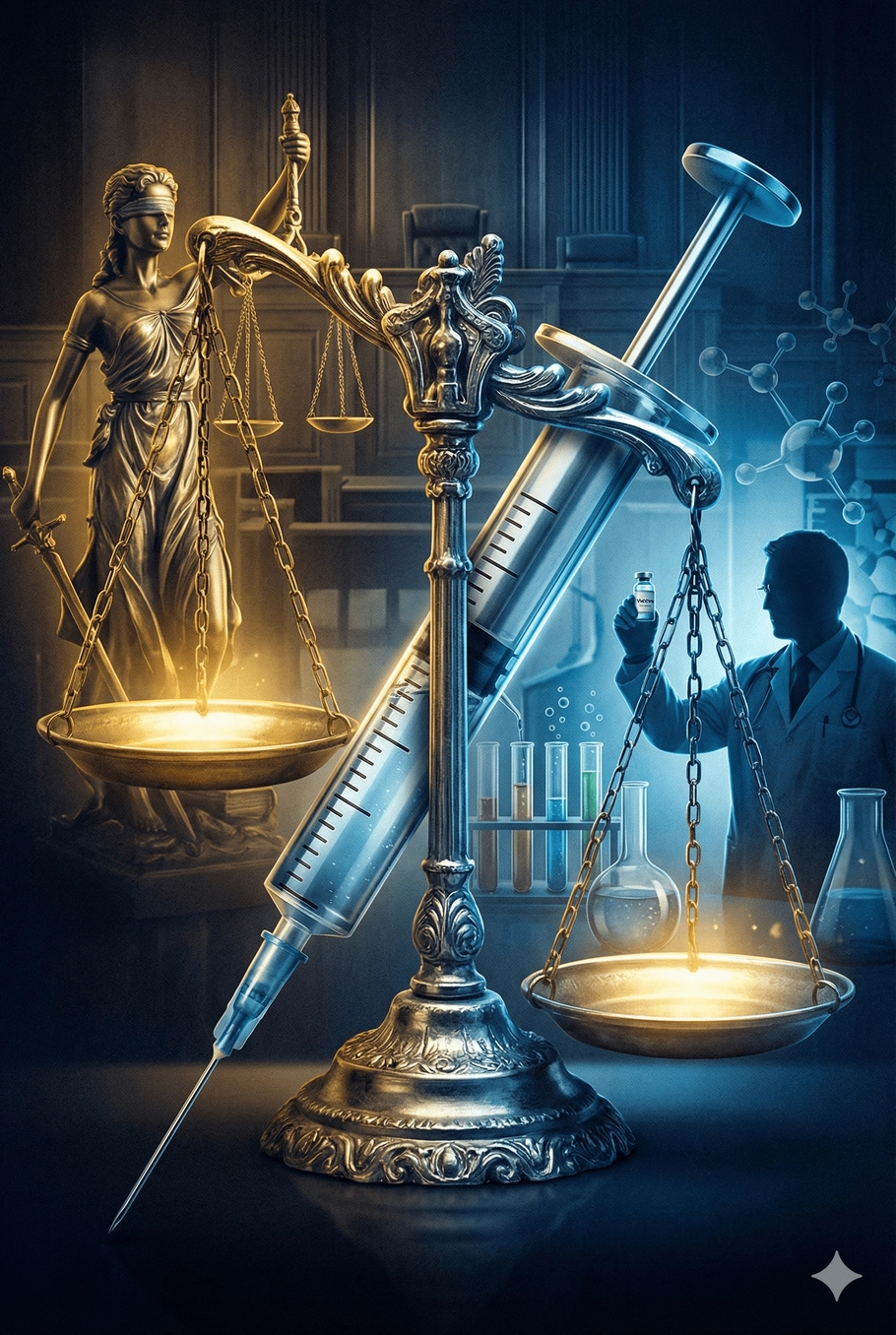
La legge italiana tutela chi riporta danni da vaccino con un indennizzo pubblico. Oggi, grazie a nuove sentenze, è possibile ottenere anche un risarcimento completo dei danni in sede civile: vediamo come funzionano queste tutele e cosa prevedono i più recenti orientamenti dei giudici.
La legge prevede un indennizzo statale per chi subisce lesioni permanenti da vaccinazioni. Recenti sentenze hanno rafforzato queste tutele: oggi anche i vaccini non obbligatori danno diritto all'indennizzo, i termini per chiederlo decorrono più tardi a vantaggio del danneggiato, e in alcuni casi è possibile ottenere un risarcimento integrale (ad esempio per mancanza di consenso informato). Questo articolo illustra gli strumenti giuridici a disposizione di chi ha riportato danni da vaccino e le più recenti novità giurisprudenziali in materia.
Indennizzo statale: cos’è e come ottenerlo
"La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente". Questa celebre frase di Arthur Schopenhauer ricorda quanto la salute sia un bene essenziale, al punto che l’ordinamento interviene per proteggere chi la perde a causa di eventi avversi. Nel caso dei vaccini, somministrati pro bono publico per prevenire malattie, il principio di solidarietà impone allo Stato di farsi carico dei rarissimi effetti negativi. Il nostro legislatore, già dal 1992, ha previsto infatti un indennizzo statale per i cittadini che riportino danni irreversibili in seguito a vaccinazioni obbligatorie. Si tratta di un sostegno economico di natura pubblica che prescinde da colpe o responsabilità: un vitalizio bimestrale e una somma aggiuntiva una tantum, riconosciuti a chi ha subito menomazioni permanenti in conseguenza del vaccino, come compensazione per il sacrificio compiuto nell’interesse collettivo. In altre parole, chi ha avuto complicanze gravi da un vaccino ottiene dallo Stato un aiuto economico senza bisogno di dimostrare errori medici o difetti, proprio perché primum non nocere è il principio guida della medicina, ma quando un trattamento necessario causa danno, la comunità deve farsene carico.
Per ottenere l’indennizzo occorre presentare una domanda amministrativa, corredata da documentazione medica, entro termini precisi. La legge n. 210/1992 fissa infatti a tre anni il termine per richiedere l’indennizzo (termine elevato a dieci anni in caso di decesso della persona vaccinata). Il dies a quo – ovvero il momento da cui parte il conteggio – è, per legge, quello in cui “si è manifestato il danno”. In passato questo limite ha creato non pochi problemi: spesso il danneggiato scopriva soltanto dopo molto tempo che la patologia sofferta era legata al vaccino, oppure la vaccinazione non era originariamente indennizzabile per legge e lo è divenuta solo in seguito (si pensi a certi vaccini inizialmente esclusi dalla tutela). Ebbene, la giurisprudenza recente ha adottato un approccio pro malato su questo fronte. La Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23590/2025 ha chiarito che il termine di tre anni inizia a decorrere dal momento in cui l’interessato viene a conoscenza non solo del danno, ma anche della possibilità legale di indennizzo per quel danno. In pratica, se al momento in cui la lesione si manifesta la legge ancora non prevedeva indennizzi per quel tipo di vaccino, il termine resta sospeso finché la normativa (o una sentenza) non riconosce tale diritto, e da lì decorre il triennio. Questo orientamento tutela chi ha scoperto tardi il nesso causale o si è visto aprire uno spiraglio normativo dopo anni: il diritto all’indennizzo non viene perso a causa di circostanze non dipendenti dalla volontà del danneggiato. Oggi, quindi, la prescrizione dell’indennizzo decorre in modo favorevole alla vittima: conta il momento in cui essa sa (o avrebbe potuto sapere con ordinaria diligenza) sia del danno da vaccino, sia dell’esistenza di un indennizzo previsto per quel tipo di danno.
Un’altra importante novità riguarda l’ambito di applicazione di questa tutela. In origine la legge del 1992 limitava l’indennizzo ai soli vaccini obbligatori per legge o per ordinanza sanitaria. Ciò escludeva dalla copertura gli eventuali danni da vaccinazioni semplicemente raccomandate dallo Stato. Tale distinzione è stata superata nel tempo grazie all’intervento dei giudici: già la Corte Costituzionale, con pronunce epocali (sent. n. 107/2012 e n. 268/2017), aveva dichiarato illegittimo negare l’indennizzo a chi si era sottoposto a vaccini raccomandati nell’interesse pubblico (rispettivamente il trivalente MPR contro morbillo-parotite-rosolia e il vaccino antinfluenzale). Più di recente, lo shock pandemico ha portato a un ulteriore ampliamento della platea: la legge n. 25/2022 ha incluso formalmente anche le reazioni avverse al vaccino anti-Covid-19 tra i casi indennizzabili ex lege 210/1992, pur trattandosi di vaccino non imposto alla popolazione generale (l’obbligo per Covid ha riguardato solo categorie particolari, come il personale sanitario e gli over 50 per un periodo). A fugare ogni dubbio residuo ci ha pensato la Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16875/2024, la quale ha sancito in modo chiaro che anche le vaccinazioni non obbligatorie danno diritto all’indennizzo statale. In quel caso la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero della Salute, confermando l’obbligo di indennizzare un minore danneggiato da un vaccino raccomandato: conta il fatto che la vaccinazione sia stata effettuata nell’interesse della collettività, indipendentemente dall’obbligatorietà formale. Oggi, dunque, chiunque riporti un’infermità permanente a causa di un vaccino somministrato nell’ambito dei piani vaccinali pubblici – obbligatorio o semplicemente consigliato – ha diritto a questo sostegno economico.
È importante ricordare che l’indennizzo non equivale a un risarcimento integrale del danno. Esso consiste infatti in importi predeterminati per legge (uguali per tutti i casi a parità di grado invalidante, con modestissime variazioni annuali ISTAT): una forma di solidarietà che lascia fuori voci di danno come il pieno ristoro del dolore sofferto, le perdite di reddito o altre conseguenze individuali. Proprio per questo la legge non esclude che, parallelamente all’indennizzo, il danneggiato possa intraprendere un’azione civile per ottenere dagli eventuali responsabili il risarcimento del danno completo. Indennizzo e risarcimento sono tutele diverse e cumulabili entro certi limiti: si può chiedere l’indennizzo allo Stato senza rinunciare a fare causa a chi ha causato il danno, fermo restando che quanto ricevuto come indennizzo potrà essere sottratto da alcune voci risarcitorie, per evitare duplicazioni. Sul punto, la Cassazione ha precisato che lo scomputo dell’indennizzo è ammesso solo rispetto al risarcimento per gli stessi effetti permanenti già coperti dal vitalizio statale, e solo se l’indennizzo è stato effettivamente ottenuto. Ad esempio, con Cass. civ., ord. n. 4415/2024 è stato chiarito che l’indennizzo ex lege 210/92 va eventualmente detratto dal risarcimento per invalidità permanente, ma non da quello per invalidità temporanea (poiché l’indennizzo è correlato solo alle menomazioni permanenti, mentre il danno temporaneo è distinto). Ancora più nettamente, Cass. civ., ord. n. 15963/2025 ha stabilito che se il danneggiato non ha concretamente ricevuto alcun indennizzo – ad esempio perché ne aveva diritto ma non lo ha richiesto in tempo ed è decaduto – allora nulla può essere detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto: non si può penalizzare la vittima per non aver usufruito di un beneficio amministrativo, soprattutto se la sua omissione non ha causato aggravamenti del danno ma è dipesa magari dalla mancata consapevolezza iniziale dei propri diritti. In sostanza, il sistema attuale garantisce che chi subisce un danno da vaccino possa ottenere almeno l’indennizzo statale e, quando il pregiudizio è grave, possa ambire anche a un risarcimento civilistico più ampio, senza eccessivi ostacoli procedurali.
Risarcimento integrale del danno: responsabilità civili e difetto del prodotto
Se l’indennizzo rappresenta una tutela automatica e “senza colpa”, il risarcimento civile mira invece a compensare integralmente tutti i danni subiti, ma presuppone di individuare una qualche responsabilità giuridica. In altre parole, chi ha riportato un grave danno da vaccino, oltre al sostegno pubblico forfettario, può valutare di agire in giudizio per ottenere il ristoro completo di ogni perdita (danno biologico permanente ed eventuali inabilità temporanee, sofferenza morale, danni patrimoniali come spese e mancato guadagno, ecc.). Questa strada, però, richiede di dimostrare che il danno sia addebitabile a un soggetto colpevole o a un prodotto difettoso. Nel contesto vaccinale, i possibili convenuti in una causa di risarcimento sono essenzialmente: il produttore del vaccino (la casa farmaceutica), il personale sanitario o la struttura che ha eseguito la vaccinazione (ad esempio per omissioni nelle procedure), oppure – in ipotesi più limitate – lo stesso Ministero della Salute o l’ASL, qualora si contesti un loro comportamento colposo specifico.
Va detto subito che l’esistenza dell’indennizzo pubblico non esonera i responsabili civili dal rispondere dei propri errori. Anzi, lo Stato ha previsto quell’indennizzo proprio per garantire un minimo ristoro anche quando non vi sia responsabilità di nessuno (ad esempio perché l’evento avverso è dovuto a un rischio imprevedibile). Ma se invece emerge che il danno poteva essere evitato con la dovuta diligenza – o che il vaccino presentava un vizio di sicurezza – allora il danneggiato ha pieno diritto di chiedere il risarcimento integrale in sede civile. Un classico esempio è la mancata acquisizione di un consenso informato: il medico che vaccina ha l’obbligo di informare adeguatamente il paziente sui rischi potenziali; se omette di farlo e si verifica un evento avverso, pur non essendoci “colpa medica” tecnica, si configura una violazione dei diritti del paziente che dà luogo a responsabilità civile. Ancora, se il vaccino aveva un difetto non noto che ha causato il danno, la casa produttrice ne può rispondere a titolo di responsabilità da prodotto difettoso. Oppure, se la reazione avversa grave era dovuta a una condizione particolare del paziente che sconsigliava la vaccinazione (controindicazione assoluta o relativa), l’aver proceduto ugualmente potrebbe costituire un errore del sanitario. Ogni vicenda ha le sue peculiarità: spetterà al legale esperto in materia valutare su quale fronte vi siano margini di successo, raccogliendo documentazione e perizie medico-legali.
Nel promuovere un’azione risarcitoria, è fondamentale inquadrare correttamente il titolo di responsabilità su cui si fonda la domanda, perché ciascun regime ha regole proprie. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che, in caso di danni da vaccino, non è consentito mescolare tra loro diversi regimi di responsabilità. In particolare, con la sentenza n. 8224/2025 (Sez. III civ.), la Suprema Corte ha annullato una decisione di merito in cui il produttore del vaccino antinfluenzale era stato ritenuto responsabile del danno pur in assenza di prova scientifica sul nesso causale, facendo leva su una combinazione impropria di normative. In quel caso un paziente aveva citato in giudizio la casa farmaceutica dopo aver subito una grave encefalite post-vaccinale. I giudici di primo e secondo grado avevano condannato il produttore applicando le norme sul prodotto difettoso (artt. 114 e segg. Codice del Consumo), sostenendo che il vaccino era da considerarsi difettoso per carenza di studi clinici aggiornati sugli effetti in soggetti anziani con certe patologie preesistenti – circostanza ritenuta indice di scarsa sicurezza. Allo stesso tempo, però, la Corte d’Appello aveva avallato una sorta di automatismo risarcitorio: una volta ravvisato questo “difetto” informativo, aveva ritenuto il produttore responsabile senza bisogno di ulteriore prova, richiamando il principio dell’onere della prova liberatoria in parte mutuato dall’art. 2050 c.c. (responsabilità per attività pericolose). La Cassazione ha censurato questo approccio “ibrido”, affermando che ogni regime di responsabilità ha i suoi presupposti specifici e non possono crearsi commistioni. Se si agisce nei confronti del produttore invocando il difetto del vaccino, occorre rispettare la disciplina ad hoc: il danneggiato deve provare il nesso causale tra vaccino e malattia e l’esistenza di un difetto di sicurezza del prodotto, mentre il produttore può andare esente da responsabilità dimostrando, ad esempio, che lo stato delle conoscenze scientifiche al momento dell’immissione in commercio non permetteva di prevedere quell’evento avverso (art. 118 del Codice del Consumo, c.d. “rischio da sviluppo”). Questa è una differenza cruciale rispetto alla responsabilità medica ordinaria o a quella per attività pericolose ex art. 2050 c.c.: nel caso dei prodotti farmaceutici, il legislatore europeo ha voluto bilanciare la tutela del consumatore con la necessità di non penalizzare oltremodo la ricerca, prevedendo appunto che il produttore non risponde di eventi dannosi scientificamente imprevedibili al tempo. D’altra parte, la Cassazione ha anche sottolineato che fornire un’adeguata informazione sui rischi noti è parte integrante del dovere di sicurezza del produttore: limitarsi a un generico bugiardino che avverte della possibilità di effetti avversi non sempre basta a esimere da responsabilità, se poi emerge che mancavano informazioni chiave per il paziente tipo (come rischi specifici per determinate categorie di soggetti). In sintesi, quando si intraprende una causa contro la casa farmaceutica è necessario impostare correttamente la domanda come responsabilità da prodotto difettoso, evitando scorciatoie giuridiche: il giudice dovrà accertare rigorosamente se esiste un difetto di progettazione o di informazione del vaccino che abbia reso la sua somministrazione ingiustamente pericolosa oltre le normali e legittime aspettative di sicurezza.
Se invece si profila un profilo di colpa sanitaria, il quadro normativo è differente. Le cause contro il medico vaccinatore o la struttura sanitaria rientrano nella responsabilità sanitaria disciplinata dalla legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) e dagli artt. 1218 e 2043 c.c. (a seconda che il rapporto sia contrattuale o meno). In tali casi il danneggiato dovrà dimostrare la negligenza o imperizia del sanitario (ad esempio la violazione di protocolli, la somministrazione nonostante controindicazioni evidenti, oppure l’uso di un lotto scaduto o conservato male, etc.), oltre al nesso causale tra l’errore e il danno. Va detto che episodi del genere, in ambito vaccinale, sono estremamente rari poiché i vaccini sono somministrati secondo procedure standardizzate e controlli rigorosi. Molto più frequente, come accennato, è il caso della carenza di consenso informato: una forma di responsabilità che attiene non alla tecnica medica in sé, ma al diritto del paziente di essere informato e poter scegliere consapevolmente.
Consenso informato: diritto all’autodeterminazione e risarcibilità
Ogni trattamento sanitario richiede, salvo situazioni d’urgenza, il consenso libero e informato del paziente. Questo principio di autodeterminazione vale anche in ambito vaccinale, seppure con adattamenti quando si tratta di vaccinazioni obbligatorie per legge (dove la libertà di scelta è limitata dal dovere imposto). Nel caso delle vaccinazioni facoltative, invece, il consenso informato riveste pienamente il suo ruolo centrale: il cittadino deve poter decidere se vaccinarsi valutando con cognizione di causa benefici e rischi. Fornire informazioni complete è quindi un obbligo preciso in capo ai sanitari e alle strutture.
Una vicenda esemplare è giunta all’attenzione della Suprema Corte e offre un importante chiarimento. Riguardava i genitori di un bambino che, dopo i vaccini dell’infanzia (in particolare un vaccino trivalente non obbligatorio), aveva sviluppato una grave patologia neuropsichiatrica (disturbo dello spettro autistico). In base alle evidenze scientifiche disponibili, non vi è nesso causale tra vaccinazione e autismo; infatti le corti di merito hanno escluso che il vaccino avesse provocato la malattia del minore. Tuttavia, durante il giudizio è emerso che l’ASL non aveva ottenuto dai genitori un consenso informato valido: non erano state fornite informazioni adeguate sui potenziali rischi, facendo venir meno la possibilità di una scelta realmente consapevole. La Corte d’Appello di Bari, pur negando il risarcimento per il danno alla salute (mancando il nesso causale), ha riconosciuto ai genitori un risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione, quantificato in via equitativa in 10.000 euro. Questo principio è stato confermato dalla Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28691/2024, divenuta subito un punto di riferimento: in assenza di un corretto consenso informato per una vaccinazione non obbligatoria, la struttura sanitaria può essere condannata a risarcire il danno non patrimoniale da violazione del diritto alla scelta. Si tratta di un danno distinto da quello biologico: anche se l’intervento non causa un pregiudizio alla salute, il fatto di aver subito un trattamento senza essere stati messi in condizione di decidere libera mente – magari rinunciandovi o rinviandolo – costituisce di per sé un’offesa alla dignità e libertà della persona, meritevole di ristoro in via civile. Questa giurisprudenza, maturata inizialmente in campo chirurgico e terapeutico, viene dunque estesa al contesto delle vaccinazioni volontarie: chi riceve un vaccino senza essere stato informato correttamente può chiedere il risarcimento del danno da consenso informato violato, a prescindere dall’esito clinico. È bene sottolineare che, nel caso di vaccino obbligatorio per legge, la situazione cambia: lì la facoltà di scelta del cittadino è compressa dall’obbligo normativo, e alcuni ritengono che l’assenza di informazioni non potrebbe comunque tradursi in una decisione diversa (dovendo il soggetto vaccinarsi per forza). Ciononostante, anche nelle vaccinazioni obbligatorie permane un dovere informativo – sia pure particolare – e la mancanza di un colloquio informativo potrebbe generare responsabilità in casi limite (ad esempio se avesse impedito al paziente di adottare cautele post-vaccino, o di prepararsi adeguatamente all’eventuale gestione degli effetti collaterali). In ogni caso, la regola generale è che il consenso informato va sempre acquisito in modo completo e documentato: per i vaccini facoltativi ciò influisce sulla libera scelta, per quelli obbligatori rappresenta comunque una buona pratica imprescindibile. Medici e operatori sanitari sono tenuti a fornire opuscoli, illustrare chiaramente benefici e rischi, lasciare il tempo necessario per decidere e rispondere a dubbi: in difetto, possono incorrere in responsabilità civile. Come ha osservato la Cassazione, va tenuta distinta la lesione del diritto alla salute (il danno biologico da complicanza, indennizzabile e risarcibile solo se c’è nesso causale) dalla lesione del diritto all’autodeterminazione (il danno da trattamento sanitario non consapevole, risarcibile di per sé). Entrambi i profili possono concorrere: ad esempio, se un vaccino causa un danno fisico e al contempo non era stato spiegato il relativo rischio, la vittima potrà ottenere sia l’indennizzo/rimborso per il danno biologico, sia una somma ulteriore per il pregiudizio da mancata informazione.
In definitiva, dall’analisi delle norme e delle più recenti pronunce emergono tutele rafforzate per i danneggiati da vaccino. Il messaggio che ne deriva è duplice: da un lato, chi subisce conseguenze avverse vaccinando si per il bene comune non viene abbandonato ma anzi vede riconosciuti maggiori diritti (più casi indennizzabili, tempi più equi, possibilità di azioni risarcitorie mirate); dall’altro, il sistema sanitario e i produttori di vaccini sono richiamati alle proprie responsabilità, dovendo garantire standard di sicurezza elevati e piena trasparenza verso i cittadini. Basti pensare che durante la pandemia da Covid-19 i tribunali hanno confermato sia la legittimità di misure rigorose – come la sospensione dal lavoro degli operatori sanitari che rifiutavano il vaccino, sancita ad esempio dalla Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 9243/2025 – sia la ferma volontà di tutelare chi, adempiendo al proprio dovere vaccinale, abbia riportato danni. In altre parole, il diritto cerca un equilibrio tra la salus populi suprema lex (la salute pubblica come legge suprema) e la salvaguardia dell’individuo: equilibrio che passa per l’indennizzo immediato e, se necessario, per il risarcimento completo in sede giudiziaria.

Redazione - Staff Studio Legale MP