

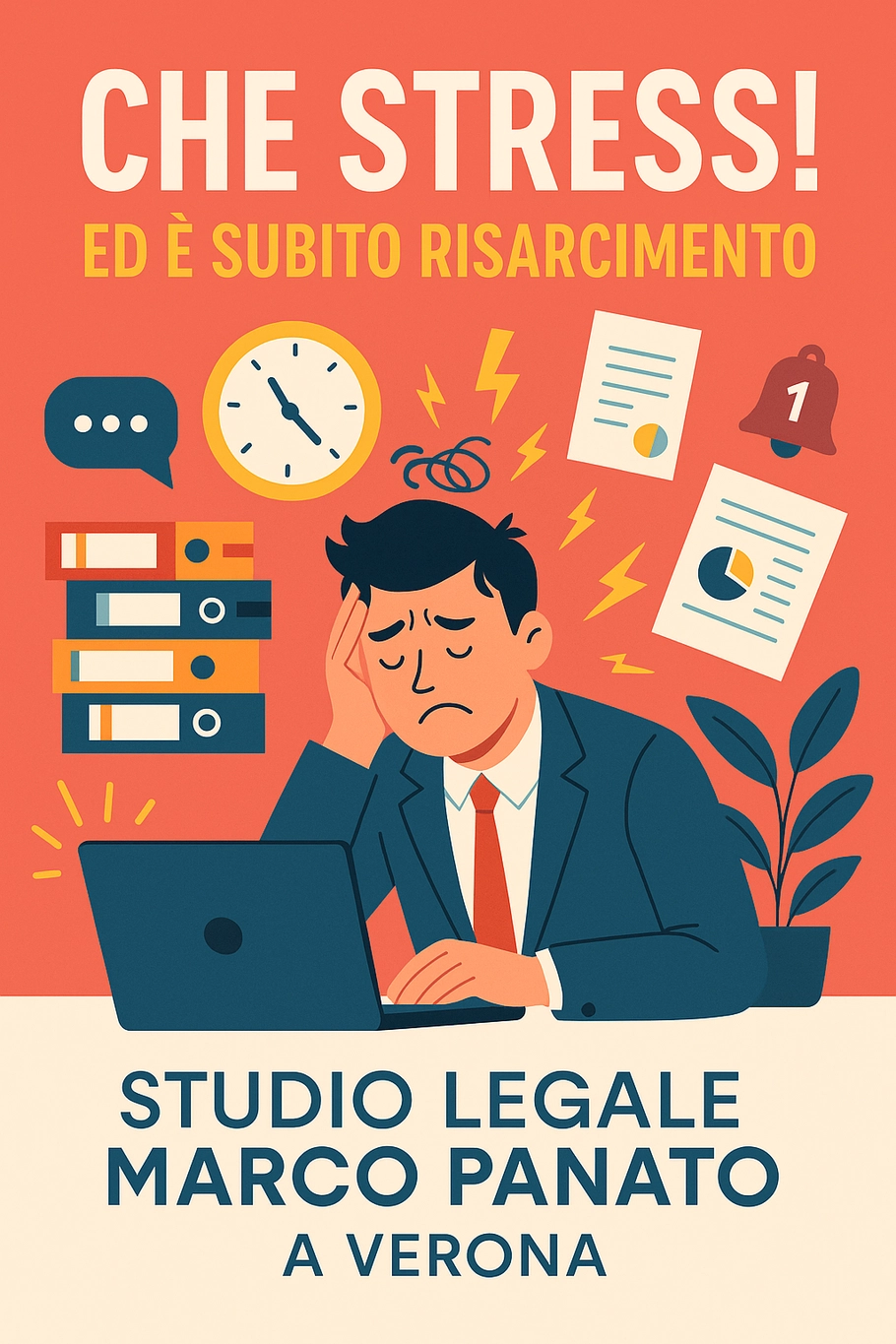
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 15957/2024) un ambiente di lavoro “stressogeno” rappresenta un “fatto ingiusto” che vulnera la sfera giuridica del lavoratore, cui spetta un diritto al risarcimento ex art. 2087 c.c.
"Il lavoro nobilita l'uomo" è un'antica bugia risalente quanto meno all'VIII o VII secolo a.C., quando il poeta greco Esiodo la scandì in uno dei suoi esametri. A propria parziale discolpa poteva invocare le Muse, le stesse che gli ispirarono un intero poema di deliri cosmogonici sull'origine dell'universo e degli dei: abituato com’era a scrivere dabbenaggini, non dovette curarsi troppo di aggiungerne un’altra alla collezione.
Il guaio è che questa ha conosciuto una gran fortuna, al punto che ancora oggi, mentre nessuno crede più alle diatribe tra Urano, Crono e Zeus, né si erigono templi in onore di questo o quel nume pagano, i più inorgogliscono della propria schiavitù stipendiata e a pieni polmoni declamano le parole di quell'oscuro poeta greco.
Nell'inconscio di questi esaltati del III millennio si annida sicuramente qualche intento consolatorio. Investire il proprio tempo - che non è solo il tempo dei calendari, ma è anche e soprattutto la propria vita, di fatti e di parole - nell'espletamento di questa o quella attività lavorativa, in cambio di quattro soldi che non compenseranno mai, neanche marginalmente, un solo secondo di quanto è stato sacrificato per essa - cioè la libertà di disporre di se stessi a proprio piacimento sempre, comunque e dovunque - è sufficientemente frustrante da spingere qualcuno ad addurre giustificazioni ideali di tanta follia. Di qui, il lavoro che “nobilita l'uomo" e le altre amenità che ci ronzano nelle orecchie.
Ora, saranno forse gli ardori giovanili e passionali di chi scrive ad annebbiargli la vista, ma ovunque egli si giri non vede persone che si nobilitano lavorando. Vede solo individui che più stanno al PC o al telefono o allo sportello o dietro a un bancone, a una scrivania, a una cattedra, im-brutiscono. Assumono cioè connotati lontanissimi da ogni profilo di umanità. Nervosi, nevrotici, nevrastenici, depressi, instabili, rintontiti, alienati, costoro sfilano per le vie del mondo come un corteo di zombie, dimentichi di se stessi, ignari della propria vita e del proprio intrinseco valore di uomini.
Il senso della loro presenza nel mondo, si direbbe, passa dal lavoro. Le passioni, gli affetti, i pensieri, le idee, il culto del "bello", il libero sfogo alle proprie autentiche propensioni, nella volgare logica materialistica secondo cui l'impiego o la professione sono l'unica misura possibile del valore, figurano quali mere suppellettili, accessori sempre sacrificabili sull'altare del feticcio "Lavoro". Che non è altro che una rinuncia a se stessi per derivare un apparente profitto in forma di danaro, che in realtà non vale neanche la millesima parte di quello che si è perso per guadagnarlo.
Non occorre sperticarsi in ardue argomentazioni per provare che, senza compenso o retribuzione, nessuno si dedicherebbe con lo stesso fervore (perlopiù auto-imposto e tutt'altro che spontaneo) alla propria attività. "Se si potessero guadagnare - scriveva George Orwell nel 1933 - dieci sterline alla settimana con l'assiduo accattonaggio, immediatamente l'accattonaggio diventerebbe una professione rispettabile" dato che "il denaro è diventato il banco di prova del valore". E ancora "I mendicanti non lavorano, si dice; ma poi che cos'è il lavoro? Lo sterratore lavora brandendo il piccone, il contabile lavora sommando cifre; il mendicante lavora stando in piedi all'aperto col bello e col cattivo tempo (...). È un mestiere come tutti gli altri; del tutto inutile, naturalmente, ma in fondo molti mestieri onorati sono del tutto inutili". E perché questa smania dell'inutile? "Credo che questo istinto di perpetuare il lavoro inutile sia, alla base, solo paura della massa. La massa è composta (si snoda il filo del pensiero) da spregevoli animali che, se avessero tempo a disposizione, sarebbero pericolosi; ad evitare rischi è meglio che siano sempre troppo occupati per pensare".
George Orwell ha dato voce ai pensieri sottesi a questo scritto: bene, bravo, bis!
Insomma, il lavoro è una iattura di per sé. Se qualcuno vi indulge ancora non è per nobilitarsi, ma solo per la tristissima e paradossale necessità dell'inutile. E proprio perché non è un bene ma un male già solo nella sua definizione astratta - ma pur sempre realista - è deleterio che in concreto si tollerino, ancora oggi, velate forme di abusi o di violenza, anche soltanto morale, sui posti di lavoro.
Il nostro Ordinamento giuridico, forgiato da quella sensibilità che nell'immediato dopoguerra portò alla stesura di una Costituzione improntata ai più alti principi di giustizia sociale, salvaguarda l'integrità psico-fisica del lavoratore non solo demandando alla contrattazione collettiva la disciplina puntuale dei più significativi aspetti del rapporto di lavoro, ma presidiandone l'inviolabilità con apposite norme, non prive di riflessi anche di diritto penale.
Tra queste rilevano quelle di contrasto al morboso fenomeno del "mobbing", inteso dalla giurisprudenza come una forma di conflittualità sistematica e persistente sul posto di lavoro, caratterizzata da comportamenti vessatori, ostili e persecutori, destinati a emarginare o escludere un lavoratore. Questi comportamenti, anche se non sempre illeciti singolarmente, sono ripetuti nel tempo e hanno come obiettivo la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore. Come si evince da una rapida scorsa della definizione della fattispecie "mobbing", i presupposti perché questa possa dirsi integrata sono tanti e difficili da provare. Sono infatti richiesti 1) una condotta sistematica e protratta nel tempo, 2) un intento persecutorio, 3) la lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, 4) il nesso causale tra la condotta mobbizzante e il danno patito dal lavoratore. Se ricorrono tutti i presupposti testè enumerati, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali subiti. Peraltro, la Cassazione ha riconosciuto che il mobbing possa talora integrare gli estremi del reato di cui all'art. 612 c.p.
Ora, quella del mobbing è sicuramente una fattispecie grave, giustamente sanzionata dall'ordinamento. Tuttavia, nell'arco casistico tra l'ottimale e regolare svolgimento del rapporto di lavoro e quello quasi estremo del mobbing, si annida una varietà di fattispecie che, pur non rientrando nella categoria "mobbing", ledono comunque la dignità del lavoratore, il suo benessere o qualsiasi altra sua posizione giuridica soggettiva. Al quale, conseguentemente, per ragioni di giustizia sostanziale e di equità, l'ordinamento deve necessariamente riconoscere una qualche forma di tutela.
Recentissimamente, la Cassazione ha aperto un nuovo fronte nella giuslavoristica rimediale, riconoscendo un diritto al risarcimento a tutti coloro che, pur non venendo mobbizzati, patiscono comunque delle lesioni alla propria sfera giuridica sul posto di lavoro.
Invero, con la sentenza n. 15957/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ambiente di lavoro "stressogeno" è configurabile come “un fatto ingiusto”, a fronte del quale il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno anche nelle ipotesi in cui, pur non potendosi ravvisare una condotta "mobbizzante", il clima lavorativo sia causa di una condizione di stress.
Il fondamento normativo richiamato dalla sentenza è l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro la tutela della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, cui si aggiunge la normativa internazionale in tema di salute dei lavoratori. Secondo quest'ultima, infatti, con "integrità fisica e personalità morale", si intende uno stato di "completo benessere fisco, mentale e sociale".
La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha davvero fornito tutela a moltissime fattispecie precedentemente relitte in uno spazio di anomia.
La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ha statuito che "un ambiente di lavoro stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorchè apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 cod. civ."
L' art. 2087 cod. civ., infatti, impone al datore di lavoro di tutelare la salute, fisica e psichica, dei lavoratori; conseguentemente è da ritenersi illegittimo il "comportamento del datore di lavoro che consente, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente 'stressogeno', fonte di danno alla salute dei lavoratori". Di qui, si configurerebbe una responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento, anche colposo, che si traduca in un danno alla salute del dipendente, costituendo un inadempimento datoriale già di per sé rilevante ai sensi dell'articolo 2087 с.с.
Le implicazioni della sentenza in esame sono tante, anche di rilievo gius-pubblicistico. Come espressamente riconosciuto dalla Corte, la pronuncia sottende un bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati: il diritto al lavoro fissato dall'art. 4; il diritto alla saluto cristallizzato nell'art. 32; la libertà di iniziativa economica del lavoratore privato ex art. 41.
In definitiva, gli Ermellini hanno vergato una pronuncia di cui si avvertiva il forte bisogno, anche a causa di un Legislatore intorpidito da sterili e anti-storiche contrapposizioni ideologiche, che mortificano, anziché vitalizzare, il parlamento.
La giurisprudenza, sempre più consapevole della sua rinnovata funzione storica, ha nuovamente risposto a esigenze concrete, a un fabbisogno rimediale non ulteriormente procrastinabile, supplendo alla colpevole inerzia del potere Legislativo. Tuttavia un corpus normativo che disciplini organicamente le responsabilità datoriali in tale ambito rimane auspicabile.
Per approfondire il tema della tutela risarcitoria per danni da stress sul lavoro e ricevere una consulenza legale qualificata, è possibile contattare lo Studio Legale Marco Panato a Verona, riferimento pronto a fornire assistenza personalizzata per la valutazione e la tutela dei propri diritti. Potete prendere un appuntamento telefonando direttamente allo studio o compilando l'apposito modulo di contatto presente sul sito web dello Studio, per ricevere una prima valutazione del vostro caso e le indicazioni utili a ottenere il risarcimento che vi spetta.

-