

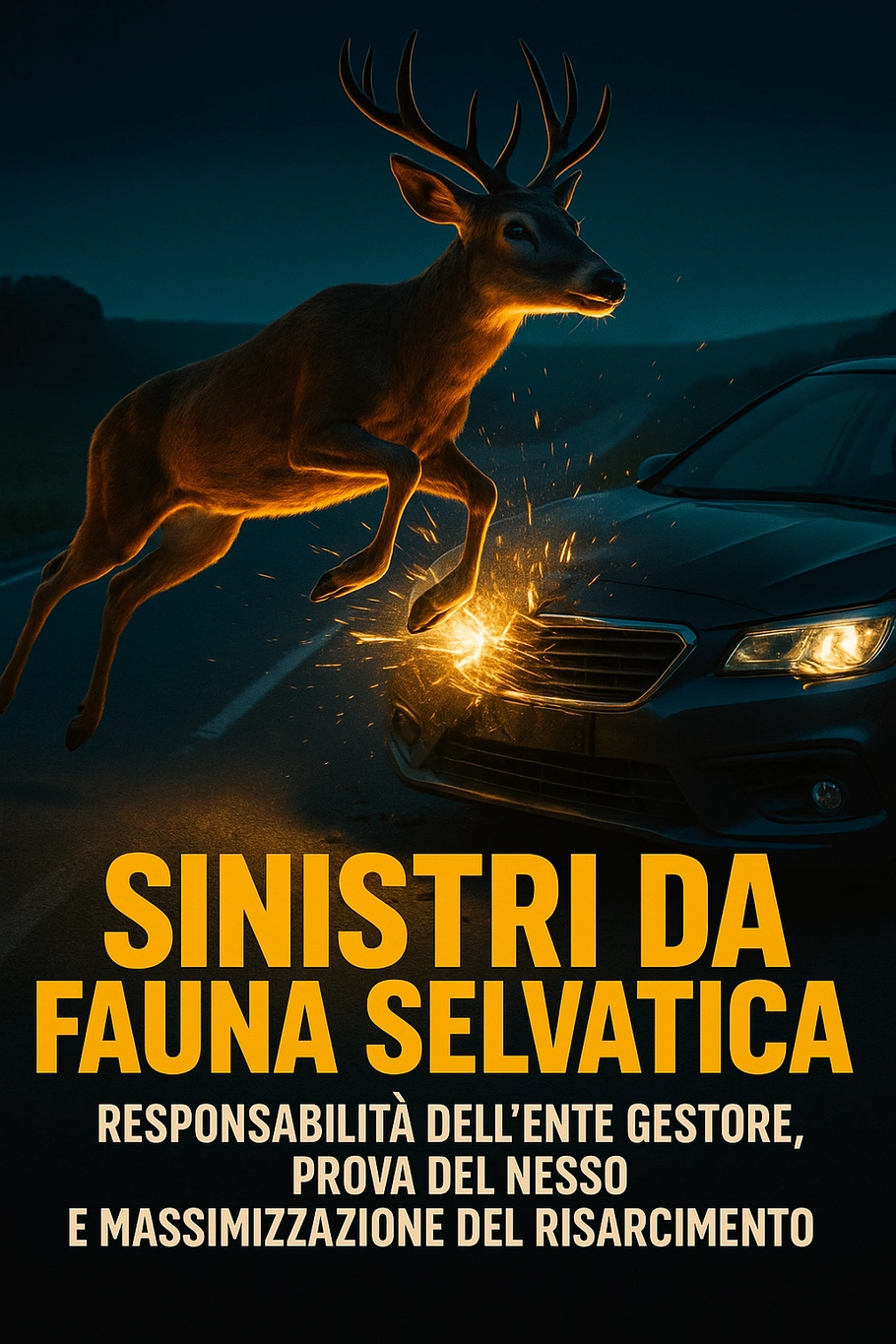
«Non v’è nulla di più imminente dell’impossibile, e se c’è una cosa che bisogna sempre prevedere, è l’imprevisto.» – Victor Hugo
Guidare di notte su una strada extraurbana del Veneto e vedersi balzare davanti un cinghiale o un capriolo è un’esperienza tanto imprevedibile quanto pericolosa. I sinistri stradali causati da animali selvatici sono in aumento e spesso comportano gravi danni: secondo l’Osservatorio ASAPS, in Italia dal 2012 al 2022 si sono verificati 1.736 incidenti con fauna selvatica, causando 151 morti e 1.961 feriti. In queste situazioni sorgono domande cruciali: chi è responsabile dei danni causati da un cervo o un cinghiale sulla carreggiata? Quali prove servono per dimostrare il nesso causale tra l’animale e l’incidente? E come massimizzare il risarcimento ottenibile, evitando che la vittima rimanga senza tutela? Di seguito esaminiamo il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato – con un occhio alle novità – e forniamo consigli pratici per affrontare al meglio questi eventi sfortunati.
In passato la giurisprudenza oscillava tra diverse soluzioni sulla responsabilità per gli incidenti con fauna selvatica. Fino a qualche anno fa prevaleva l’idea che tali danni fossero risarcibili solo provando la colpa di un ente pubblico ex art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana): ad esempio, la Cassazione nel 2017 escluse l’applicabilità della responsabilità per custodia di animali, ritenendo il caso inquadrabile solo in termini di colpa dell’ente a cui è affidata la gestione della fauna. In concreto, quindi, il danneggiato doveva citare l’ente (Regione, Provincia o altro) che non aveva adottato le dovute cautele (recinzioni, segnaletica, piani di contenimento) per prevenire l’attraversamento di animali, provando un comportamento omissivo che configurasse negligenza. Un esempio emblematico fu la vicenda di Torreglia (PD): un’automobilista investì un cinghiale nel 2011 nella zona dei Colli Euganei e in primo grado non ottenne nulla; solo in appello la Corte d’Appello di Venezia la risarcì, riconoscendo la responsabilità della Regione Veneto per non aver controllato l’eccessiva proliferazione di cinghiali nell’area (situazione di cui era a conoscenza dal 2010 senza aver preso misure).
Oggi, tuttavia, il quadro è cambiato grazie a interventi chiarificatori della Corte di Cassazione. Con una serie di pronunce recenti, la Cassazione ha stabilito che i danni causati da animali selvatici protetti (quelli appartenenti alla fauna tutelata dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157) vanno inquadrati sotto la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali). In altre parole, “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici […], va applicato il criterio di imputazione di cui all’art. 2052 c.c.” e il soggetto pubblico responsabile dev’essere individuato nella Regione competente. La fauna selvatica, infatti, è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato” affidato alla cura pubblica, e le Regioni – quali enti titolari delle funzioni normative e amministrative in materia faunistica – “si servono” del patrimonio faunistico nell’interesse collettivo (tutela dell’ambiente ed ecosistema). Dunque, la Regione svolge un ruolo assimilabile a quello di proprietario-custode degli animali selvatici, rispondendo dei danni che questi arrecano a terzi. Questo principio, affermato ad esempio dalla Cassazione civile Sez. III con sentenza n. 7969/2020 del 20 aprile 2020 (rel. Tatangelo) e confermato da successive pronunce (Cass. n. 8385/2020, Cass. n. 31038/2023, etc.), comporta che l’ente gestore della fauna – ossia la Regione – sia chiamato a rispondere automaticamente dei danni causati dalla fauna selvatica, salvo che provi il caso fortuito. Non è più necessario per il danneggiato dimostrare specifiche colpe dell’ente (come omissioni di recinzioni o simili); basta provare che il danno è stato cagionato dall’animale selvatico.
Va precisato che la legittimazione passiva in queste cause spetta in via esclusiva alla Regione, anche se la gestione operativa della fauna in quell’area è delegata a enti minori (Province, Enti parco, ecc.). La Regione potrà eventualmente rivalersi su tali enti dopo aver risarcito il danno, ma nei confronti del privato danneggiato rimane il debitore principale. Ad esempio, in una recente causa veneta il Tribunale di Rovigo (sent. n. 504/2022, Giud. Abiuso) ha condannato la Regione Veneto a risarcire un automobilista per uno scontro con un cinghiale avvenuto nel Padovano, confermando che l’ente parco locale o la Provincia (chiamati in causa) non rispondono direttamente verso il danneggiato. Similmente, il Tribunale di Belluno ha ribadito nel 2023 che la Regione è l’unico ente legittimato passivo nelle azioni risarcitorie per fauna selvatica.
E se l’incidente avviene in autostrada? In tal caso la giurisprudenza ha talvolta distinto la posizione: l’impatto con un animale su una strada statale o provinciale ricade sulla Regione, mentre se il sinistro si verifica in autostrada alcuni orientamenti chiamano in causa anche l’ente gestore dell’autostrada (es. la società concessionaria), in quanto tenuto a mantenere recinzioni e altre misure anti-intrusione. Quindi, per incidenti in autostrada può essere necessario rivolgere la richiesta di risarcimento sia alla Regione competente sia al gestore autostradale, valutando le specifiche circostanze (ad es. presenza o meno di varchi nelle recinzioni, ecc.). In generale, però, per le aree extraurbane venete la controparte principale è la Regione Veneto, responsabile della fauna sul suo territorio ai sensi della normativa vigente.
L’inquadramento del caso sotto l’art. 2052 c.c. non significa che il risarcimento sia automatico. Al contrario, in queste controversie si ha un “concorso di presunzioni”: da un lato opera la presunzione di responsabilità a carico del proprietario/utilizzatore dell’animale (la Regione, ex art. 2052), dall’altro permane la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (art. 2054, co. 1, c.c.). In pratica, entrambe le parti hanno un onere probatorio per superare la presunzione che le grava. Questo principio è stato chiarito di recente dalla Cassazione (ord. n. 9043/2025): “nell’ipotesi di scontro fra un veicolo e un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità […] comporta la pari efficacia di entrambe e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, […] il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato”.
Cosa deve provare dunque il danneggiato? Se il conducente dell’auto è anche il danneggiato che chiede il risarcimento, egli dovrà anzitutto provare il fatto e il nesso causale: in altre parole, dimostrare la dinamica del sinistro e che l’impatto col selvatico c’è stato realmente, causando i danni lamentati. È fondamentale raccogliere elementi che confermino la presenza dell’animale sulla strada e il contatto con il veicolo (ad es. fotografie dell’animale investito, verbali delle autorità intervenute, resti biologici sul veicolo, ecc.). Inoltre – ed è un aspetto cruciale – il conducente deve fornire prova di avere adottato una condotta di guida diligente e prudente, tale che l’attraversamento improvviso dell’animale sia risultato inevitabile anche usando la massima cautela. In sintesi, occorre dimostrare di non avere colpa nell’incidente: velocità nei limiti, attenzione alla strada, fari adeguatamente accesi, nessuna manovra errata. La Cassazione ha evidenziato che il danneggiato deve provare che il comportamento dell’animale è stato effettivamente imprevedibile e irrazionale, in modo che, nonostante ogni prudenza, evitare l’impatto fosse impossibile. Questo è il cuore del “nesso causale” in simili casi: l’animale selvatico deve aver agito come un fattore improvviso e inevitabile. Se vi erano, ad esempio, cartelli di “attraversamento fauna selvatica” e l’automobilista procedeva comunque a velocità sostenuta, potrebbe non superare la presunzione di colpa a suo carico, perché l’evento poteva essere in parte prevedibile. Come affermato dal Tribunale di Trieste (sent. n. 448/2023), per evitare la responsabilità il conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto, mentre “l’imprevedibilità ed irrazionalità del contegno dell’animale” ha reso vano ogni sforzo.
Parallelamente, sull’altro fronte, l’ente pubblico convenuto (Regione) potrà andare esente da responsabilità solo provando il caso fortuito. In termini pratici, la Regione deve dimostrare che la condotta dell’animale si è posta completamente al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo e prevenzione. Ciò implica provare, ad esempio, che l’evento è dipeso da una causa eccezionale non imputabile all’ente: ad esempio, l’animale potrebbe essere fuggito a causa di un comportamento imprevedibile di terzi (bracconieri che lo hanno spinto sulla strada, apertura intenzionale di cancelli, ecc.), oppure che l’incidente è avvenuto in un luogo e in un modo totalmente impossibile da prevenire anche con le misure più diligenti (Nemo tenetur ad impossibilia). Dimostrare il caso fortuito per la Regione è oneroso: deve provare che aveva attuato tutte le misure ragionevoli di gestione e tutela della fauna (piani di contenimento, recinzioni, segnaletica, vigilanza) e che nonostante ciò l’attraversamento è dipeso da un fattore imprevedibile e inevitabile. Se la Regione riesce in questa prova liberatoria, non sarà tenuta a risarcire. In caso contrario – e questa è la situazione più comune – la responsabilità resta in capo alla Regione ex art. 2052 c.c.
È importante comprendere che, se nessuna delle parti riesce a superare la presunzione a proprio carico, si può configurare una sorta di concorso: il conducente rimane presunto colpevole ex art. 2054 c.c. e la Regione rimane oggettivamente responsabile ex art. 2052 c.c. In tale scenario, paradossalmente, entrambi risultano responsabili. Sul piano pratico, ciò può tradursi nella riduzione del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.): ad esempio, il giudice potrebbe riconoscere solo una percentuale dei danni se ritiene che l’automobilista non abbia dimostrato sufficiente prudenza. Inoltre, vi è il rischio che l’automobilista venga chiamato a rispondere dei danni riportati dall’animale stesso: uccidere un animale protetto può far sorgere, in teoria, un obbligo risarcitorio verso l’ente pubblico proprietario (oltre alle sanzioni amministrative previste in alcuni casi per la mancata denuncia di investimento di fauna). Non a caso, uno studio osserva che “il conducente sprovvisto di un saldo impianto probatorio non solo non otterrà il risarcimento, ma molto probabilmente sarà anche condannato a risarcire i danni inferti all’animale”. In definitiva, è essenziale per il danneggiato vincere la presunzione di colpa a suo carico, altrimenti il sinistro rientrerà nel novero di ciò che i giuristi chiamano “damnum sine iniuria” – un danno senza colpa giuridica altrui, che purtroppo resta a carico di chi lo subisce.
Affrontare le conseguenze di un urto con un cinghiale o un capriolo richiede non solo sangue freddo nell’immediato, ma anche attenzione a raccogliere tutte le prove utili e a seguire le procedure giuste per massimizzare il risarcimento. Ecco alcuni consigli chiave:
Allertare subito le autorità: È fondamentale chiamare le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia locale, Polstrada) sul luogo dell’incidente. Il loro intervento consentirà di stilare un verbale ufficiale che documenti la presenza dell’animale selvatico e la dinamica del sinistro. Questo documento sarà una prova determinante del nesso causale. Inoltre, avvisare anche il servizio veterinario ASL o i Forestali può essere utile, soprattutto se l’animale è ferito vivo o se si tratta di specie protetta, per gestire la fauna e ottenere ulteriore certificazione dell’evento.
Raccogliere evidenze sul posto: Se le condizioni lo permettono, scattare fotografie della scena (posizione del veicolo, dell’animale morto o ferito, eventuali tracce di sangue o peli sull’auto, segni di frenata) e annotare l’ora e il luogo preciso. Se vi sono testimoni oculari, è importante prendere i loro contatti (nome, telefono) affinché possano confermare in seguito l’accaduto. Ogni dettaglio può rivelarsi prezioso per corroborare la vostra versione dei fatti.
Non spostare immediatamente il veicolo o l’animale, se possibile, finché non arrivano le autorità: la posizione finale dopo l’impatto può fornire indicazioni utili. Ovviamente, bisogna comunque mettere in sicurezza la circolazione (azionare le quattro frecce, posizionare il triangolo di emergenza) ed evitare rischi ulteriori.
Documentare i danni e le spese: Conservate tutte le fatture e ricevute delle spese conseguenti: costi di riparazione dell’auto, spese di traino o carro attrezzi, eventuale noleggio di un’auto sostitutiva durante il fermo tecnico, ricevute per cure mediche se ci sono lesioni (esami, farmaci, fisioterapia). Questi importi potranno essere chiesti in risarcimento. Anche il danno da fermo tecnico (il disagio per l’indisponibilità del mezzo durante le riparazioni) è riconosciuto in giurisprudenza e va provato magari tramite ricevute di noleggio o uso di taxi.
Denunciare il sinistro alla propria assicurazione: Anche se l’RCA standard di norma non copre i danni al proprio veicolo da collisione con animali selvatici, è bene informare subito la compagnia assicurativa dell’evento. In alcuni casi, la polizza può includere garanzie accessorie specifiche (evento naturali/animali) che indennizzano questi danni. Inoltre, la compagnia potrebbe offrire assistenza nella gestione del recupero danni verso terzi. Attenzione: se l’assicurazione copre il danno (perché avevate ad esempio la polizza Kasko fauna), questa subentrerà nei vostri diritti verso l’ente pubblico (surroga) – ma l’importante è che voi riceviate il rimborso dovuto.
Presentare richiesta di risarcimento alla Regione: In Veneto esiste una procedura amministrativa dedicata. La Regione Veneto ha predisposto un modulo ufficiale per la denuncia di sinistro con fauna selvatica (approvato con D.G.R. n. 1443/2017). Il modulo va compilato con i dati dell’incidente e inviato agli uffici regionali competenti (di norma, all’Unità Organizzativa Caccia e Pesca) entro i termini indicati, allegando copia del verbale delle autorità, preventivi o fatture dei danni e ogni altra prova utile. La Regione trasmetterà poi la richiesta alla propria compagnia assicuratrice per la valutazione. Seguire questa procedura può portare, nei casi riconosciuti, a un risarcimento in via stragiudiziale, evitando i tempi di una causa. Tuttavia, se la Regione (o il suo assicuratore) nega il pagamento – ad esempio contestando il nesso causale o adducendo il caso fortuito – allora sarà necessario intraprendere una azione legale in sede civile.
Valutare l’assistenza di un legale esperto: Data la complessità di questi casi (pericolosi intrecci di presunzioni e prove), è altamente consigliabile farsi seguire da un avvocato esperto in infortunistica stradale e diritto degli enti pubblici. Un professionista potrà aiutarvi a impostare correttamente le richieste risarcitorie, quantificare tutti i danni risarcibili (anche quelli meno evidenti come il danno non patrimoniale da eventuale trauma fisico o psichico subìto nell’incidente) e contrastare efficacemente le eccezioni dell’ente pubblico in causa. Spesso, solo con un’adeguata strategia legale è possibile ottenere il pieno risarcimento dovuto, soprattutto quando l’ente tenta di scaricare la colpa sul conducente. Ricordiamo che, qualora la causa si concluda positivamente, il soccombente (Regione) sarà di regola condannato a rimborsare anche le spese legali sostenute dal danneggiato.
In sede di giudizio, per massimizzare il risarcimento, il danneggiato dovrà chiedere tutte le voci di danno pertinenti, tra cui: il danno materiale al veicolo (costo di riparazione o valore di mercato se distrutto), il danno da fermo tecnico (giorni di inutilizzo del mezzo), i danni alla persona (lesioni fisiche al conducente e passeggeri, con relativo danno biologico, spese mediche, ecc.), l’eventuale danno morale o da spavento (se l’evento ha causato shock emotivo significativo) e qualsiasi altra perdita documentabile (ad es. perdita di occasioni lavorative, se dimostrabile). La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza del 2023, ha sottolineato che persino i danni riportati dall’animale possono essere oggetto di rivalsa: ad esempio, se un animale d’allevamento viene investito, l’allevatore proprietario può chiedere i danni al conducente salvo prova liberatoria di quest’ultimo. Nel caso degli animali selvatici protetti, il “proprietario” è la collettività rappresentata dalla Regione: ciò significa che, a rigore, la Regione potrebbe contropretendere il valore dell’animale selvatico ucciso, ma in pratica questo accade raramente e solo se vi è una conclamata colpa grave del conducente (ad esempio un investimento volontario o per guida in stato di ebbrezza). In tutti i casi, la parola d’ordine è documentare e quantificare: ogni euro speso o perso a causa dell’incidente dovrebbe trovare spazio nella domanda risarcitoria.
I sinistri causati da fauna selvatica nelle aree extraurbane – un tempo liquidati un po’ fatalisticamente come eventi sfortunati senza colpevoli – oggi vengono affrontati con maggiore tutela per le vittime, grazie all’evoluzione normativa e giurisprudenziale. La Regione, quale ente gestore della fauna, può essere chiamata a rispondere in modo oggettivo dei danni subìti dagli automobilisti: “dura lex, sed lex”, verrebbe da dire, anche se ciò sprona le amministrazioni pubbliche a prevenire meglio il fenomeno (con recinzioni, attraversatoi faunistici, piani di contenimento delle specie in sovrannumero). Al tempo stesso, però, il conducente non è sollevato dai propri doveri: la diligenza di guida rimane essenziale e va dimostrata, pena la perdita del diritto al risarcimento. Come abbiamo visto, serve un delicato equilibrio probatorio: chi ha subìto il danno deve preparare con cura la propria “difesa” per vincere la presunzione di colpa, mentre l’ente per andare esente deve provare l’imponderabile.
In ultima analisi, se vi trovate coinvolti in un incidente con un animale selvatico, non scoraggiatevi: sappiate che la legge vi offre strumenti per essere risarciti, ma dovrete attivarvi tempestivamente e con precisione. Prevedere l’imprevisto non è facile – “non è in potestà degli uomini né prevederlo né schivarlo”, scriveva saggiamente Guicciardini – tuttavia, con la giusta preparazione e assistenza, è possibile far valere le proprie ragioni. Ogni caso va valutato “in concreto”, ma l’importante è non rinunciare a far valere i propri diritti. La strada verso il risarcimento c’è, tracciata dalla normativa e dalle sentenze più recenti: percorrerla con determinazione può portarvi a ottenere giustizia per il vostro sinistro con fauna selvatica.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.