

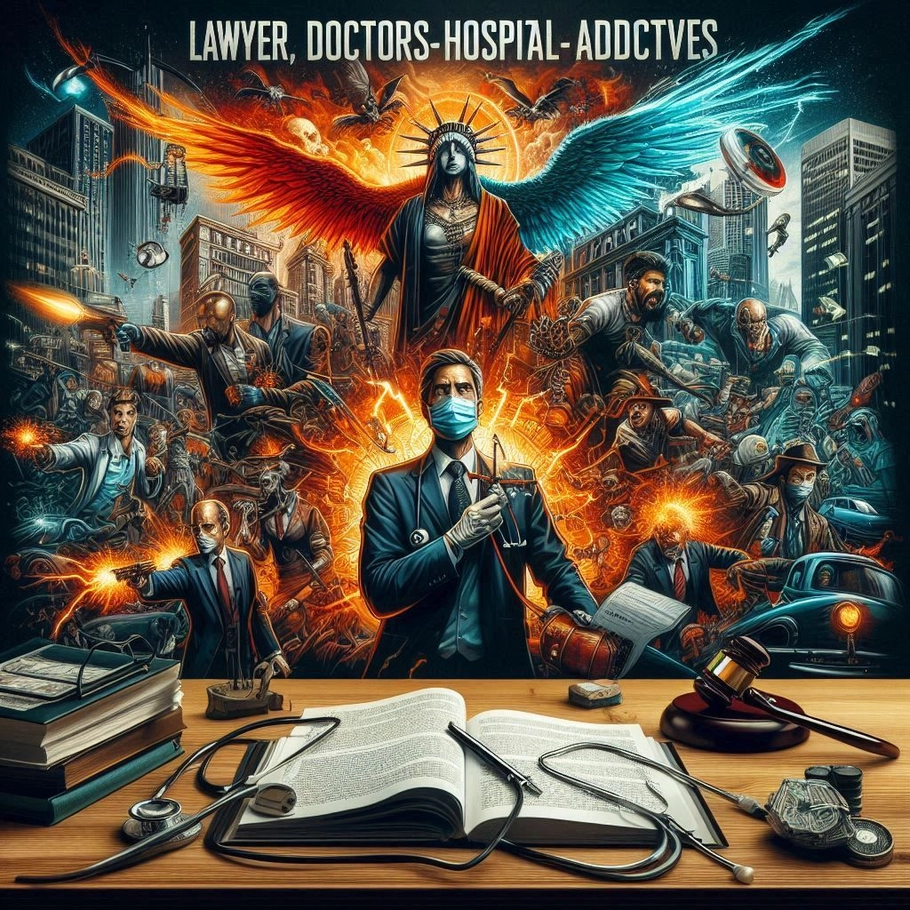
Una diagnosi medica arrivata troppo tardi può avere conseguenze gravi. In questo articolo spieghiamo come tutelarsi legalmente di fronte a una diagnosi tardiva – ad esempio nel caso di un tumore individuato in ritardo – e perché è fondamentale muoversi immediatamente per ottenere il risarcimento del danno. Scopriremo i termini di prescrizione entro cui agire, come viene valutato il danno biologico (anche in termini di perdita di chance), il ruolo del consenso informato e dell’onere della prova, e quali documenti raccogliere sin dal primo colloquio con l’avvocato.
Negli ultimi anni i casi di diagnosi tardiva (specialmente di patologie gravi o croniche) hanno ricevuto crescente attenzione. Sempre più pazienti e familiari cercano sul web frasi come “risarcimento diagnosi tardiva” o “diagnosi ritardata tumore avvocato”, segno di una maggiore consapevolezza dei propri diritti. Questo interesse riflette una realtà preoccupante: scoprire una malattia in ritardo spesso comporta trattamenti più invasivi, minori probabilità di guarigione e, nei casi peggiori, esiti fatali che potevano forse essere evitati o posticipati. Primum non nocere – “innanzitutto, non nuocere” – recita un antico principio latino della medicina; eppure, quando un medico manca di diagnosticare tempestivamente una patologia, quel principio viene tradito e il paziente subisce un danno. Vediamo dunque come ottenere giustizia in queste situazioni, ricordando che – parafrasando Montesquieu – giustizia ritardata è giustizia negata. Agire subito non è solo cruciale: è parte integrante del diritto alla salute e alla dignità della persona.
Una diagnosi tardiva si verifica quando una malattia non viene riconosciuta nei tempi adeguati per avviare le cure opportune. In pratica, il medico (o la struttura sanitaria) ritarda nel formulare la diagnosi corretta, e questo ritardo fa sì che la patologia progredisca indisturbata. Esempi tipici sono un tumore maligno scambiato inizialmente per disturbo benigno, oppure risultati di esami critici ignorati o comunicati troppo tardi. Questi errori possono comportare un aggravamento delle condizioni del paziente, la necessità di terapie più aggressive o meno efficaci, fino a incidere sulle stesse chance di sopravvivenza.
Dal punto di vista legale, la diagnosi tardiva è considerata un errore medico e rientra nella cosiddetta malasanità. Il paziente danneggiato ha diritto a chiedere un risarcimento danni, che può comprendere sia danni patrimoniali (perdita di reddito, spese mediche aggiuntive, costi di assistenza, ecc.) sia danni non patrimoniali (il danno biologico per la lesione alla salute, il danno morale per la sofferenza interiore, ed eventualmente il danno esistenziale). Ad esempio, se a causa del ritardo diagnostico la malattia richiede interventi più invasivi, il responsabile può dover rimborsare le spese mediche extra e risarcire la perdita di chance lavorative del paziente. Allo stesso modo, il peggioramento della salute causato dall’errore dà luogo a un danno biologico risarcibile, cioè la diminuzione permanente o temporanea dell’integrità psicofisica della persona. In sintesi, un errore diagnostico può dare diritto a un rimborso complessivo per tutte le conseguenze negative subite dal paziente (risarcimento del danno in senso tecnico).
È importante sottolineare che non tutti i ritardi diagnostici configurano automaticamente una responsabilità: occorre dimostrare che il medico abbia violato la “lex artis” – ovvero le regole della buona pratica clinica – non riconoscendo la malattia dove un professionista diligente l’avrebbe individuata, oppure omettendo di prescrivere esami e approfondimenti necessari. Ad esempio, ignorare sintomi evidenti o trascurare i risultati di un test cruciale può costituire negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario. In casi complessi, solo una perizia medico-legale potrà chiarire se vi sia stato errore o se, pur con tutto l’impegno, la diagnosi sarebbe comunque risultata difficile. Tuttavia, quando l’errore c’è ed ha provocato un danno, il paziente ha diritto ad essere risarcito.
Di fronte a un sospetto caso di malasanità diagnostica, il tempo è un fattore decisivo. Da un lato, per ottenere giustizia occorre raccogliere prove e testimonianze il prima possibile (le cartelle cliniche vanno richieste subito, i ricordi dei fatti sono più precisi a ridosso degli eventi, ecc.). Dall’altro lato, esistono precisi termini di prescrizione da rispettare: trascorso un certo numero di anni, non sarà più legalmente possibile far valere il proprio diritto al risarcimento.
In ambito civile, l’azione di risarcimento per errore medico si prescrive generalmente in 10 anni se si configura una responsabilità contrattuale (tipicamente quella della struttura sanitaria con cui il paziente ha un “contratto” di cura, anche solo implicito), oppure in 5 anni se si procede per responsabilità extracontrattuale (ad esempio nei confronti del medico libero professionista). Si tratta dei termini ordinari previsti dal codice civile (art. 2946 c.c. per le obbligazioni contrattuali e art. 2947 c.c. per il fatto illecito). In concreto, una diagnosi tardiva rientra quasi sempre nella responsabilità medica sanitaria: spesso il paziente agisce verso l’ospedale o la ASL (responsabilità contrattuale, 10 anni) e/o direttamente verso il medico che ha sbagliato (la cui responsabilità, specie dopo la Legge Gelli-Bianco n.24/2017, può essere inquadrata come extracontrattuale, 5 anni). È fondamentale valutare con l’avvocato come impostare la causa, ma in ogni caso conviene attivarsi ben prima della scadenza di questi termini. Anche fonti divulgative confermano che il termine decennale si applica ai casi di malpractice sanitaria contrattuale, ma è prudente muoversi tempestivamente e non aspettare l’ultimo momento. Come sottolinea un legale esperto, “È essenziale agire presto” in queste situazioni.
Vale la pena ricordare che il “decorso” della prescrizione inizia dal momento in cui il danneggiato ha consapevolezza del danno e della sua causa. Nel caso di diagnosi tardiva, spesso il paziente ne prende coscienza solo quando scopre la vera malattia e realizza che una diagnosi precedente era mancata: da quel momento (scoperta dell’errore) si calcolano i 5 o 10 anni. Tuttavia, sono questioni giuridiche complesse da non lasciare al caso: ecco perché agire subito consultando un avvocato è doppiamente cruciale, sia per non rischiare la prescrizione, sia per massimizzare le possibilità di successo. Del resto, come ammoniva lo stesso Montesquieu, “Giustizia ritardata è giustizia negata” – un monito che calza a pennello per chi ha subìto un grave errore sanitario.
Uno degli aspetti più delicati nelle cause da diagnosi tardiva è la quantificazione del danno. Non si tratta solo di conteggiare ricevute e fatture (danno patrimoniale), ma soprattutto di valutare in termini medico-legali l’impatto sulla salute e sulla vita del paziente. In particolare, entra in gioco il concetto di perdita di chance: cioè la perdita di possibilità di guarigione o di un esito migliore a causa del ritardo diagnostico.
Facciamo un esempio concreto: un tumore che, se identificato subito, avrebbe avuto il 70% di probabilità di guarigione, viene scoperto tardi quando le chance di cura sono solo del 20%. Il paziente purtroppo non sopravvive alla malattia. In questo scenario, non si può dire con certezza che senza ritardo si sarebbe salvato; tuttavia, è altamente probabile che avrebbe avuto un esito migliore. La chance di sopravvivenza – pari a quel potenziale 50% di probabilità in più – è stata negata dall’errore medico. Come si risarcisce questo tipo di danno? La giurisprudenza ci offre dei criteri: anzitutto, bisogna separare due piani, quello del nesso causale e quello dell’evento di danno. In altre parole, occorre distinguere l’incertezza sul risultato (guarigione o meno) dall’accertamento della responsabilità. La Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare se il comportamento dei medici abbia “più probabilmente che non” causato la perdita di quella possibilità di guarigione o di migliore esito. Non si chiede al paziente di provare che sarebbe guarito sicuramente (cosa impossibile), ma di dimostrare – anche attraverso una perizia – che il ritardo ha ridotto le sue probabilità di sopravvivenza in modo significativo. Se è più probabile che sì (ossia >50%) che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato o attenuato il danno, il nesso causale è giuridicamente riconosciuto.
Definito il nesso, si passa alla quantificazione. Qui la percentuale di chance perduta diventa rilevante: seguendo l’esempio, aver perso una chance del 50% di guarire potrà tradursi in un risarcimento pari al 50% del valore che si riconoscerebbe per la perdita totale della vita (danno da morte). In pratica, la “chance” viene trattata come un bene autonomo: non è il mancato conseguimento della guarigione in sé (che purtroppo non era garantita), ma la perdita di una possibilità concreta che il paziente già aveva prima che la negligenza gliela sottraesse. Tale chance perduta, misurata in termini percentuali o probabilistici, rileva ai fini della liquidazione equitativa del danno: più era elevata la probabilità di un esito favorevole in caso di diagnosi corretta, maggiore sarà il risarcimento dovuto. La logica è compensare il paziente (o i familiari, se la persona è deceduta) per quella parte di vita in più o di qualità di vita migliore che avrebbe ragionevolmente potuto avere.
Va detto che in sede di giudizio spesso vengono utilizzati strumenti tecnici come le tabelle medico-legali (ad esempio le Tabelle di Milano o di Roma per il danno biologico) per attribuire un valore economico ai punti percentuali di invalidità o alle aspettative di vita perdute. Inoltre, il giudice può avvalersi della consulenza di un medico legale per stimare, sulla base di dati statistici e scientifici, quale fosse la prognosi con e senza errore. È una vera e propria valutazione probabilistica del danno, che tiene conto sia dell’aspetto quantitativo (anni di vita persi, aggravamento dell’invalidità, ecc.) sia qualitativo (sofferenze aggiuntive, terapie più gravose, ecc.).
Importante: non sempre si parla di perdita di chance di guarigione. Ci sono casi in cui la malattia era talmente aggressiva che, in tutta sincerità, nemmeno una diagnosi tempestiva avrebbe cambiato il destino finale (la guarigione era impossibile). In queste situazioni, la giurisprudenza insegna che il danno risarcibile assume un’altra forma: non la chance di guarire, ma la lesione del diritto del paziente all’autodeterminazione sul finale della propria vita. Approfondiamo questo aspetto nel paragrafo seguente, poiché tocca il ruolo del consenso informato e un tipo particolare di danno non patrimoniale.
Ogni paziente ha il diritto fondamentale di essere informato sulle proprie condizioni di salute e di decidere consapevolmente quali trattamenti accettare o rifiutare. Questo principio – sancito anche dalla legge italiana (L. 219/2017 sul consenso informato e le DAT) – rientra nella sfera della libertà di autodeterminazione in materia sanitaria. Ma cosa accade se, a causa di una diagnosi sbagliata o tardiva, il paziente non sa neppure di essere malato fino a quando è troppo tardi? In tal caso non ha avuto la possibilità di compiere nessuna scelta riguardo alle cure o alle ultime fasi della sua vita. Si tratta di una violazione gravissima del suo diritto all’autodeterminazione, che costituisce di per sé un danno risarcibile, distinto dalla perdita di chance di tipo “curativo”.
Pensiamo a una situazione purtroppo non rara: al paziente viene diagnosticata una patologia terminale (esito certamente infausto) solo in fase avanzata, quando ormai le terapie possono fare ben poco se non alleviare i sintomi. Se quella diagnosi tempestiva fosse stata fatta mesi prima, forse non avrebbe cambiato la prognosi finale (la malattia era incurabile), però il paziente avrebbe potuto affrontare diversamente il tempo che gli restava da vivere. È un aspetto che attiene alla dignità della persona e alla libertà di scegliere “come” vivere (e morire) di fronte a una malattia terminale. La Corte di Cassazione ha affrontato direttamente questo tema in più pronunce recenti, chiarendo che nei casi di ritardata diagnosi di patologie sicuramente mortali, il danno subito dal paziente non coincide con la perdita della chance di guarigione, bensì con la lesione del diritto di autodeterminarsi liberamente nelle scelte sul periodo finale della propria vita. In altre parole, il torto è aver privato il malato della possibilità di decidere se intraprendere subito cure (anche solo palliative), organizzare i propri affari personali, prepararsi spiritualmente, oppure semplicemente vivere in modo pienamente consapevole gli ultimi mesi.
Questa violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente terminale è stata riconosciuta come un danno non patrimoniale autonomo dalla Suprema Corte. Già un’ordinanza del 2018 (Cass. Civ. n. 7260/2018) e poi altre sentenze di merito hanno affermato che il ritardo colpevole nella diagnosi, in tali contesti, lede un bene giuridico “certo” del paziente: la libertà di disporre di sé in una condizione estrema. Una volta accertato che vi è stata un’omissione diagnostica colpevole su una malattia inguaribile, non serve nemmeno provare ulteriormente quali scelte specifiche il paziente avrebbe fatto (ogni individuo potrebbe preferire percorsi diversi): basta il fatto in sé che gli è stato impedito di scegliere, per configurare il danno. Di conseguenza, i giudici hanno stabilito che questo danno va risarcito in via equitativa. Ciò significa che spetterà al tribunale liquidare una somma ragionevole a titolo di risarcimento, valutando tutte le circostanze del caso (età del paziente, durata del periodo “negato” alla consapevolezza, sofferenza psicologica correlata, ecc.).
Si tratta, come si vede, di concetti che sconfinano dall’ambito strettamente medico per abbracciare principi etici e costituzionali: il rispetto della persona e del suo percorso esistenziale. Una diagnosi comunicata tardi può equivalere a un difetto di informazione verso il paziente, e quindi a un vizio nel consenso informato: se il malato non sa di cosa soffre, non può né acconsentire né dissentire su cure e assistenza. Di nuovo, la legge 219/2017 ha rafforzato l’obbligo del medico di informare in modo completo e comprensibile il paziente su diagnosi, prognosi e opzioni terapeutiche; il mancato rispetto di tale obbligo può comportare responsabilità. In giudizio, pertanto, si può chiedere il risarcimento anche per la lesione del diritto all’informazione e all’autodeterminazione, oltre che per il danno biologico in senso stretto. Questa componente spesso si manifesta come danno morale ed esistenziale: l’angoscia di chi scopre improvvisamente di essere in fin di vita senza aver avuto modo di prepararsi, o il rammarico dei familiari nel sapere che il loro caro “non ha potuto scegliere” fino in fondo. I tribunali italiani hanno riconosciuto tale voce di danno, condannando le strutture sanitarie a risarcire proprio in considerazione di questa violazione della libertà personale. Si pensi che in un caso la Cassazione ha parlato esplicitamente di risarcire la perdita del diritto all’autodeterminazione sul fine-vita del paziente.
In sintesi, il consenso informato non riguarda solo la firma di un modulo prima di un intervento chirurgico: è un principio più ampio, che impone al medico di mettere il paziente nelle condizioni di sapere e decidere. Quando una diagnosi viene omessa o ritardata per errore, questo diritto può essere calpestato. Fortunatamente, la giustizia può intervenire a posteriori con un risarcimento, che pur non restituendo il tempo perduto, rappresenta un riconoscimento concreto del torto subito.
Nel promuovere una causa di risarcimento per diagnosi tardiva, ci si chiede spesso: su chi ricade l’onere della prova? In altre parole, chi deve provare cosa, davanti al giudice, per vincere la causa?
La regola generale nel diritto civile italiano è “actori incumbit probatio” – spetta a chi agisce (attore) provare i fatti su cui si fonda la sua domanda. Nel nostro caso, quindi, il paziente (o i familiari) che chiedono il risarcimento dovranno provare: 1) l’esistenza di un danno alla salute (peggioramento, aggravamento, esito nefasto, ecc.); 2) una condotta colpevole del medico o dell’ospedale (l’errore diagnostico, l’omissione di controlli, etc.); 3) il nesso causale fra quella condotta e il danno (ossia che il ritardo nella diagnosi ha contribuito in modo determinante a causare l’esito negativo). Questa prova in giudizio si basa in larga parte su documentazione medica e consulenze tecniche: è fondamentale presentare cartelle cliniche, referti, esami e avvalersi di un medico-legale che rediga una perizia sulla culpa medica e sulle conseguenze dannose.
Tuttavia, nel campo della responsabilità medica, vi sono particolari attenuazioni di questa rigida ripartizione dell’onere probatorio, soprattutto quando la responsabilità è contrattuale. Infatti, una volta che il paziente abbia provato di avere avuto un rapporto di cura (contratto sanitario) e di aver subito un danno durante quel rapporto, la legge presume che ci sia un inadempimento da parte del sanitario, spostando sul convenuto (medico/struttura) l’onere di dimostrare di aver agito diligentemente. In parole semplici: il paziente deve provare il danno e il ritardo diagnostico, ma è poi il medico/ospedale che deve provare la propria assenza di colpa oppure provare che, anche senza errore, il risultato sarebbe stato lo stesso. Proprio quest’ultimo punto è stato ribadito in una recente pronuncia: la Cassazione ha sottolineato che non spetta ai familiari dimostrare con assoluta certezza che un intervento tempestivo avrebbe evitato il decesso; bensì è la struttura sanitaria a dover provare che, anche con un trattamento corretto e tempestivo, l’esito sarebbe stato comunque infausto. Questo principio alleggerisce il carico probatorio per il paziente, coerentemente con l’idea che è il professionista (e l’ente che lo impiega) ad avere accesso alle informazioni tecniche e organizzative per spiegare cosa è successo. Se il medico non riesce a dimostrare che non vi è nesso tra il suo operato e il danno (ad esempio provando che la malattia era incurabile a prescindere), verrà ritenuto responsabile.
In sede processuale, dunque, la prova della colpa medica e del nesso causale si costruisce spesso così: il paziente produce tutti i documenti clinici e si fa assistere da un consulente tecnico di parte (CTP) – tipicamente un medico legale – il quale, studiando il caso, conclude che c’è stato un errore e che questo errore ha probabilmente causato i danni lamentati. A quel punto sarà la controparte (ospedale/assicurazione) a dover confutare tali conclusioni, magari mostrando che il protocollo seguito era appropriato o portando un proprio consulente che ridimensioni il nesso causale. Il giudice nominerà a sua volta un consulente tecnico d’ufficio (CTU), ovvero un esperto super partes, per avere un parere oggettivo. Alla fine, se permangono incertezze insolubili sul nesso causale – ad esempio perché scientificamente non si può stabilire cosa sarebbe successo se la diagnosi fosse stata tempestiva – in ambito civile si adotta il criterio del “più probabile che non”: basta, come detto, che risulti più probabile di no l’effetto salvifico o migliorativo della diagnosi precoce perché il giudice accolga la domanda. Invece, se le probabilità risultano sotto la soglia del 50%, il caso potrebbe essere qualificato non come nesso causale pieno ma come perdita di chance (e risarcito parzialmente, come visto sopra), oppure rigettato se il ritardo viene ritenuto irrilevante.
Riassumendo: il paziente deve attivarsi per provare il più possibile, ma le lacune probatorie non ricadono interamente su di lui. Una volta dimostrati il danno e il ritardo, sarà il medico a dover convincere che non c’è stata colpa o che il suo errore non ha inciso sull’evento. Questa impostazione garantisce un più equilibrato “bilanciamento delle armi” in giudizio e tutela la parte debole (il paziente) che altrimenti si troverebbe a dover provare l’imponderabile (ossia come sarebbe andata se il medico non avesse sbagliato). Non va dimenticato infatti che la struttura sanitaria risponde anche di carenze organizzative (ad es. reparti sotto organico, esami ritardati per disservizi interni): anche in tali casi, è l’ospedale a dover provare che l’evento dannoso non è dipeso dai suoi deficit organizzativi.
Un ultimo cenno sull’onere della prova del consenso informato: qualora si alleghi che il paziente non fu informato adeguatamente (ad esempio, non venne avvisato della necessità di ulteriori esami o dei segnali sospetti che poi si sono rivelati essere un cancro), spetterà ai medici dimostrare di aver fornito le informazioni dovute. Anche qui la Cassazione è chiara: “senza consenso informato si presume il dissenso del paziente”, il che significa che è onere del sanitario documentare di aver messo il paziente al corrente, altrimenti scatta la responsabilità per violazione del diritto all’informazione. Dunque, conservare copia di eventuali moduli di consenso o annotazioni di colloqui informativi diventa importante per i medici; mentre per il paziente è essenziale segnalare ogni omissione informativa subita.
Affrontare una causa di malasanità richiede una solida base documentale. È opportuno che il paziente (o i familiari) raccolga sin da subito tutti gli atti e i referti utili a ricostruire la vicenda. Ecco una check-list dei documenti fondamentali da portare al primo incontro con l’avvocato e il medico legale:
Cartella clinica completa: richiedere la cartella clinica di ogni struttura sanitaria coinvolta (ospedale, clinica, pronto soccorso dove ci si è rivolti). È un diritto del paziente ottenere copia della propria documentazione sanitaria. Dalla cartella emergono diagnosi, terapie, esami eseguiti e annotazioni dei medici, elementi cruciali per valutare l’errore.
Referti di esami e analisi: conservare tutti i referti diagnostici (esami del sangue, referti radiologici come TAC, risonanze, ecografie, esami istologici, ecc.). Questi documenti spesso contengono i “segnali” che possono essere stati mal interpretati o ignorati. Servono anche a capire quando certi dati erano disponibili.
Cronologia degli eventi sanitari: è utile preparare uno schema cronologico degli appuntamenti, sintomi, visite ed esami sostenuti. Un vero e proprio “cronoprogramma diagnostico” aiuta l’avvocato a capire i tempi morti e i ritardi. Ad esempio: data in cui sono comparsi i primi sintomi, data della prima visita, esame X effettuato il (tal giorno), risultato disponibile il (tal giorno), diagnosi corretta arrivata solo al (tal giorno), e così via. Questa linea temporale evidenzia il gap temporale imputabile a negligenza.
Certificati e documenti clinici vari: ad esempio lettere di dimissione, prescrizioni mediche, richieste di esami specialistici, verbali di pronto soccorso, diario medico se disponibile. Tutto ciò che attesti il percorso sanitario seguito.
Documentazione delle conseguenze: se il paziente ha subito un intervento più invasivo per via del ritardo, includere il relativo referto operatorio; se vi è stata una progressione della malattia, eventuali perizie mediche precedenti o certificati che attestino l’aggravamento.
Spese e ricevute: raccogliere scontrini, fatture e ricevute di tutte le spese affrontate a causa dell’errore (nuove cure, farmaci non previsti, viaggi per centri specialistici, assistenza domiciliare, adattamenti dell’abitazione, ecc.). Queste serviranno per chiedere il rimborso delle spese vive sostenute in conseguenza della diagnosi tardiva.
Eventuale corrispondenza o reclami: se prima di decidere per vie legali sono stati presentati reclami all’ospedale, o ci sono state comunicazioni scritte (e-mail, PEC) con i medici riguardo all’errore, vanno allegate. Possono contenere ammissioni o elementi utili.
L’importanza di questa documentazione è ribadita da tutti gli esperti: “È cruciale raccogliere tutta la documentazione sanitaria, come cartelle cliniche e referti” sin dalle prime fasi. Solo con le carte in mano, infatti, l’avvocato e il consulente medico potranno fornire un parere attendibile sul caso. Spesso, il primo passo dello studio legale sarà far esaminare tutta la documentazione a un proprio medico legale di fiducia, per capire se sussistono i presupposti per procedere e quali siano le chance di successo. In caso affermativo, verrà redatta una perizia medico-legale dettagliata, che costituisce la base tecnica della richiesta di risarcimento. Senza una perizia solida, anche i casi apparentemente evidenti rischiano di naufragare; al contrario, una robusta documentazione può indurre la controparte a offrire un accordo transattivo prima ancora di arrivare in giudizio.
Un ultimo consiglio: non scoraggiarsi di fronte alla burocrazia. La raccolta delle cartelle cliniche richiede tempo e qualche iter amministrativo, ma è un diritto che non possono negarvi. Allo stesso modo, tenere un diario personale degli eventi (anche ricostruito a posteriori) aiuta molto a fare chiarezza. Trasparenza e precisione sono armi vincenti: un buon legale vi aiuterà a far emergere la verità sui fatti, purché abbia a disposizione tutti gli elementi necessari.
Affrontare un caso di diagnosi tardiva non è solo una questione tecnica, ma anche un percorso umano complesso. Da un lato c’è la sofferenza di chi si è visto privare di una cura tempestiva o di un frammento di vita; dall’altro c’è la necessità di responsabilizzare chi ha sbagliato, affinché errori del genere non si ripetano. Intraprendere un’azione legale di risarcimento può sembrare impegnativo, ma rappresenta spesso l’unica via per ottenere giustizia e dare un senso a quella sofferenza, traducendola in un riconoscimento concreto.
È cruciale affidarsi a professionisti esperti in malasanità – avvocati specializzati e medici legali di comprovata esperienza – i quali sappiano valutare con onestà le probabilità di successo e accompagnare il paziente passo dopo passo. Il sistema giudiziario, pur con i suoi tempi, offre strumenti efficaci per far valere i propri diritti. E, come abbiamo visto, la giurisprudenza attuale è sensibile alla tutela dei pazienti: riconosce tanto il danno biologico quantificabile quanto gli aspetti più intangibili come la perdita di chance e la lesione della dignità personale.
In conclusione, se sospettate di aver subìto una diagnosi tardiva o un errore medico, non aspettate. Informatevi, raccogliete la documentazione, consultate un legale. Il tempo perso non ve lo restituirà nessuno, ma agire prontamente può evitare di perdere anche il diritto al risarcimento. La giustizia in questo campo significa ottenere un ristoro economico, certo, ma anche affermare un principio: che la salute del paziente viene prima di tutto – salus aegroti suprema lex – e che ogni violazione di questo principio non rimane impunita.
Giustizia ritardata è giustizia negata, dicevamo, ma quando si interviene in tempo la giustizia può ancora essere pienamente realizzata.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.