

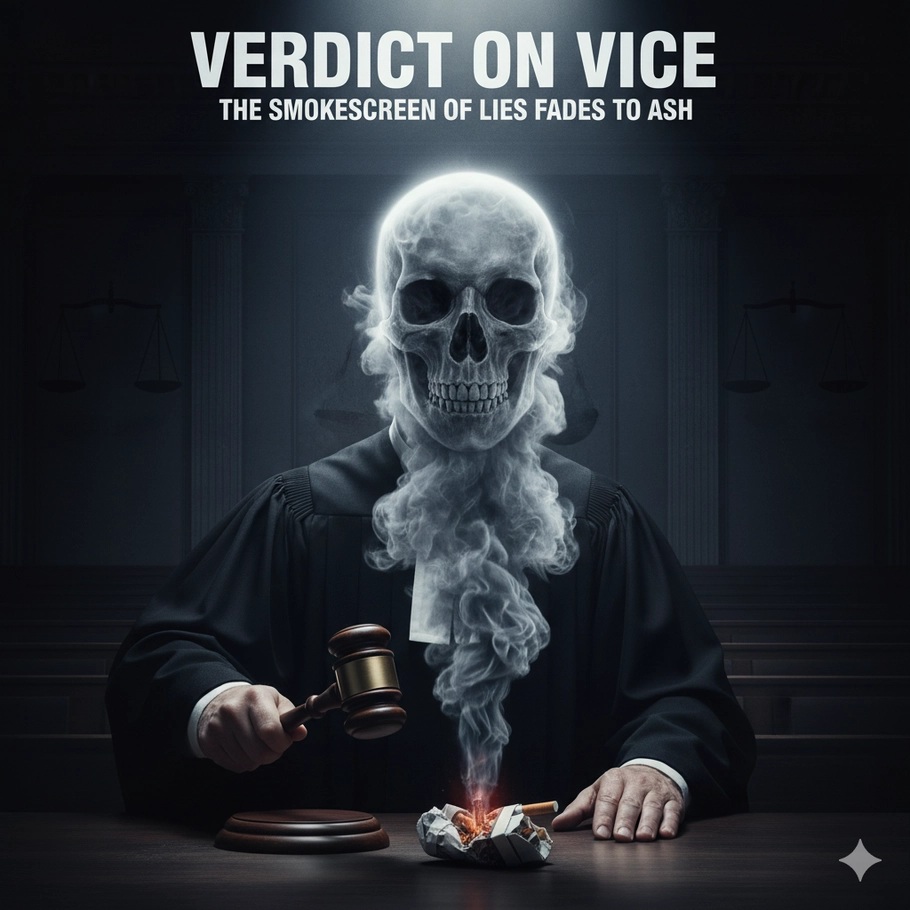
“Smettere di fumare è la cosa più facile del mondo. Lo so perché l’ho fatto migliaia di volte.” – Mark Twain. Questa celebre battuta ironica di Mark Twain evidenzia quanto sia difficile liberarsi dal vizio del fumo. Eppure, fino a poco tempo fa, la legge sembrava trattare il fumatore come l’unico responsabile dei propri mali. In base al principio giuridico del volenti non fit iniuria (a chi acconsente non si fa torto), per decenni la giurisprudenza italiana ha negato qualunque risarcimento a chi si ammalava fumando: si riteneva che la scelta autonoma e consapevole di accendere sigarette – nonostante la notoria dannosità del tabacco – recidesse il nesso causale tra l’operato dei produttori e il danno alla salute. In altre parole, prevaleva il principio di autoresponsabilità: chi fuma lo fa a suo rischio e pericolo, sollevando le aziende produttrici da ogni responsabilità civile per le conseguenze (tumori, malattie cardiache e così via). Le cause intentate dai fumatori o dai loro familiari venivano quindi puntualmente respinte, sostenendo che il fatto stesso di aver volontariamente iniziato e continuato a fumare – con i rischi ben noti sin dagli anni ‘60 – fosse sufficiente a escludere qualsiasi obbligo risarcitorio da parte dei produttori di sigarette.
Questo scenario è cambiato radicalmente con una pronuncia storica della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21464, la Suprema Corte ha affrontato il caso degli eredi di un uomo deceduto per carcinoma polmonare dopo aver fumato due pacchetti di sigarette al giorno per oltre quarant’anni. In primo e secondo grado, i giudici avevano rigettato la richiesta di risarcimento dei familiari, ribadendo il vecchio orientamento: la pericolosità del fumo era cosa nota e la decisione di fumare, essendo libera e consapevole, interrompeva il nesso causale ed escludeva la colpa del produttore. La Cassazione, però, ha cassato queste sentenze di merito e rinviato il caso alla Corte d’Appello, adottando una lettura completamente nuova dei fatti. Secondo la Suprema Corte, l’attività di produzione e vendita di tabacco non va considerata un semplice antefatto neutro, ma costituisce essa stessa una concausa diretta del danno alla salute. Pertanto, non è corretto addossare tutte le conseguenze sulla vittima: il comportamento del fumatore non può essere valutato isolatamente, ma va inquadrato nell’ambito più ampio della condotta dei produttori di sigarette, che immettono sul mercato un prodotto altamente nocivo e potenzialmente addittivo. La nicotina, infatti, genera dipendenza e può limitare la capacità del fumatore di interrompere il consumo. Di conseguenza la scelta di fumare, per quanto volontaria, non può essere considerata una causa esclusiva del danno quando si inserisce in un contesto di rischio creato e conosciuto dall’industria del tabacco.
Uno dei passaggi chiave dell’ordinanza rivoluzionaria del 2025 è la qualificazione della produzione di sigarette come “attività pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Questa definizione comporta l’applicazione di una regola speciale sulla responsabilità civile: chi svolge un’attività pericolosa è responsabile dei danni cagionati, a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli. In altri termini, il carico della prova si inverte in favore del danneggiato. Nel caso del fumo, dunque, spetta al produttore di tabacco dimostrare di avere fatto tutto il possibile per prevenire i danni ai consumatori – informandoli adeguatamente dei rischi, riducendo le sostanze nocive, adottando campagne dissuasive efficaci, ecc. – per andare esente da responsabilità. Si tratta di una prova liberatoria estremamente onerosa: non basta più per le aziende appellarsi genericamente alla “scelta personale” del fumatore. La Cassazione sottolinea che la mera decisione individuale di fumare non esonera il produttore dalla propria obbligazione risarcitoria. Può esservi responsabilità del fumatore solo se il suo comportamento costituisce causa autonoma e sufficiente a provocare il danno, tale da rendere irrilevante il ruolo del produttore. Ma ciò accade soltanto in presenza di circostanze eccezionali (es. se il consumatore fosse l’unico al mondo a ignorare i rischi, ipotesi oggi irreale). Al contrario, nella normalità dei casi, il nesso causale tra l’attività dell’industria del tabacco e la malattia del fumatore rimane, anche considerata la dipendenza indotta dal prodotto. La Suprema Corte ha evidenziato come la piena consapevolezza sociale del rischio sia emersa solo progressivamente nel tempo: ad esempio, il divieto di fumo nei locali pubblici risale al 1975, e solo con il d.lgs. 184/2003 sono state introdotte in Italia le forti avvertenze sui pacchetti di sigarette e altre misure incisive. Pertanto, soprattutto per chi ha iniziato a fumare decenni fa, non si può presumere una completa informazione e percezione del pericolo. Anche su questo punto i giudici di legittimità hanno marcato un cambio di passo: la conoscenza generica che “il fumo fa male” non basta da sola a scaricare tutta la responsabilità sul consumatore, se manca la prova di una consapevolezza concreta e dettagliata del rischio specifico (es. rischio di cancro ai polmoni) al momento del consumo. In sintesi, richiamando il paradigma dell’art. 2050 c.c., la Cassazione ha stabilito che l’industria del tabacco è soggetta a responsabilità oggettiva per i danni da fumo, salvo prova contraria rigorosa. Questa impostazione sovverte la prospettiva precedente e segna un deciso ampliamento delle tutele per i cittadini.
La decisione della Cassazione n. 21464/2025 rappresenta un precedente potentissimo destinato a incidere su tutti i futuri giudizi in materia. In pratica, si apre la strada a richieste di risarcimento da parte di fumatori ammalatisi (o dei familiari di fumatori deceduti) là dove finora tali richieste venivano scoraggiate dal muro giurisprudenziale. Chi ha subito danni alla salute legati al consumo di sigarette può oggi trovare nella pronuncia una base solida per chiamare in causa le aziende del tabacco. Naturalmente questo non significa che ogni fumatore malato verrà automaticamente risarcito: sarà comunque necessario dimostrare il nesso causale tra il consumo di quel prodotto e la patologia (aspetto medico-legale complesso, specie quando intervengono altri fattori di rischio). Tuttavia, la novità sta nell’aver rimosso quello scudo legale che proteggeva a priori i produttori. Ora i giudici dovranno valutare caso per caso se l’azienda ha rispettato tutti i doveri di informazione e prudenza oppure no. È facile prevedere che, soprattutto per fatti avvenuti in decenni passati, le aziende difficilmente potranno provare di aver adottato misure efficaci (si pensi alle epoche in cui le sigarette venivano pubblicizzate come simbolo di status, minimizzando i pericoli). Dunque, per le vittime del fumo si profilano possibilità concrete di ottenere un riconoscimento dei propri diritti e un ristoro economico per i danni subiti. Questa evoluzione giurisprudenziale avvicina l’Italia all’esperienza di altri paesi, come gli Stati Uniti, dove le cause contro i grandi produttori di tabacco hanno portato a risarcimenti miliardari e a profonde modifiche nelle strategie commerciali del settore. Anche nel nostro ordinamento, ora, giustizia e salute pubblica trovano un rinnovato punto di equilibrio: la libertà individuale di fumare non esonera più chi produce e vende sigarette dalle proprie responsabilità sociali.
La “svolta” sancita in materia di fumo si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione del diritto verso una maggiore tutela della salute e dell’integrità personale. Negli ultimi tempi, infatti, la Cassazione ha assunto posizioni innovative anche in altri settori, spesso ribaltando orientamenti precedenti a vantaggio dei danneggiati. Ad esempio, in tema di esposizione professionale a sostanze nocive, la Corte ha riaffermato la responsabilità dei datori di lavoro per le malattie asbesto-correlate (amianto). Con la sentenza Cass. civ., Sez. Lav., 17 febbraio 2025, n. 4092, è stato accolto il ricorso degli eredi di un operaio deceduto per mesotelioma pleurico dopo anni di lavoro a contatto con l’amianto: anche in quel caso la Corte d’Appello aveva negato il risarcimento, ritenendo non pienamente nota la pericolosità dell’amianto all’epoca dei fatti e non provato in modo certo il nesso tra esposizione e tumore. La Cassazione ha invece chiarito che già da decenni esistevano conoscenze e norme protettive (l’asbestosi è riconosciuta come malattia professionale fin dal 1943) e che il datore di lavoro aveva l’obbligo di tutelare i dipendenti anche prima delle specifiche leggi degli anni ’90. Inoltre, ha ribadito che in materia di malattie professionali non serve una certezza assoluta sul nesso causale, essendo sufficiente un alto grado di probabilità logica basato sulle evidenze mediche: nel caso di specie, la diagnosi di asbestosi precedente al cancro era un “segnale sentinella” di esposizione massiccia, sufficiente a collegare probabilmente l’amianto al successivo tumore. In sostanza, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito e imposto un nuovo esame, sottolineando ancora una volta che il principio di precauzione e la protezione della salute devono prevalere sulle incertezze, invertendo l’onere della prova in capo al datore di lavoro (il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza, ex art. 2087 c.c.). Un altro campo significativo di recente intervento è quello dello stress lavoro-correlato. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. Lav., 23 aprile 2025, n. 10730, la Cassazione ha cambiato paradigma nelle cause per danno psicologico da lavoro: non è più necessario identificare un preciso “persecutore” (come nel mobbing classico) affinché il lavoratore ottenga giustizia. È sufficiente dimostrare che l’ambiente di lavoro si è fatto tossico e ha causato un serio disagio psico-fisico al dipendente, anche in assenza di condotte intenzionalmente vessatorie. In tal caso l’azienda può essere chiamata a rispondere. Tradotto in termini concreti: il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire situazioni lavorative stressogene e di salvaguardare la salute mentale dei propri dipendenti; non può trincerarsi dietro l’assenza di colpe specifiche di singoli superiori o colleghi. Ancora una volta, viene invocato l’art. 2087 c.c. come baluardo: la Cassazione ricorda che questa norma impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, e tale dovere si estende anche alla prevenzione di fenomeni di burnout, straining e stress cronico. Queste pronunce – dal fumo, all’amianto, allo stress occupazionale – pur riguardando ambiti diversi, condividono un filo rosso: l’orientamento dei giudici si muove verso una maggiore protezione dei diritti della persona, riconoscendo il risarcimento del danno alla salute in situazioni un tempo trascurate o negate. Viene progressivamente limitato il principio secondo cui la vittima “ha accettato il rischio”: sia il produttore di beni pericolosi sia il datore di lavoro negligente vengono posti di fronte alle proprie responsabilità. Il messaggio è chiaro e forte: salus populi suprema lex – la salvaguardia della salute (individuale e collettiva) è la legge più alta e funge da criterio guida nell’interpretazione delle norme. Chi subisce un danno ingiusto alla salute, sia esso fisico o psichico, trova oggi maggiori riconoscimenti in sede giudiziaria.

Redazione - Staff Studio Legale MP