

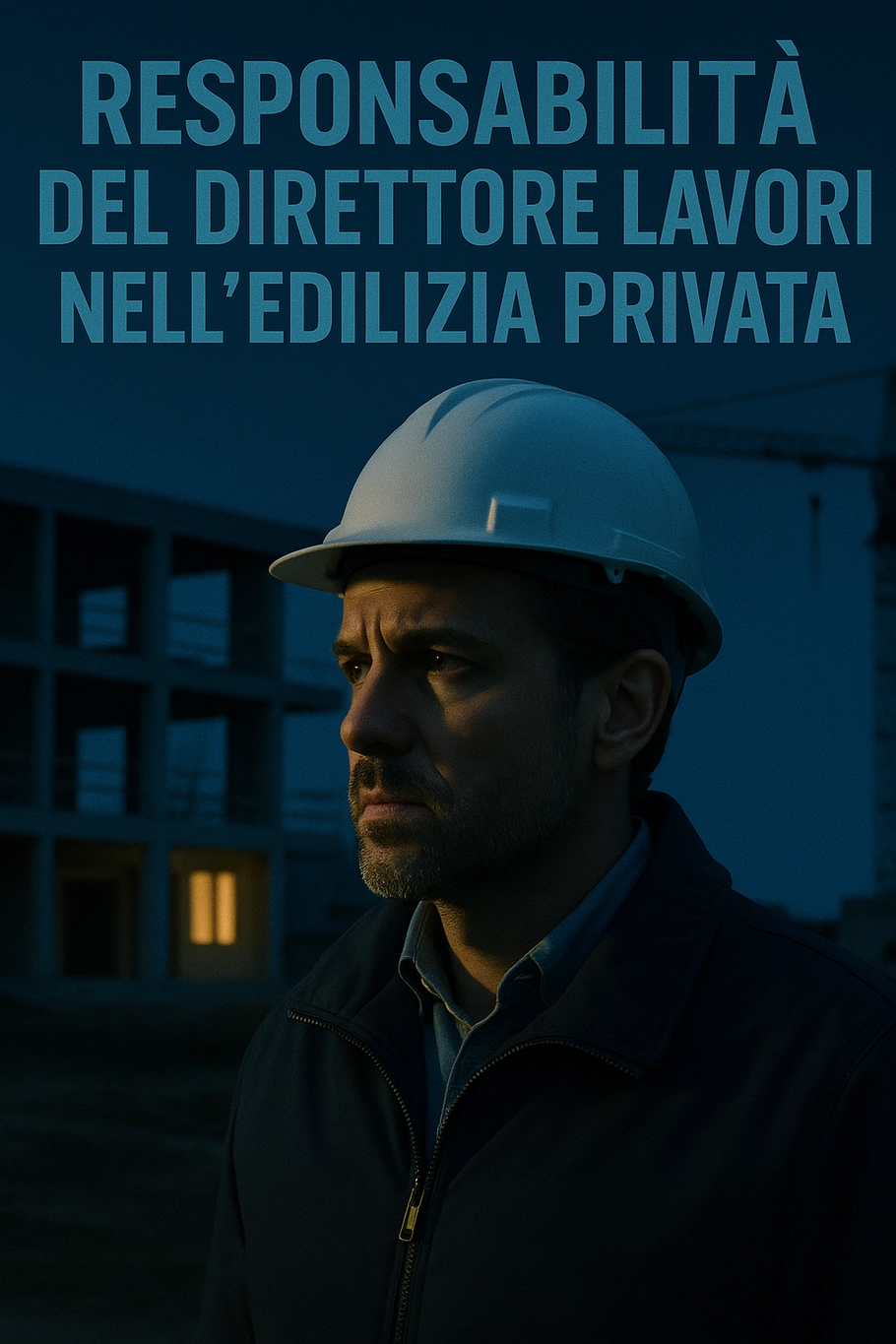
Come le ultime sentenze delineano i doveri del direttore dei lavori e quali accorgimenti adottare nel contratto per tutelare committenti e professionisti in ambito di edilizia privata.
Nel settore dell’edilizia privata, la figura del direttore dei lavori (spesso un architetto o ingegnere incaricato dal committente) riveste un ruolo cruciale e delicato. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno ulteriormente definito i profili di responsabilità di questo professionista, chiarendo compiti, limiti di responsabilità e possibili conseguenze in caso di inadempimento. Allo stesso tempo, tali sviluppi giurisprudenziali suggeriscono l’importanza di cautele contrattuali specifiche: definire con precisione i compiti del direttore lavori, prevedere obblighi di vigilanza attiva e documentare le attività di controllo sono diventati elementi fondamentali per prevenire contenziosi. In questo articolo, esamineremo i profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttore dei lavori alla luce della più recente giurisprudenza, evidenziando le novità emerse dalle sentenze più recenti (2024-2025) e fornendo indicazioni pratiche (in ottica SEO) su come committenti e professionisti possano tutelarsi con adeguate clausole contrattuali.
Il direttore dei lavori è il rappresentante tecnico del committente sul cantiere dell’appalto privato. Il suo compito principale è garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al progetto approvato, al contratto di appalto e alle normative vigenti. In pratica, i suoi obblighi coprono una vasta gamma di attività di sorveglianza e controllo: verifica che i materiali impiegati siano adeguati e conformi alle specifiche, controlla che le lavorazioni procedano secondo il progetto esecutivo e le regole dell’arte, registra gli avanzamenti e coordina le comunicazioni tra committente e appaltatore. Questa funzione va ben oltre una supervisione formale o burocratica: la Cassazione ha sottolineato che il direttore dei lavori deve svolgere una vigilanza attiva e costante, con un approccio proattivo alla prevenzione di difformità e vizi costruttivi.
Da un punto di vista normativo, il rapporto che lega il direttore lavori al committente è di natura contrattuale (un contratto d’opera professionale). Ciò significa che il direttore è tenuto alla diligenza professionale qualificata prevista dall’art. 1176, co. 2, c.c.: deve comportarsi con la perizia e attenzione che ci si aspetta da un professionista medio della sua qualifica, nella specifica situazione concreta. In cantiere, quindi, non basta una presenza saltuaria o limitarsi a “fare atto di presenza”: il professionista deve organizzare verifiche periodiche nelle fasi critiche, impartire istruzioni all’impresa, pretendere il rispetto di norme di sicurezza e tecniche, e segnalare tempestivamente eventuali irregolarità. Un direttore lavori scrupoloso terrà aggiornato il giornale dei lavori, redigerà verbali di sopralluogo e relazioni periodiche, informando il committente di ogni problema significativo. Tutto ciò non solo è buona prassi, ma costituisce un vero e proprio dovere giuridico: la Suprema Corte ha ribadito che il direttore dei lavori “è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevarle”, ovvero deve attivarsi per prevenire vizi e non limitarsi a constatarli a cose fatte.
Se il direttore dei lavori viola i propri obblighi contrattuali di controllo e vigilanza, può incorrere in responsabilità contrattuale verso il committente (il cliente proprietario dell’immobile). In termini semplici, ciò avviene quando dall’inadempimento dei suoi doveri derivano danni: tipicamente, vizi e difetti dell’opera che un’adeguata sorveglianza avrebbe evitato. Ad esempio, pensiamo a gravi infiltrazioni o crepe strutturali dovute a errori di posa in opera: l’appaltatore ne risponde quale esecutore materiale, ma il direttore dei lavori può risponderne a sua volta se non ha vigilato e segnalato in tempo quelle difformità. La giurisprudenza recente è intervenuta più volte a confermare questo principio: la Cassazione, con sentenza n. 18929/2024, ha ribadito che il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore per i vizi derivanti da omessa sorveglianza, salvo solo il caso in cui i difetti siano dovuti esclusivamente a errori progettuali fuori dall’ambito del suo controllo. Questa pronuncia del 2024 segna un punto fermo: il direttore dei lavori non può assumere un ruolo meramente formale, ma deve farsi garante della qualità dell’esecuzione, altrimenti ne condividerà le conseguenze dannose.
Un aspetto peculiare della responsabilità del direttore lavori rispetto a quella dell’appaltatore è la diversa natura del loro obbligo e, di conseguenza, il differente regime probatorio. L’appaltatore risponde come obbligato al risultato (garantisce che l’opera sia esente da difetti): in caso di vizi, al committente basta provare l’esistenza del vizio nell’opera, senza dover dimostrare colpa dell’appaltatore. Il direttore dei lavori, invece, risponde per colpa professionale nell’aver violato gli obblighi di controllo: trattandosi di responsabilità contrattuale da inadempimento, il committente che agisce contro il direttore deve provare non solo l’esistenza del vizio, ma anche la condotta negligente od omissiva del professionista e il nesso causale tra questa e il danno (il vizio dell’opera). In altre parole, è necessario dimostrare che il direttore lavori ha mancato ai suoi doveri di vigilanza e che, se avesse agito diligentemente, quel difetto sarebbe stato evitato o contenuto. Questa distinzione comporta che, nei giudizi, l’azione contro il direttore dei lavori richiede un onere della prova più articolato a carico del committente rispetto alla più agevole azione contro l’appaltatore.
Una recente ordinanza della Cassazione (ord. n. 18405/2025) ha rafforzato ulteriormente l’idea della “vigilanza attiva” a carico del direttore dei lavori, chiarendo che il vincolo di solidarietà nel risarcimento si applica quando i vizi e le difformità costruttive siano anche in parte imputabili all’omesso controllo del direttore. In tale pronuncia si evidenzia che il direttore non può limitarsi a dissociarsi verbalmente da lavorazioni scorrette o a fare contestazioni formali ex post: egli ha l’obbligo di intervenire e prevenire le irregolarità, adottando tutte le misure necessarie in corso d’opera. Chi tace acconsente, recita un noto brocardo latino – “qui tacet consentire videtur, ubi loqui debuit ac potuit” – e questo vale anche in cantiere: se il direttore lavori assiste passivamente a scelte esecutive sbagliate senza fermarle né informare il committente, il suo silenzio può equivalere ad un consenso colpevole. Non a caso, la Cassazione ha affermato che il direttore, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a segnalare il dissenso su certi interventi ritenuti scorretti, ma deve fare tutto il possibile per impedirne la realizzazione. Questa linea rigorosa mira a tutelare il committente: investire in un direttore dei lavori deve garantire un valore aggiunto in termini di controllo tecnico, e la legge assicura che il professionista non possa lavarsi le mani di fronte alle negligenze altrui senza conseguenze.
Va peraltro precisato che la responsabilità del direttore dei lavori non è illimitata né automatica: egli risponde dei danni solo se e nella misura in cui essi siano effettivamente riconducibili alla sua omissione di vigilanza. Non è richiesto, ad esempio, che il direttore sia presente ogni singolo giorno sul cantiere; la Cassazione ha esplicitamente escluso l’idea di un obbligo di presenza continua, a patto però che il tecnico organizzi controlli periodici adeguati. Inoltre, se un vizio dell’opera dipende da un aspetto del tutto estraneo ai compiti di controllo del direttore, questi non ne risponde. È il caso – evidenziato proprio dalla sentenza Cass. 18929/2024 – in cui il difetto sia dovuto esclusivamente a un errore progettuale (magari commesso da altro professionista) che il direttore non poteva rilevare attraverso la sorveglianza in cantiere. In situazioni simili, si esclude la responsabilità solidale del direttore lavori. Allo stesso modo, qualora l’impresa esecutrice ponga in essere, di nascosto, lavorazioni difformi nonostante le istruzioni contrarie del direttore, e queste risultino difficili da scoprire tempestivamente, potrebbe invocarsi il principio “ad impossibilia nemo tenetur”: nessuno può essere tenuto a risultati impossibili. In sostanza, la giurisprudenza riconosce che il direttore non è un assicuratore universale contro ogni difetto dell’opera, ma risponde delle carenze “ragionevolmente” attribuibili a un suo mancato esercizio della dovuta diligenza nel controllo.
Quando un’opera presenta difetti gravi, spesso la responsabilità è il frutto di più condotte colpose: ad esempio, l’appaltatore potrebbe aver eseguito male i lavori e il direttore potrebbe non aver vigilato osegna segnalato in tempo. In questi casi di concorso, come si ripartiscono le colpe e i risarcimenti? La risposta ce la fornisce sia la legge che la giurisprudenza: se più soggetti contribuiscono con condotte differenti a causare un danno unitario al committente, essi ne rispondono in solido verso il danneggiato (art. 2055 c.c.). Significa che il committente può chiedere l’intero risarcimento a entrambi insieme o anche a uno solo dei corresponsabili, lasciando poi a costoro la regolazione dei conti interna in base alla gravità delle rispettive colpe. Questo principio, nato in materia extracontrattuale, è stato applicato dalla Cassazione anche ai casi in cui appaltatore (che risponde contrattualmente ex art. 1667 c.c. per i vizi dell’opera) e direttore dei lavori (che risponde contrattualmente ex artt. 1218 e 2230 c.c. per inadempimento ai suoi doveri) abbiano entrambi concorso a causare il medesimo evento di danno al committente. La tradizionale teoria che negava la solidarietà in mancanza di una “causa obligandi” identica è stata superata: oggi conta il fatto oggettivo che più condotte colpose abbiano cooperato al danno. Cassazione 20704/2021 ha chiaramente affermato che, nell’appalto privato, il direttore dei lavori (o progettista) e l’impresa appaltatrice sono solidalmente responsabili dei danni subìti dal committente se le rispettive inadempienze hanno efficacemente concorso a produrre quei danni. Non importa che la responsabilità dell’uno sia contrattuale e quella dell’altro parimenti contrattuale (ma da diverso titolo contrattuale) o, eventualmente, extracontrattuale: ciò che rileva è che entrambi, con le loro omissioni, abbiano causato il risultato dannoso. In tal caso, “a nulla rileva la diversità dei titoli”, ossia la diversa fonte della responsabilità, perché l’ordinamento privilegia la tutela del danneggiato garantendogli la possibilità di agire contro tutti i corresponsabili per l’intero.
Questa solidarietà esterna verso il committente va distinta dalla responsabilità interna fra appaltatore e direttore: in un eventuale giudizio di rivalsa tra loro, il giudice potrà graduare la colpa e ripartire il peso risarcitorio in proporzione (ad esempio, potrebbe stabilire che il direttore sia responsabile al 30% e l’appaltatore al 70% del danno, a seconda della gravità delle rispettive mancanze). Ma per il committente, tali distinzioni interne non hanno effetto: egli ha diritto al pieno risarcimento e può ottenerlo da entrambi. Questo orientamento è pensato per evitare che il committente, già danneggiato da un’opera difettosa, debba anche subire il rimpallo di responsabilità tra impresa e direttore lavori. In concreto, se la casa presenta gravi difetti strutturali dovuti sia a errori dell’impresa sia alla mancata vigilanza del direttore, il proprietario potrà chiamarli entrambi in giudizio. La Cassazione conferma che il committente può rivalersi indifferentemente sull’uno o sull’altro per l’intero danno, salva poi la regolazione di quanto ciascuno dovrà sopportare in via di regresso in base alle colpe.
Un altro aspetto da considerare è il termine di prescrizione delle azioni contro i diversi soggetti. Per i vizi dell’opera, l’azione contro l’appaltatore è soggetta ai termini brevi previsti dal codice civile: denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e prescrizione entro 2 anni (o 1 anno dalla scoperta e 10 anni dalla fine lavori in caso di gravi difetti ex art. 1669 c.c.). Invece, la responsabilità del direttore dei lavori, essendo legata al contratto d’opera professionale, segue la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.. Significa che il committente può agire contro il direttore per inadempimento anche oltre i termini in cui magari è decaduta o prescritta l’azione edilizia contro l’appaltatore. La Cassazione ha confermato che i termini speciali di decadenza/prescrizione dell’appalto non si applicano al direttore lavori né al progettista. Questo è un punto di estrema importanza pratica: ad esempio, qualora gravi difetti strutturali emergano dopo 5 o 6 anni dalla costruzione, l’azione ex art. 1669 c.c. contro il costruttore va esercitata entro 1 anno dalla scoperta; ma l’azione contrattuale contro il direttore (o progettista) resta possibile entro 10 anni dall’evento dannoso. In alcuni casi, quindi, il committente potrebbe trovarsi a poter chiedere i danni al direttore lavori anche quando l’azione contro l’appaltatore è ormai preclusa. Questa differenza di regime impone particolare attenzione e un monitoraggio adeguato: è una “ancora di salvezza” per il committente, ma anche un rischio prolungato per il professionista, che deve tenere coperta la propria posizione magari con idonea assicurazione professionale per tutta la durata decennale.
Da ultimo, vale la pena accennare che la responsabilità del direttore dei lavori può assumere rilievo anche verso terzi estranei al contratto. Ad esempio, se durante l’esecuzione dei lavori si verifica un danno a un edificio confinante o a un passante, il direttore dei lavori potrà essere chiamato a risponderne in via extracontrattuale (assieme all’appaltatore), ma solo qualora si dimostri che una sua condotta colposa (es. omesso controllo di misure di sicurezza, tolleranza di prassi pericolose) abbia contribuito all’evento. In genere, in questi casi prevale la responsabilità dell’appaltatore quale esecutore materiale e del committente come eventualmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. (se l’appaltatore è considerato suo ausiliario), ma la giurisprudenza non esclude un concorso del direttore lavori per colpa propria. Anche qui vale il principio del 2055 c.c.: se un terzo subisce un danno da crollo o incidenti in cantiere, e tanto l’appaltatore quanto il direttore (oltre magari al progettista) hanno colpa, essi risponderanno solidalmente verso il terzo danneggiato. È chiaro però che il direttore risponde solo se ha assunto di fatto una posizione di garanzia verso quel tipo di evento: ad esempio, la Cassazione penale (sent. n. 5003/2025) ha ricordato che i tecnici della direzione lavori e della sicurezza non possono sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di infortuni sul cantiere, anche se formalmente il loro incarico non li investiva di certi obblighi specifici, conta ciò che hanno fatto o omesso in concreto. Fortunatamente, questi casi esulano dall’ambito quotidiano dell’edilizia privata residenziale, ma è bene avere presente che il direttore dei lavori, come ogni professionista, può essere chiamato a rispondere anche verso soggetti terzi per fatti illeciti generati dalla sua condotta negligente (si pensi ad esempio a un cedimento strutturale che metta in pericolo gli occupanti dell’edificio: qui il direttore risponderebbe verso il committente contrattualmente e verso gli inquilini o vicini eventualmente in via extracontrattuale, qualora la sua vigilanza avrebbe potuto evitare il danno).
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che definire chiaramente diritti, doveri e responsabilità del direttore dei lavori già in sede contrattuale è fondamentale per prevenire dispute e proteggere sia il committente sia il professionista. Ecco alcune cautele contrattuali e operative che è opportuno adottare:
Scelta di un professionista qualificato – Per il committente (sia esso un privato cittadino o un costruttore), il primo passo è selezionare con cura un direttore dei lavori di provata esperienza e competenza. Un professionista esperto saprà organizzare un controllo rigoroso del cantiere, prevenendo errori e contenziosi futuri. Anche in ottica SEO (Search Engine Optimization) per trovare clienti, sottolineare la propria esperienza in lavori simili e mostrare case history positive può fare la differenza: i committenti spesso cercano online termini come “direzione lavori appartamento ristrutturazione responsabilità” o “collaudo e direzione lavori difetti” per informarsi, ed essere presenti con contenuti che rassicurano sulla competenza può attirare clienti.
Contratto di incarico chiaro e dettagliato – È essenziale predisporre un disciplinare d’incarico scritto per la direzione lavori, in cui vengano elencati in modo preciso i compiti del direttore, l’estensione del suo potere di intervento e le sue responsabilità. Vanno specificate le modalità dei controlli (es. frequenza dei sopralluoghi in cantiere, obbligo di redigere report periodici, procedure per segnalare non conformità), eventualmente i limiti dell’incarico (es. se il direttore NON svolge anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza, ciò deve essere chiarito, distinguendo le figure). Prevedere esplicitamente obblighi di “sorveglianza attiva” nelle fasi critiche dei lavori è utile sia per vincolare il professionista, sia per costituire una base chiara in caso di contestazioni. Ad esempio, il contratto potrebbe stabilire che il direttore verificherà l’armatura dei ferri prima del getto del calcestruzzo e attesterà per iscritto la conformità, così da avere traccia dell’avvenuto controllo. Allo stesso tempo, per tutelare il direttore, il contratto può contenere clausole che escludono responsabilità per ambiti non di sua competenza: ad esempio, “il direttore non risponde per vizi derivanti esclusivamente da errori progettuali altrui o da difformità nascoste che non era ragionevolmente tenuto a rilevare”. Ovviamente, tali clausole non potranno mai esonerare il direttore da colpa grave o violazioni di norme di ordine pubblico, ma servono a delineare il perimetro dell’incarico. Un contratto chiaro riduce il rischio di malintesi: come diceva Voltaire, “le scritture rimangono”, ovvero mettere nero su bianco previene dispute sull’onda dei ricordi.
Documentazione e tracciabilità delle attività – Dal punto di vista del direttore dei lavori, una regola d’oro è “documentare, documentare, documentare”. Ogni visita in cantiere dovrebbe essere seguita da un breve verbale o rapporto di sopralluogo in cui si annotano lo stato dei lavori, eventuali istruzioni date all’impresa e non conformità riscontrate. Le comunicazioni importanti (ordini di servizio, contestazioni di vizi, sospensioni dei lavori per motivi tecnici) vanno fatte per iscritto e preferibilmente inviate anche al committente per conoscenza. Questo non solo adempie a un dovere di informazione, ma crea una traccia utile in caso di future contestazioni legali: poter esibire le mail e i verbali che dimostrano come il direttore abbia avvisato l’impresa dei problemi e il committente delle possibili conseguenze è spesso decisivo per andare esenti da responsabilità. Viceversa, la mancanza di prove scritte lascia spazio a contestazioni sulla presunta inerzia del direttore. Pertanto, inserire nel contratto l’obbligo di redigere periodicamente verbali di avanzamento e checklist di controllo può essere utile e conforme alla diligenza richiesta. Oggi esistono anche strumenti digitali (software di cantiere, BIM con funzioni di report, ecc.) che facilitano questa tracciabilità e permettono al committente di accedere in tempo reale ai report: adottarli può costituire una best practice innovativa, da comunicare anche in chiave marketing per distinguersi sul mercato.
Previsione di coperture assicurative – Considerata l’estensione temporale decennale della responsabilità del direttore dei lavori e la gravità dei rischi (basti pensare ai costi di riparazione di gravi difetti strutturali), è fortemente consigliato – e ormai comune – che il professionista stipuli una polizza di assicurazione RC professionale che copra l’attività di direzione lavori. Dal canto suo, un committente accorto potrebbe inserire nel contratto l’obbligo per il direttore di esibire una polizza valida e di mantenerla attiva per un certo periodo dopo la fine dei lavori (alcune polizze postume coprono i danni manifestatisi entro 5 o 10 anni). Questo fornisce una garanzia aggiuntiva che, in caso di gravi problemi, ci sia un soggetto solvibile (l’assicurazione) a rispondere. Analogamente, per i committenti più strutturati (es. aziende di sviluppo immobiliare), può essere utile prevedere contrattualmente che l’impresa appaltatrice e il direttore partecipino a periodiche riunioni di coordinamento e cooperino nella risoluzione tempestiva delle criticità, formalizzando in appositi verbali le decisioni: in tal modo, si crea un team coeso e si riducono i rischi di attribuzioni di colpa ex post.
Clausole penali o incentivi legati alla qualità – Un’altra cautela contrattuale che talvolta si vede è la previsione di clausole penali a carico del direttore dei lavori in caso di inadempimento grave dei suoi obblighi (ad esempio una penale pecuniaria se viene accertato che non ha effettuato i controlli concordati, oppure se non segnala tempestivamente difformità rilevanti). Tali clausole però possono incontrare limiti di validità, specie se appaiono come esoneri di responsabilità indiretti (ricordiamo che la responsabilità per colpa grave non può essere preventivamente limitata). Un approccio più costruttivo può essere quello di prevedere incentivi per il direttore legati al buon esito e all’assenza di contestazioni: ad esempio, una premialità se al collaudo finale l’opera risulta senza vizi oppure se eventuali vizi minori vengono risolti senza contenzioso. Ciò allinea gli interessi del direttore a quelli del committente, motivandolo ulteriormente a svolgere una vigilanza efficace.
Monitoraggio dei termini legali – Come evidenziato, i termini per far valere difetti e responsabilità differiscono tra appaltatore e direttore. È prudente per il committente tenere un’agenda dei termini: ad esempio, fare verifiche approfondite sull’opera prima che scadano i 2 anni di garanzia dell’appaltatore (per vizi non gravi) o il termine di un anno dall’eventuale scoperta di difetti gravi (art. 1669 c.c.), in modo da attivarsi in tempo contro l’impresa. Parallelamente, sapere di avere fino a 10 anni per agire contro il direttore può evitare di considerare irrecuperabili certi danni se l’azione contro l’impresa è prescritta: il committente potrebbe ancora avere un rimedio. Dal lato del direttore, ciò significa che la tranquillità arriva solo dopo dieci anni dall’ultimazione dell’opera (salvo interruzioni): è bene quindi conservare tutta la documentazione almeno fino ad allora, e magari – come detto – mantenere una coda di copertura assicurativa. Entrambe le parti, se ben consigliate da un legale, dovrebbero mettere in conto questi orizzonti temporali nei loro accordi.
La figura del direttore dei lavori nell’edilizia privata ha assunto, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, un ruolo ancora più centrale e di alta responsabilità. La Suprema Corte ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il direttore dei lavori è un attore chiave nella garanzia della qualità costruttiva e della conformità tecnico-normativa di un’opera, e non può ridursi a “firmaio” o spettatore passivo. Diligenza, vigilanza attiva e comunicazione trasparente con committente e appaltatore sono le parole d’ordine per chi ricopre questo ruolo. Allo stesso tempo, i committenti sono chiamati a fare la loro parte: scegliere professionisti competenti, formalizzare bene gli incarichi e pretendere report e controlli effettivi durante i lavori. In un’ottica di prevenzione, investire in un buon direttore dei lavori e in un solido contratto di appalto significa ridurre drasticamente la probabilità di ritrovarsi a dieci anni di distanza con gravi difetti e cause legali. Come recita un antico adagio, “meglio prevenire che curare”: prevenire i vizi con la sorveglianza è meglio che curarli poi in tribunale.
Vale la pena di ricordare, in chiusura, che assumere il ruolo di direttore dei lavori implica una assunzione di responsabilità morale ancor prima che giuridica. A tal proposito, un richiamo letterario ci illumina: «Tu diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato» dice la volpe al Piccolo Principe. Analogamente, chi “addomestica” (ovvero prende in carico) un progetto edilizio ne diventa per sempre responsabile, in senso lato, della sua sorte. La fiducia che il committente ripone nel direttore dei lavori è grande: egli affida al professionista la realizzazione di un bene spesso di enorme valore economico e affettivo (la casa, l’edificio da lasciare ai figli, ecc.). Tradire quella fiducia con negligenza può avere conseguenze gravissime per tutti. Al contrario, esercitare il proprio ruolo con rigore e proattività porta benefici: le opere riescono meglio, le dispute si riducono, la reputazione professionale cresce. In medio stat virtus: la virtù sta nel mezzo, ossia nel trovare equilibrio tra controllo minuzioso e collaborazione con l’impresa, tra tutela del committente e dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti.
In definitiva, la più recente giurisprudenza in materia di responsabilità del direttore dei lavori nell’edilizia privata non fa che ribadire concetti ispirati al buon senso e alla buona tecnica: vigilare sempre, intervenire presto, contrattualizzare tutto il possibile. Seguendo questi principi – e con un pizzico di passione per il proprio lavoro – il direttore dei lavori può veramente diventare il “regista” che assicura il lieto fine di un’opera edile, a beneficio del committente e della collettività.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.