

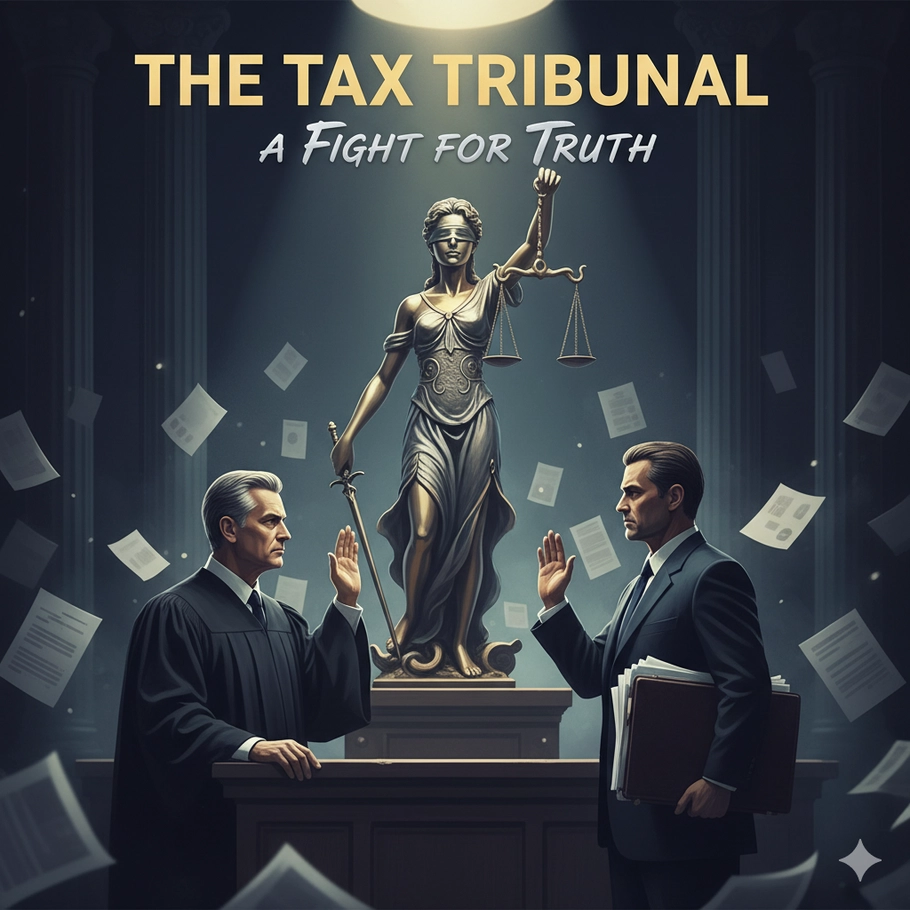
«La verità è raramente pura e non è mai semplice.» – Oscar Wilde. Nel contenzioso fiscale, l’accertamento della verità è complesso e regolato da norme rigorose. La recente riforma del processo tributario segna però una svolta storica: viene superato lo storico divieto di ammettere testimoni nel giudizio tributario e vengono introdotte nuove regole sulla produzione delle prove in appello. In questo articolo esaminiamo le novità principali del 2024 nel diritto tributario processuale – dall’introduzione della testimonianza scritta all’abolizione della mediazione obbligatoria, fino ai correttivi della Corte Costituzionale sulle limitazioni probatorie – per capire come cambia la tutela del contribuente di fronte al Fisco.
Per decenni nel processo tributario vigeva un rigido divieto di ammettere testimoni: la prova testimoniale era espressamente esclusa, rendendo il giudizio fiscale essenzialmente documentale. Questa peculiarità aveva radici storiche nella sfiducia verso dichiarazioni di terzi in materia di imposte, ritenute poco affidabili. «Testis unus, testis nullus», ammonivano i giuristi latini: un solo testimone equivale a nessun testimone. Di conseguenza, al contribuente era precluso portare in giudizio persone informate sui fatti a proprio favore, anche quando l’esito della causa poteva dipendere da quelle testimonianze.
Con la Legge n. 130/2022 (riforma della giustizia tributaria) questa impostazione è cambiata. Dal 2023 è finalmente ammessa la testimonianza nel processo tributario, seppur con forme e limiti particolari. In pratica non si tratta di una testimonianza orale tradizionale in udienza, ma di testimonianza scritta: il giudice tributario, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, può ammettere che un terzo renda dichiarazioni scritte sui fatti di causa. Viene così introdotta nel processo tributario 2.0 la figura del testimone, sia pure “a distanza”.
Questa novità rappresenta un importante passo avanti verso un processo più equilibrato. Permettere ai contribuenti di fornire prove testimoniali – ad esempio, un cliente che attesti una determinata operazione commerciale, o un consulente che confermi un certo fatto – può rafforzare la posizione difensiva in cause dove i soli documenti non bastano a chiarire la vicenda. Allo stesso tempo, il legislatore ha previsto garanzie per evitare abusi: la testimonianza è ammessa solo in forma scritta e solo in via eccezionale, quando non vi siano altri mezzi di prova disponibili. Il giudice decide caso per caso se acquisire una dichiarazione testimoniale, valutandone la necessità per definire la controversia.
Sono inoltre stabiliti limiti rigorosi sul contenuto della testimonianza. Non possono testimoniare soggetti che hanno interesse diretto nella causa (ad esempio soci della società contribuente o coobbligati nel debito tributario). Inoltre non si può usare la testimonianza per aggirare il valore legale di atti pubblici: se un fatto è attestato in un verbale ufficiale (ad esempio un verbale di verifica della Guardia di Finanza) che fa fede fino a querela di falso, il testimone non può smentire quel fatto. In sostanza, la testimonianza può riguardare solo circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle già cristallizzate in atti pubblici, e non può mai provenire dalla stessa parte in causa.
Quella introdotta è dunque una prova “residuale” e “straordinaria”. La norma (art. 7, co. 4, D.Lgs. 546/1992, come modificato) ricalca la formulazione sull’ammissione di nuove prove in appello, indicando che il giudice può ammettere testimoni “ove lo ritenga necessario ai fini della decisione”. Ciò lascia intendere che la testimonianza sarà accolta solo quando indispensabile. Di fatto, nel processo tributario continuano a dominare i documenti e le presunzioni, mentre il testimone scritto sarà una risorsa di chiusura, da utilizzarsi in casi eccezionali. Resta il fatto, però, che si è superato un tabù: il muro che escludeva totalmente i testimoni dal processo fiscale è caduto. Questa apertura, pur cauta, rappresenta una garanzia in più per il contribuente che voglia far emergere la verità su fatti rilevanti ai fini delle imposte. Come sottolineato dalla Suprema Corte, l’obiettivo della riforma è “assegnare all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”, ribadendo nel contempo che spetta sempre all’Amministrazione finanziaria provare in giudizio le violazioni contestate (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2746/2024). In altri termini, il principio dell’onere della prova in campo tributario non cambia: è il Fisco che deve dimostrare la fondatezza delle pretese impositive, mentre il contribuente può avvalersi ora anche di dichiarazioni di terzi a proprio favore.
Accanto alla rivoluzione “copernicana” dei testimoni ammessi, la riforma ha inciso profondamente anche sulle regole del processo di appello tributario, in particolare sulla produzione di nuove prove e documenti nei gradi successivi. Storicamente, il giudizio tributario di secondo grado era caratterizzato da una certa flessibilità probatoria: era sempre possibile produrre nuovi documenti in appello, anche preesistenti e non presentati in primo grado, senza particolari restrizioni (salvo il rispetto di termini processuali). La norma previgente (art. 58, D.Lgs. 546/92, vecchio testo) consentiva al giudice di appello di assumere nuove prove ritenute necessarie e, soprattutto, lasciava libera la produzione di documenti nuovi, persino se la parte avrebbe potuto esibirli già prima. Questa impostazione, peculiare rispetto al processo civile, mirava a favorire l’accertamento della verità materiale in materia tributaria, non precludendo al contribuente di far valere in appello elementi probatori trascurati in primo grado.
La riforma del 2023 ha introdotto un regime molto più restrittivo, allineando l’appello tributario al modello civilistico. La nuova formulazione dell’art. 58 (D.Lgs. 546/92) prevede che non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti in appello, a meno che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, oppure che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile. Viene quindi importato il concetto di prova nuova indispensabile o di causa non imputabile (forza maggiore, scoperta successiva di documenti decisivi) per poter aggiungere elementi nel secondo grado. Inoltre, il nuovo art. 58 consente la proposizione di motivi aggiunti in appello qualora il contribuente venga a conoscenza solo dopo il primo grado di nuovi documenti (non prodotti dalle altre parti) da cui emergano vizi degli atti impugnati: una possibilità per reagire a “sorprese” documentali emerse tardivamente.
La stretta più significativa introdotta nel 2023 riguardava però un aspetto specifico: il divieto assoluto di produrre in appello determinati atti relativi alla legittimità formale dell’atto impositivo. In particolare, il comma 3 del nuovo art. 58 (come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. bb, D.Lgs. 220/2023) stabiliva che “non è mai consentito il deposito” in appello delle deleghe di firma, delle procure e degli altri atti di attribuzione di poteri, rilevanti per la validità della sottoscrizione degli atti impugnati, nonché delle notifiche dell’atto impugnato o degli atti presupposti. Si tratta di documenti che in precedenza spesso venivano prodotti tardivamente dall’Amministrazione o dal contribuente per verificare aspetti formali: ad esempio, la delega di firma del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, oppure le relazioni di notifica delle cartelle di pagamento originarie. La nuova norma intendeva impedire che tali documenti fossero introdotti in appello se non già esibiti in primo grado.
Questa previsione ha sollevato immediate perplessità, perché appariva penalizzante per il diritto di difesa del contribuente. Pensiamo al caso – non raro – in cui solo dopo il primo grado ci si accorga che l’atto impositivo è stato firmato da un funzionario forse non provvisto di valida delega, oppure che la cartella esattoriale originaria non era stata notificata correttamente: secondo la norma riformata, in appello non si sarebbero potute produrre le relative prove (la delega, o gli avvisi di ricevimento) per far valere tali vizi. In pratica, il contribuente sarebbe rimasto privo di uno strumento difensivo essenziale qualora l’irregolarità emergesse tardivamente.
Sulla questione è intervenuta con tempestività la Corte Costituzionale, ripristinando un equilibrio tra esigenze di speditezza e garanzie difensive. Con la sentenza n. 36/2025, depositata il 27 marzo 2025, la Consulta ha dichiarato illegittima quella parte della norma (art. 58, co. 3) che vietava in assoluto la produzione in appello “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti”. Ha inoltre dichiarato incostituzionale la retroattività immediata della nuova disciplina sui giudizi di secondo grado pendenti, modulandone l’applicazione solo ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della riforma. In sostanza, è caduto il divieto di depositare in appello le deleghe di firma, le procure e gli atti relativi alle notifiche: documenti fondamentali per verificare la validità formale dell’atto impositivo possono essere prodotti anche nel giudizio di secondo grado. La Corte ha ritenuto che quella preclusione assoluta comprimisse in modo irragionevole il diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.), specialmente considerando che tali vizi formali spesso emergono solo col tempo o su impulso dello stesso giudice.
Grazie a questa pronuncia, oggi il contribuente mantiene la possibilità di far valere in appello difetti di delega o di notifica, a tutela della legalità dell’azione amministrativa. Va ricordato, infatti, che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un soggetto non autorizzato è causa di nullità dell’atto (art. 42 DPR 600/1973): il Fisco deve provare l’esistenza di una regolare delega di firma se l’accertamento non è firmato dal dirigente titolare. Su questo punto la giurisprudenza ha chiarito che la delega alla firma è una delega di mera funzione interna: non occorre che il provvedimento di delega indichi nome e cognome del delegato né una durata predeterminata, potendo avvenire tramite ordini di servizio generali che individuino il ruolo dell’impiegato autorizzato (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 12916/2024). È però indispensabile, ex post, poter verificare che chi ha firmato l’atto avesse davvero quel potere di firma. Proprio qui si innesta l’intervento della Corte Costituzionale: impedire al contribuente di produrre in appello la delega o la prova della notifica significava, in caso di omissioni in primo grado, cristallizzare potenziali illegittimità senza rimedio. Ora questo ostacolo non c’è più: se tali questioni formali emergono tardivamente, possono essere affrontate e risolte anche in appello, salvaguardando sia la correttezza formale dell’azione fiscale sia il diritto di difesa.
In definitiva, dopo le correzioni della Consulta, la disciplina delle prove in appello tributario è la seguente: nuove prove e nuovi documenti sono ammessi solo se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile, salvo che – ed è l’eccezione voluta dalla Corte – si tratti di documenti relativi a deleghe di firma o notifiche, il cui deposito è sempre consentito se necessario a far valere vizi dell’atto. Il risultato è un appello “a prova dimezzata” rispetto al passato, più simile all’appello civilistico (che limita le nuove prove), ma con un correttivo importante a tutela della legalità degli atti fiscali. Il contribuente dovrà dunque essere diligente nel presentare tutte le prove sin dal primo grado, ma non rischia più di vedersi imposto un atto nullo senza poterlo contestare per un divieto meramente procedurale.
Oltre ai profili probatori, la riforma ha toccato anche altri aspetti del contenzioso tributario, tutti orientati ad una maggiore efficienza e modernità del sistema. Una modifica di rilievo è l’abolizione del reclamo-mediazione obbligatoria per le liti di piccolo valore. Fino al 2023, infatti, il contribuente che intendeva impugnare un atto impositivo di valore fino a 50.000 euro doveva prima presentare un’istanza di reclamo-mediazione all’Agenzia delle Entrate, pena l’inammissibilità del ricorso: un passaggio obbligatorio pensato per favorire la conciliazione e deflazionare le cause. Dal 4 gennaio 2024 questo adempimento non è più richiesto: il reclamo-mediazione è stato abrogato (per i ricorsi notificati da tale data in poi). Ciò significa che, anche per importi modesti, il contribuente può adire direttamente la Corte di Giustizia Tributaria (il nuovo nome delle Commissioni Tributarie) senza attendere i tempi della mediazione. L’obiettivo è snellire e velocizzare il processo: la mediazione obbligatoria, introdotta nel 2012, non aveva prodotto i risultati sperati in termini di accordi conciliativi, trasformandosi spesso in un allungamento dei tempi. Ora la fase amministrativa di reclamo è stata soppressa, fermo restando che resta sempre possibile conciliare la lite in corso di giudizio. Anzi, la riforma ha eliminato il precedente divieto di conciliazione in appello: oggi le parti possono trovare un accordo col fisco in qualsiasi grado del giudizio, anche in secondo grado, con benefici sulle sanzioni (ridotte al 50% in caso di conciliazione raggiunta in giudizio). Dunque, meno formalità precontenzioso e più flessibilità nel definire bonariamente le liti quando conviene a entrambe le parti.
Un’altra innovazione procedurale riguarda il giudice monocratico: per le controversie di valore fino a 3.000 euro (innalzato a 5.000 euro dal 2023), le Corti di Giustizia Tributaria decidono in composizione monocratica (un solo giudice anziché un collegio). Questo mira a velocizzare le cause minori, affidandole a un solo magistrato tributario. Nei ricorsi di maggior valore continua a operare il collegio di tre giudici. Inoltre, è stata istituita la figura del Giudice di pace tributario onorario per smaltire l’arretrato, e sono state create Sezioni specializzate per le liti di valore più elevato, con requisiti di professionalità più stringenti per i giudici tributari.
Sul fronte della giurisprudenza, il biennio 2024–2025 ha visto alcune pronunce di legittimità che confermano o affinano principi fondamentali del diritto tributario processuale. Tra queste, merita attenzione la posizione della Corte di Cassazione in tema di prove acquisite in modo irregolare. A differenza del processo penale, dove vige il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente ottenute (ad es. per violazione di diritti fondamentali), nell’ambito tributario la Cassazione ha più volte ribadito un orientamento diverso: non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite nel processo tributario, salvo che la legge lo preveda espressamente. In una recente decisione, la Corte ha sottolineato che elementi probatori raccolti in modo non conforme alle procedure (ad esempio, documenti ottenuti senza autorizzazione formale) possono comunque essere utilizzati dal Fisco a supporto dell’accertamento, in mancanza di un esplicito divieto normativo (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 8452/2025). Questo significa che un’irregolarità nell’acquisizione della prova non ne comporta automaticamente l’esclusione dal giudizio tributario. La logica sottostante è che prevale l’interesse pubblico alla corretta imposizione dei tributi, per cui un elemento di fatto, ancorché raccolto contra legem in sede amministrativa, può entrare nel processo, fermo restando che il giudice ne valuterà liberamente l’attendibilità e la rilevanza. È bene però precisare che restano inviolabili i diritti fondamentali: se la prova è stata ottenuta in violazione di diritti costituzionalmente garantiti (si pensi a un accesso domiciliare della Guardia di Finanza eseguito senza le prescritte garanzie), allora potrebbero operare limitazioni all’utilizzo, anche alla luce dei principi della CEDU (art. 8, diritto alla vita privata). Ma in via generale, la Corte di Cassazione ha mantenuto ferma la differenza di approccio tra processo penale e tributario: ciò che conta, nel giudizio fiscale, è accertare la realtà sostanziale dell’obbligazione tributaria, anche a costo di dare ingresso a prove “imperfette” dal punto di vista formale. Su questo punto la giurisprudenza di merito si sta adeguando: di recente è stato chiarito, ad esempio, che l’esito di una perquisizione illegale potrà inficiare il processo penale per reati tributari, ma non annulla automaticamente l’accertamento fiscale derivato da quegli elementi (in assenza di una norma che ne sancisca l’inutilizzabilità).
In sintesi, il quadro attuale del processo tributario vede importanti novità favorevoli ai contribuenti – testimonianza scritta ammessa, niente più mediazione obbligatoria, possibilità di contestare vizi formali anche in appello – accompagnate dalla conferma di alcuni principi di rigore propri della materia – come l’ampia utilizzabilità delle prove e la centralità del contraddittorio documentale. Siamo di fronte a un processo tributario “rinnovato”, che cerca un equilibrio tra efficienza e garanzie. Da un lato, si vuole evitare che il giudizio si trasformi in un “secondo accertamento” interminabile: ecco perché si limita l’introduzione di nuove prove tardive e si snelliscono le fasi preliminari. Dall’altro lato, il sistema riconosce che per assicurare una reale giustizia tributaria occorre dare al contribuente tutti gli strumenti per difendersi, compresa la possibilità di far parlare testimoni e di far valere le formae quando incidono sulla validità degli atti.
Conclusione. “La legge è uguale per tutti”, recita il motto presente in ogni aula di tribunale. Nel diritto tributario, questo principio passa anche attraverso regole processuali equilibrate, che garantiscano sia l’efficacia dell’azione accertatrice sia la piena tutela del contribuente. Le novità del 2024 rappresentano un passo avanti in questa direzione: il processo tributario diventa un po’ più umano (ammette la voce, seppur scritta, dei testimoni) e rimane giusto (correggendo norme che rischiavano di penalizzare eccessivamente il contribuente diligente). Sarà interessante osservare come queste innovazioni verranno applicate in concreto nei prossimi anni e se produrranno l’auspicata riduzione dei conflitti e una più rapida soluzione delle liti tributarie. Nel frattempo, per i cittadini e le imprese è fondamentale essere consapevoli di questi cambiamenti, in modo da poterli sfruttare appieno nelle proprie strategie difensive.
Affrontare un accertamento fiscale o una controversia tributaria con le nuove regole richiede competenze aggiornate e strategie mirate. Lo Studio Legale MP di Verona, con esperienza in diritto tributario, è a tua disposizione per assisterti. Se hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o sei coinvolto in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, contattaci senza impegno: analizzeremo il tuo caso alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali (comprese le sentenze Cass. civ., Sez. V, n. 12916/2024, n. 8452/2025 e Corte Cost. n. 36/2025 citate) e ti aiuteremo a scegliere la strategia difensiva più efficace.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.