

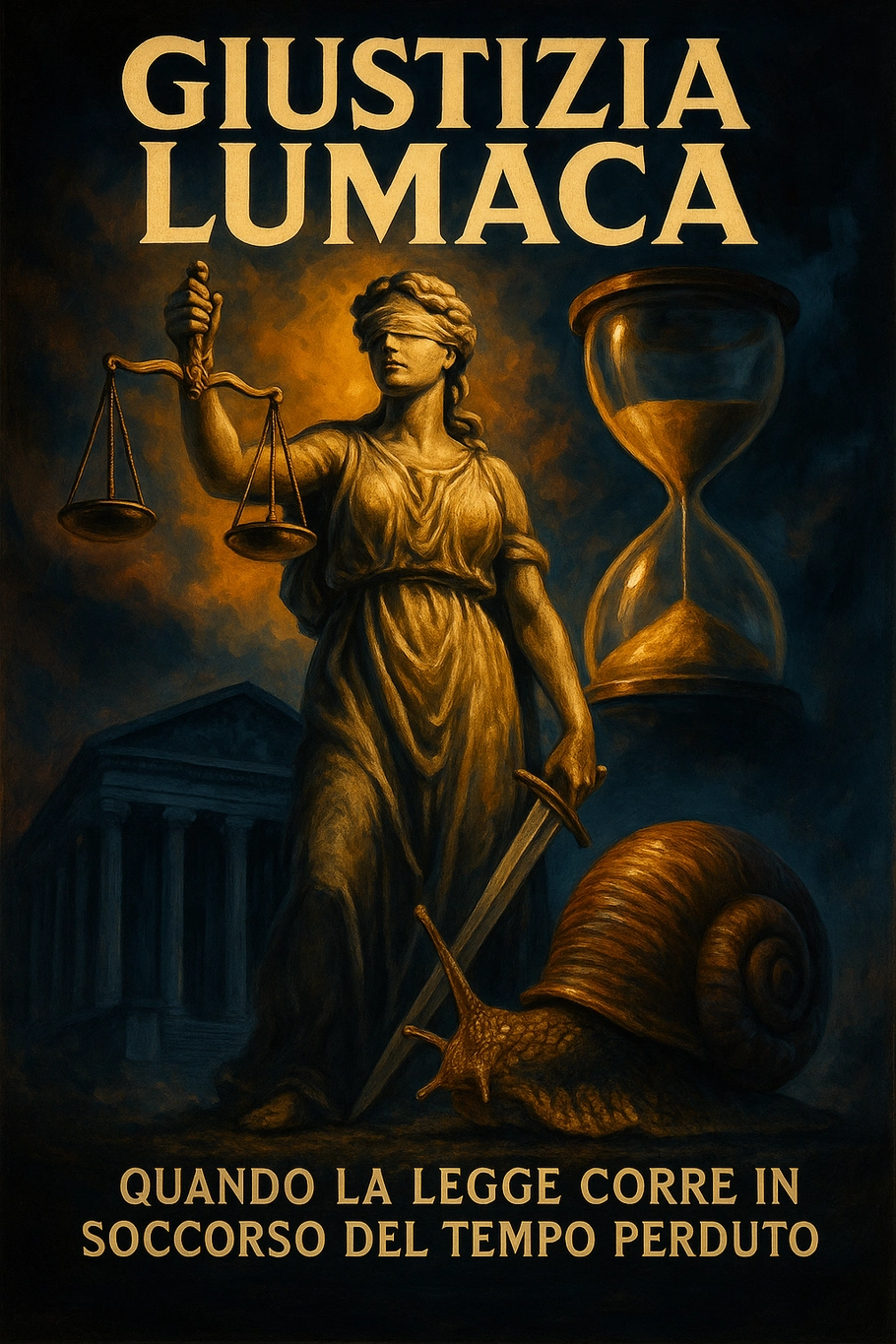
Ogni persona ha diritto a un processo che si concluda in tempi ragionevoli. Questo principio è sancito sia dall’art. 6 della Convenzione EDU (diritto a un equo processo entro un termine ragionevole) sia dall’art. 111 della Costituzione italiana, che dal 1999 assicura la “ragionevole durata” come requisito fondamentale di ogni procedimento. Nonostante tali proclamazioni di principio, l’Italia per decenni ha sofferto il cronico problema dei processi lumaca, con ritardi endemici in sede civile, penale e amministrativa. Questa lentezza ha portato a numerose condanne dello Stato italiano da parte della Corte di Strasburgo, nell’ottica del noto adagio secondo cui giustizia tardiva equivale a giustizia negata. Per porre rimedio interno a tali violazioni, il legislatore ha introdotto la legge Pinto (legge 24 marzo 2001 n. 89), che ha istituito una procedura ad hoc per compensare – in forma di indennizzo monetario – il pregiudizio subito da chi è rimasto invischiato in un procedimento eccessivamente lungo. In altre parole, la legge Pinto non accelera i processi ma consente alla parte lesa di ottenere un risarcimento ex post per il danno (morale ed eventualmente patrimoniale) derivante dall’attesa protratta. Si tratta di una valvola di sfogo nazionale che evita di dover ricorrere direttamente alla Corte EDU: lo Stato ammette la propria responsabilità per il ritardo, riconosce al cittadino un equo indennizzo e in tal modo cerca di ristabilire fiducia nella giustizia, dando sostanza al detto “summum ius, summa iniuria” (la massima giustizia formale può diventare massima ingiustizia, specie se ottenuta fuori tempo massimo).
Non ogni ritardo processuale legittima un indennizzo automatico. La legge Pinto fissa parametri temporali ben precisi oltre i quali la durata del processo si presume irragionevole. In generale, un procedimento eccede il termine ragionevole se supera: 3 anni per il primo grado di giudizio (tribunale o giudice di pace), 2 anni per l’appello e 1 anno per il giudizio di Cassazione. Esistono termini differenti per procedimenti speciali e situazioni particolari: ad esempio 6 anni sono considerati ragionevoli per un’intera procedura fallimentare (dato il coinvolgimento di più parti e fasi) e 3 anni per un processo esecutivo. Inoltre – elemento cruciale – la normativa prevede un tetto massimo complessivo: se l’intero procedimento si conclude con decisione definitiva entro 6 anni (sommando tutte le fasi), non sorge diritto ad indennizzo neppure se qualche grado ha sforato i limiti singoli. Questa sorta di “franchigia” generale (i 6 anni totali) vuole evitare risarcimenti in casi in cui il processo, pur con qualche lentezza, non è durato in modo abnorme nel suo insieme. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di tale limite, dichiarando non fondate le questioni di illegittimità sull’art. 2, comma 2-bis L. 89/2001 nella parte in cui fissa il termine di sei anni come soglia massima (Corte cost., sent. n. 102/2025).
Nel valutare la durata effettiva di un procedimento, si escludono dal conteggio alcuni periodi “morti” o comunque non imputabili allo Stato. In particolare, non si considerano le sospensioni previste ex lege (es: processo sospeso in attesa di altro giudizio), i rinvii richiesti dalle parti o i ritardi deliberatamente causati dall’istante stesso. Chi provoca dilazioni nel procedimento non può poi lamentarsene ai fini dell’equa riparazione. Ad esempio, un avvocato che abbia chiesto un rinvio aderendo a uno sciopero forense non vedrà conteggiato quel periodo di fermo, trattandosi di un ritardo imputabile alla sua parte. In sintesi, la “lumaca” della giustizia viene misurata sul tempo effettivo impiegato dallo Stato per giungere a una decisione definitiva, al netto di pause fisiologiche o stratagemmi dilatori delle parti. Ciò che conta è il ritardo ingiustificato ascrivibile all’apparato giudiziario, rispetto ai parametri di legge.
Quando un processo di merito si conclude (con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo), la parte che ha subito il lungo iter deve attivarsi con sollecitudine per far valere il proprio diritto all’equa riparazione. La legge Pinto impone infatti un termine di decadenza di 6 mesi: il ricorso va presentato, pena l’improcedibilità, entro sei mesi da quando la decisione finale è diventata definitiva. In pratica, il countdown inizia dal passaggio in giudicato della sentenza (o decreto) che ha definito il procedimento “lumaca”. Oltre questa finestra semestrale, si perde il diritto all’indennizzo. È bene sottolineare che – per garantire effettività alla tutela – la decorrenza dei sei mesi parte dal momento in cui la parte ha avuto formale conoscenza della conclusione del giudizio (notifica o comunicazione della sentenza), come precisato dalla giurisprudenza costituzionale. Dunque, anche se una sentenza è formalmente definitiva da una certa data, il termine per agire ex L. 89/2001 scatta solo dalla notifica o comunicazione che la rende nota alla parte interessata.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso introduttivo depositato presso la Corte d’Appello competente, di regola quella del distretto dove si è svolto il primo grado del processo presupposto. Non è ammessa la procedura “fai da te”: trattandosi di un procedimento giurisdizionale, è necessario farsi assistere da un avvocato (munito di procura alle liti). Chi ha i requisiti economici può eventualmente richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Va notato che lo Stato, riconoscendo la natura “riparatoria” dell’azione, esonera dal contributo unificato: il ricorso Pinto è esente dal pagamento delle normali tasse giudiziarie che si versano per avviare una causa civile, restando a carico del ricorrente solo le spese vive di notifica (poche decine di euro) e naturalmente l’onorario del legale. La trattazione è abbastanza snella: la Corte d’Appello designa un magistrato relatore, il quale in molti casi decide con decreto motivato (anziché con sentenza), salvo poi la possibilità per la parte soccombente di fare opposizione al decreto. L’intero procedimento dovrebbe svolgersi in tempi brevi (la legge teoricamente parla di 30 giorni per decidere); in caso di accoglimento, il decreto ingiunge al Ministero competente il pagamento di una certa somma a titolo di indennizzo, oltre alla liquidazione delle spese legali.
Chi può agire per chiedere l’indennizzo Pinto? Tutti i soggetti che erano formalmente parti del processo di durata irragionevole e ne hanno subito le conseguenze. Sono inclusi ovviamente gli attori e i convenuti in un giudizio civile, l’imputato in un processo penale (anche se condannato, perché il diritto alla ragionevole durata prescinde dall’esito), la parte civile, gli intervenienti volontari o ad adiuvandum, i ricorrenti e resistenti nei procedimenti amministrativi, e così via. Conta la partecipazione al processo: se hai avuto lo status di parte nel procedimento “lumaca”, hai potenzialmente diritto all’equa riparazione indipendentemente da come è andata a finire la causa. Perfino gli eredi di una parte deceduta nel corso (o dopo la fine) del processo possono subentrare: il diritto all’equa riparazione, infatti, si trasmette iure hereditatis e può essere esercitato dagli aventi causa del soggetto leso. Si pensi al caso di Tizio che muore dopo una lunga vicenda giudiziaria non ancora indennizzata – i figli o successori potranno presentare ricorso Pinto in suo nome.
Un aspetto procedurale delicato – frutto delle riforme degli ultimi anni – è la condizione dei “rimedi preventivi”. La normativa attuale obbliga le parti ad attivarsi durante il processo lento per sollecitarne la definizione, altrimenti si rischia di perdere il diritto all’indennizzo. In particolare, le modifiche introdotte nel 2012 e, soprattutto, con la L. 208/2015 (in vigore dal 31 ottobre 2016) prevedono che, prima di poter lamentare ufficialmente la durata irragionevole, la parte interessata debba aver compiuto almeno un’azione acceleratoria nel corso di quel giudizio. Cosa significa in concreto? Che il cittadino non può restare del tutto passivo e poi, a fine processo, “lucrare” l’indennizzo: deve dimostrare di aver tentato di accelerare i tempi. Ad esempio, nei procedimenti civili bisogna aver richiesto il passaggio al rito sommario di cognizione o aver depositato un’istanza di decisione immediata ex art. 281-sexies c.p.c.; nel processo penale occorre presentare un’istanza di accelerazione al giudice; nel processo amministrativo è necessario proporre la famosa istanza di prelievo al TAR (richiesta di fissazione dell’udienza). Tali istanze vanno inoltrate prima che il processo ecceda i termini di durata ragionevole – indicativamente almeno 6 mesi prima dello scadere del triennio in primo grado, del biennio in appello, ecc. Se il procedimento è iniziato (o proseguito) oltre il 31/10/2016 ed è divenuto eccessivamente lungo, il mancato utilizzo dei rimedi preventivi comporta l’improcedibilità della domanda di indennizzo. Dura lex, sed lex: la logica (severa) è stimolare le parti a non dormire sui propri diritti durante il processo, pena l’inammissibilità di richieste risarcitorie a posteriori.
Tuttavia, questo meccanismo ha sollevato dubbi di ragionevolezza in alcuni casi, specie quando il “rimedio” richiesto si rivela di fatto inutile. Emblematico è il caso dell’istanza di accelerazione in Cassazione: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 142/2023, l’ha dichiarata illegittima come condizione di ammissibilità del Pinto, poiché un’istanza di sollecitazione in Cassazione non incide realmente sui tempi decisionali della Suprema Corte (che segue il suo ruolo secondo criteri propri). In altre parole, non si può negare il risarcimento se l’unica azione preventiva esigibile era un adempimento inefficace. La Consulta ha precisato che la mancata presentazione di richieste acceleratorie potrà semmai influire sul quantum dell’indennizzo (ad esempio segnalando uno scarso interesse della parte a una definizione rapida), ma non può precludere del tutto il diritto alla riparazione. Al di là di questo intervento mirato, l’obbligo di attivismo processuale resta negli altri casi: ad esempio, la Cassazione ha stabilito che perfino nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace – spesso di modesta entità – la parte deve aver presentato un’istanza di sollecita trattazione se poi vorrà accedere alla legge Pinto. In definitiva, chi subisce un processo lungo deve dimostrare di aver fatto la propria parte per sollecitarlo; solo così potrà bussare a quattrini allo Stato senza sentirsi opporre di aver colpevolmente “dormito” durante la causa.
Ottenere l’equa riparazione per un processo eccessivamente lungo significa anche chiedersi: a quanto ammonta il risarcimento? La legge Pinto fornisce alcuni parametri monetari ben delineati. L’art. 2, comma 1-bis L. 89/2001 stabilisce che l’indennizzo non può essere inferiore a €400 né superiore a €800 per ogni anno di ritardo oltre la soglia di ragionevolezza (considerando come anno anche la frazione di anno superiore a sei mesi). In pratica, per un processo durato, poniamo, 3 anni oltre il termine ragionevole, la parte lesa può ottenere tra un minimo di circa €1.200 e un massimo di €2.400. Questa forbice risarcitoria relativamente contenuta è stata introdotta dalla riforma del 2016, che ha di fatto ridotto i massimali rispetto agli importi riconosciuti in passato dalla giurisprudenza europea (la Corte EDU in origine liquidava anche cifre intorno ai €1.500 per anno di ritardo). Oggi il range è dunque 400-800 euro annui, ma il giudice determina la somma concreta caso per caso entro tali limiti, valutando criteri equitativi: l’esito e la natura del processo presupposto, il comportamento del giudice e delle parti, il valore economico e l’importanza per il danneggiato, l’eventuale particolare sofferenza patita per l’attesa. Ad esempio, un grave reato prescritto per eccessiva durata può rappresentare per la vittima un danno morale più acuto (sensazione di giustizia negata) rispetto a un banale litigio civile tra privati: queste differenze possono riflettersi sul quantum liquidato.
Va aggiunto che la legge prevede meccanismi di aumento progressivo dell’indennizzo per i ritardi eccezionalmente prolungati. In particolare, oltre il terzo anno oltre soglia, l’importo per ciascun anno ulteriore può essere incrementato fino al +20%; oltre il settimo anno aggiuntivo, l’incremento può arrivare al +40% per ogni anno in più. Si riconosce così che i ritardi molto lunghi aggravano esponenzialmente il patimento della parte: dopo molti anni di attesa, l’ansia e lo stress accumulati crescono, e la risposta risarcitoria viene adeguata di conseguenza. Viceversa, in presenza di cause di scarso valore o in cui la parte non abbia subìto un gran pregiudizio (magari perché nel frattempo ha ottenuto un risultato alternativo), la giurisprudenza considera la possibilità di liquidare l’indennizzo in misura ridotta, o perfino simbolica in taluni casi estremi. Ad esempio, se il processo “lumaca” verteva su una controversia bagatellare di infimo interesse pratico, oppure se la parte ha già ricevuto soddisfazione durante l’attesa (transazioni, pagamenti spontanei, ecc.), il giudice Pinto potrebbe riconoscere un risarcimento minimo o respingere la domanda per mancata prova del danno. In generale, comunque, il danno morale da ritardo è presunto in re ipsa (si assume che l’attesa prolungata causi ansia, frustrazione, incertezza), dunque spetta allo Stato eventualmente dimostrare che nel caso concreto quel pregiudizio è mancato o è irrisorio. Oltre al danno non patrimoniale (morale), il ricorrente può chiedere di essere risarcito anche del danno patrimoniale eventualmente sofferto a causa del ritardo, ma qui serve una prova rigorosa: ad esempio, si potrebbe provare di aver sostenuto spese legali aggiuntive per colpa delle dilazioni, oppure di aver perso opportunità economiche (clienti, investimenti) a causa dell’incertezza prolungata. In assenza di prove specifiche di danno economico, verrà comunque riconosciuto l’indennizzo standard per il danno non patrimoniale da irragionevole durata.
A distanza di oltre vent’anni dall’entrata in vigore, la legge Pinto è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità, che ne hanno delineato confini e condizioni applicative. Negli anni 2024–2025 in particolare sono emerse decisioni di rilievo che vale la pena evidenziare, poiché chiariscono aspetti peculiari e risolvono contrasti interpretativi.
Soggetti legittimati all’indennizzo: con l’ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 34183/2024 (23 dicembre 2024) la Corte di Cassazione ha affermato un principio inclusivo sulla legittimazione attiva. È stato chiarito che anche il soggetto intervenuto adesivamente dipendente in un processo (cioè colui che si inserisce nel giudizio sostenendo le ragioni di una delle parti originarie, senza domanda autonoma) ha diritto a chiedere l’equa riparazione se il processo è durato oltre il ragionevole. Questo perché il pregiudizio da ritardo eccessivo si collega alle sofferenze e allo stress subiti per la lunga attesa, e tali effetti colpiscono chiunque abbia partecipato alla causa, ancorché con posizione subordinata. L’interveniente, pur non titolare di una domanda propria, acquisisce la qualità di parte del procedimento e dunque ha diritto a una definizione del giudizio in tempi ragionevoli al pari degli altri (principio già sotteso in precedenza, ora ribadito espressamente).
Limiti soggettivi – il caso dell’avvocato “antistatario”: la Cassazione ha invece escluso il diritto all’indennizzo in capo a soggetti che non rivestono formalmente la parte sostanziale nel giudizio. Una situazione esemplare è quella dell’avvocato distrattario delle spese (detto anche antistatario). Si tratta del difensore che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., ha chiesto la distrazione delle spese di lite a proprio favore: in pratica il legale ottiene di essere liquidato direttamente dalla parte soccombente, diventando creditore delle spese processuali. Ebbene, con ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 6070/2025 (depositata il 6 marzo 2025) la Suprema Corte ha negato l’indennizzo a un avvocato che, in qualità di procuratore antistatario, lamentava la lungaggine di un processo in cui aveva operato. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’avvocato che ottiene le spese in via distratta non assume la qualità di parte nel merito della causa (che appartiene sempre al cliente rappresentato) e soprattutto la sua istanza di distrazione è un elemento accessorio del giudizio, privo di autonomia sul piano del diritto sostanziale. Dunque, anche se il legale agisce “in proprio” limitatamente alla questione delle spese, ciò non lo abilita a chiedere il risarcimento Pinto per la durata del processo del suo assistito. In altre parole, il diritto all’equa riparazione spetta al cliente, parte sostanziale lesada dal ritardo, e non può essere rivendicato dall’avvocato per il solo fatto di aver atteso a lungo la definizione della causa altrui. Questo orientamento – conforme alla giurisprudenza costante – sottolinea anche un profilo deontologico: chi esercita la professione forense come antistatario non può cercare un doppio beneficio (spese liquidate e indennizzo di Stato) da un medesimo processo tardivo.
“Pinto su Pinto” e calcolo della durata nei ricorsi di equa riparazione: paradossalmente, anche le stesse cause Pinto a volte subiscono ritardi, generando ulteriori richieste di indennizzo (il fenomeno della causa Pinto sulla precedente causa Pinto). Su questo tema la Cassazione è intervenuta per eliminare alcuni dubbi sul computo dei tempi. In particolare, l’ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 18317/2024 (4 luglio 2024) ha chiarito come determinare la “ragionevole durata” di un giudizio di equa riparazione in sé considerato. La Corte d’Appello di merito, nel caso esaminato, aveva ritenuto ragionevole un anno più un ulteriore periodo di circa sei mesi (concesso alla Pubblica Amministrazione per pagare l’indennizzo dovuto dopo la decisione). La Cassazione ha corretto questo approccio: nel giudizio Pinto, la procedura si articola in due fasi (fase di cognizione e fase di esecuzione del decreto), ma ai fini del calcolo del ritardo deve considerarsi rigidamente un anno come durata ragionevole complessiva del grado di merito. Il lasso di tempo aggiuntivo concesso allo Stato per effettuare il pagamento (spatium adimplendi) non va sommato come se fosse durata “virtuosa” del processo. Pertanto, se un ricorso Pinto tra definizione e pagamento impiega ad esempio 18 mesi totali, la parte eccedente l’anno va considerata ritardo indennizzabile, senza poter detrarre un ulteriore semestre di tolleranza. In sintesi, la Cassazione ha affermato che il periodo dato all’Amministrazione per eseguire il pagamento non dilata il termine di ragionevole durata del giudizio di equa riparazione stesso. Questa precisazione mira a evitare interpretazioni restrittive che penalizzerebbero il cittadino: anche i ritardi nelle procedure Pinto (che dovrebbero essere rapide per natura) danno luogo a risarcimento, e gli artifici contabili non possono ridurre il conteggio dell’attesa subìta.
Interventi del giudice delle leggi: oltre alle pronunce di legittimità ordinaria, come già accennato, la Corte Costituzionale ha recentemente esaminato varie questioni sulla legge Pinto, confermando in parte l’impianto normativo e in parte eliminando alcune rigidità. Abbiamo citato la sentenza n. 142/2023 che ha eliminato l’istanza di accelerazione in Cassazione quale condizione di procedibilità, e la sentenza n. 102/2025 che ha confermato la validità del “tetto” dei 6 anni per le procedure concorsuali. In altra decisione (Corte cost. n. 205/2023) la Consulta ha ritenuto non irragionevole applicare i limiti di durata standard anche ai giudizi in materia di protezione internazionale (ribadendo che 3 anni per il primo grado sono un termine ragionevole anche per cause delicate come quelle sui rifugiati). Insomma, il giudice costituzionale ha finora respinto i principali dubbi di costituzionalità sulla legge Pinto, pur richiamando il legislatore a garantire rimedi effettivi e pagamenti tempestivi. Del resto, come osservava amaramente anche lo scrittore Pino Caruso, «Una giustizia lenta fa più danni della criminalità»: è compito dell’ordinamento trovare un equilibrio tra l’esigenza di non lasciare impuniti i ritardi e la sostenibilità del sistema.
Un capitolo di attualità merita attenzione: lo Stato italiano negli ultimi anni si è trovato ad affrontare non solo l’eccessiva durata dei processi, ma anche i ritardi nei pagamenti degli indennizzi Pinto stessi. Si è creato infatti un arretrato di migliaia di ricorsi Pinto pendenti e decreti già emessi ma non ancora liquidati, con conseguenti ulteriori aggravi (interessi moratori, nuove azioni esecutive contro lo Stato, ecc.). Per fronteggiare questa situazione paradossale (risarcimenti per ritardi erogati in ritardo!), il Ministero della Giustizia ha lanciato nel 2025 un progetto straordinario denominato “PintoPaga”.
Questa iniziativa – introdotta con la Legge di Bilancio 2025 – si propone di azzerare entro due anni l’arretrato formatosi nelle Corti d’Appello sul fronte equa riparazione. In cifre, si parla di circa 80.000 domande di indennizzo riferite a ritardi accumulati tra il 2015 e il 2022, per un debito stimato intorno ai 400 milioni di euro a carico dello Stato. Il piano PintoPaga prevede una procedura digitalizzata e semplificata: i difensori delle parti che hanno ricorsi pendenti sono invitati a inserire le istanze su una piattaforma online (portale Siamm – Pinto) entro una data prefissata (inizialmente 30 giugno 2025, poi prorogata). Le domande caricate sul portale vengono trattate in ordine cronologico mediante una task force amministrativa, con l’obiettivo di emettere i decreti di accoglimento e disporre i pagamenti entro la fine del 2025 (termine prorogabile al 2026 per le situazioni più complesse). Si tratta di un procedimento “fuori ruolo” rispetto al circuito ordinario delle Corti d’Appello, finanziato con fondi straordinari, che mira a indennizzare rapidamente migliaia di cittadini e imprese senza attendere i tempi delle udienze tradizionali. I primi risultati di PintoPaga sono incoraggianti: già nei primi mesi del 2025 molte pratiche sono state liquidate in via telematica, riducendo il monte arretrato. Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini degli Avvocati hanno invitato i professionisti a utilizzare senza esitazioni tale strumento, poiché rappresenta una via breve e certa al soddisfacimento dei crediti da equa riparazione. Contestualmente, per consentire l’efficacia del progetto, la legge finanziaria ha disposto una temporanea sospensione dei giudizi Pinto in corso (soprattutto appelli e opposizioni) fino a conclusione del PintoPaga: una misura su cui anche il Consiglio di Stato ha chiesto chiarimenti interpretativi, ma che nelle intenzioni serve a concentrare gli sforzi sullo smaltimento straordinario. In definitiva, PintoPaga è una risposta amministrativa all’annoso problema dei ritardi della giustizia: un modo per “mettere in pari” i risarcimenti dovuti e voltare pagina, nella speranza che per il futuro i nuovi processi rispettino di per sé la ragionevole durata, rendendo sempre meno necessario il ricorso alla legge Pinto.
La legge Pinto si conferma dunque uno strumento essenziale per tutelare cittadini e imprese di fronte alla patologia della giustizia lenta. In un sistema ideale, non ci sarebbe bisogno di risarcire alcunché perché ogni processo si concluderebbe entro tempi accettabili. Ma in attesa di un’efficienza piena, l’equa riparazione costituisce un riconoscimento tangibile del torto subìto e uno stimolo a migliorare. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni mostra un duplice sforzo: da un lato, rendere più effettivo e accessibile il rimedio Pinto per chi ha diritto (allargando le maglie a tutti i partecipanti lesi e affinando il calcolo degli indennizzi); dall’altro, introdurre meccanismi per prevenire nuovi ritardi (rimedi acceleratori obbligatori, progetti di smaltimento come PintoPaga) e per responsabilizzare le parti e l’amministrazione. Il messaggio è chiaro: la giustizia ha un costo quando arriva tardi, costo che lo Stato deve pagare a chi ne ha sopportato il peso. Allo stesso tempo, si cerca di evitare abusi e rendite di posizione, pretendendo un minimo di diligenza processuale da parte degli interessati. In definitiva, “giustizia lumaca” e “giustizia negata” non devono diventare sinonimi: l’ordinamento offre rimedi e compensazioni per scongiurare che un ritardo cancelli i diritti.
Se ritieni che un tuo procedimento si sia protratto oltre ogni ragionevole limite e vuoi sapere come far valere i tuoi diritti in base alla legge Pinto, il nostro Studio è a tua disposizione. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata: valuteremo insieme la tua situazione e ti aiuteremo a ottenere il giusto indennizzo per il tempo perduto. La giustizia può essere lenta, ma con il supporto legale adeguato non resterai senza tutela – “fiat iustitia, ruat caelum”, sia fatta giustizia (anche se cadessero i cieli)!

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.