

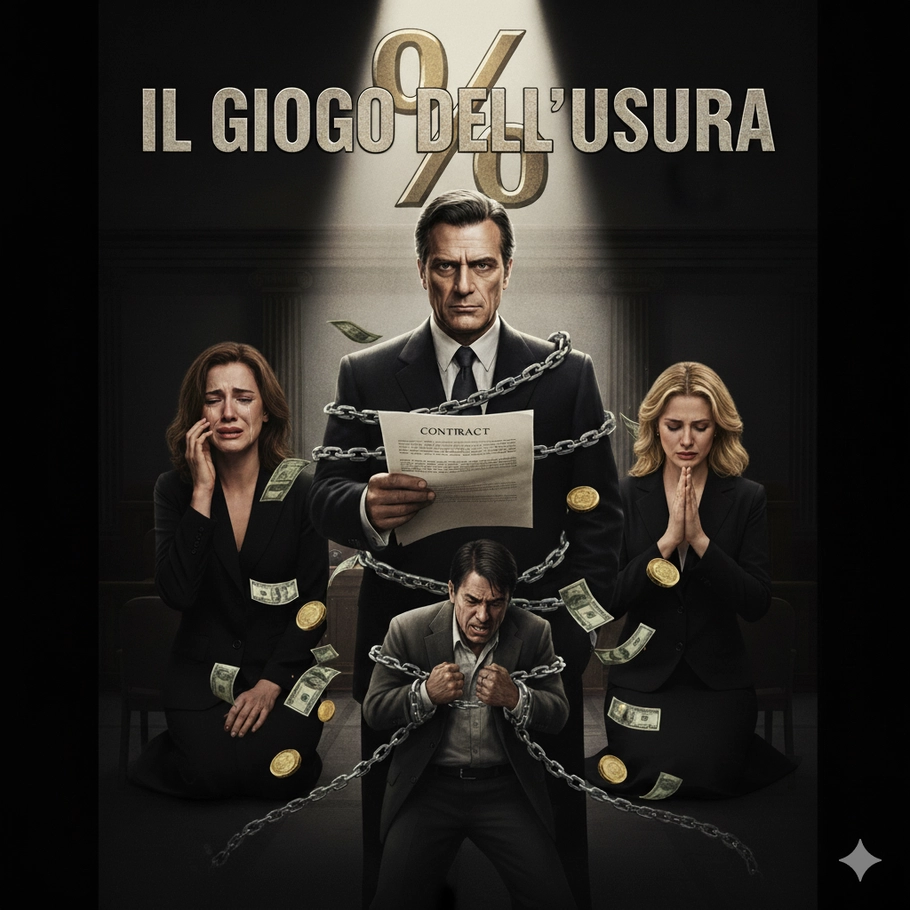
Quando si parla di usura bancaria nei mutui, si fa riferimento a interessi sproporzionati che superano i limiti imposti dalla legge. In Italia, la Legge n. 108/1996 ha introdotto criteri precisi per individuare la soglia oltre la quale gli interessi diventano usurari. Questa soglia d’usura viene determinata trimestralmente dal Ministero, basandosi sui tassi medi praticati dalle banche e aumentandoli di un margine. Se il tasso effettivo globale (TEG) del mutuo eccede tale soglia, la clausola di interessi è considerata nulla per usurarietà. La conseguenza, ai sensi dell’art. 1815 c.c., è drastica: il debitore non è tenuto a pagare alcun interesse, restituendo solo il capitale. In altre parole, un mutuo usurario perde per legge tutti gli interessi, trasformandosi in un prestito a tasso zero.
È importante distinguere due situazioni: l’usura originaria (o contrattuale) e l’usura sopravvenuta. L’usura originaria sussiste quando il tasso degli interessi, già al momento della stipula del contratto, supera la soglia legale: in tal caso si applica la sanzione di nullità degli interessi. L’usura sopravvenuta, invece, si verifica se gli interessi pattuiti, inizialmente sotto soglia, la oltrepassano nel corso dell’esecuzione del contratto a causa di variazioni dei tassi soglia nel tempo. Su questo secondo tipo di usura la giurisprudenza è intervenuta per chiarire che non comporta l’azzeramento degli interessi: una volta valido il tasso iniziale, il successivo innalzamento dei tassi medi non rende illecito quanto concordato in origine. Pacta sunt servanda – gli accordi vanno rispettati – anche se il mutuo, col passare del tempo, diventa più oneroso rispetto ai parametri aggiornati.
Un tema centrale nell’analisi dell’usura nei mutui riguarda quali oneri e spese debbano essere inclusi nel calcolo del tasso effettivo ai fini del confronto con la soglia usuraria. Le banche spesso sostengono che alcune spese “accessorie” – come i premi assicurativi collegati al finanziamento – possano essere escluse dal computo del TAEG/TEG ai fini dell’usura, in modo da mantenere il tasso apparente entro i limiti di legge. Su questo punto è intervenuta di recente la Cassazione civile con orientamenti chiari a tutela dei clienti.
In particolare, la Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15114/2025 (depositata il 6 giugno 2025) ha ribadito con forza un principio fondamentale: tutti i costi collegati all’erogazione del credito devono essere considerati nel calcolo del tasso usurario, nessuno escluso, comprese le polizze assicurative sottoscritte contestualmente al prestito. Fanno eccezione soltanto imposte e tasse, che per legge non rientrano nel TAEG. La Suprema Corte, con questa sentenza, ha richiamato l’attenzione sul comportamento di alcuni intermediari finanziari che continuavano a escludere il costo delle assicurazioni dal computo dell’indice di usura, nonostante numerose pronunce avessero già affermato il contrario. Ora la Cassazione conferma in modo definitivo che tali costi “occulti” – ad esempio la polizza sulla vita spesso abbinata alla cessione del quinto – contribuiscono a far lievitare il tasso effettivo: se sommati agli interessi, potrebbero far superare la soglia.
Questo significa che chi ha sottoscritto un mutuo o prestito con polizza obbligatoria potrebbe scoprire che, includendo il premio assicurativo nel TEG, il tasso totale pattuito risulta usurario. In tal caso il finanziamento è da considerarsi gratuito quanto a interessi. La Cassazione ha così fornito un’arma in più ai debitori: un mutuatario che sospetta l’usurarietà del proprio contratto deve far ricalcolare il TAEG comprensivo di ogni spesa (istruttoria, commissioni, assicurazioni, intermediazioni) e confrontarlo con i tassi soglia vigenti all’epoca della stipula. Se il tasso reale eccede il limite, scatta la tutela antiusura e il debitore ha diritto a restituire solo il capitale senza interessi, oltre eventualmente a recuperare quelli già corrisposti. Si tratta di un importante consolidamento della tutela del consumatore, volto a contrastare prassi poco trasparenti: ogni costo legato all’ottenimento del credito, anche se mascherato da servizio accessorio, incide sul costo effettivo del denaro preso a prestito e non può essere ignorato.
Accanto alla questione dei costi occulti, le ultime sentenze hanno affrontato nuovamente il tema dell’usura sopravvenuta nei contratti di mutuo, in particolare nei finanziamenti a rata costante con ammortamento “alla francese”. In questo tipo di piani di rimborso, molto diffusi, le rate sono di importo costante ma composte da una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente: ciò implica un meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi su base periodica. Alcuni debitori hanno contestato tali contratti sostenendo che la mancata esplicitazione nel contratto della formula di ammortamento impiegata (francese vs. italiano) e del regime di capitalizzazione degli interessi costituisca una violazione della trasparenza, oltre a poter generare usura nel corso del rapporto.
La Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 18838/2025 (10 luglio 2025) è intervenuta su questo tema, fornendo due importanti precisazioni. Primo: ha confermato l’orientamento secondo cui l’usura sopravvenuta non travolge la validità della clausola di interessi. Se il tasso contrattuale era lecito alla stipula, il fatto che durante il rapporto superi la soglia d’usura (perché magari i tassi medi di mercato sono calati) non rende illegittimo il patto iniziale né comporta la nullità o modifica della clausola. In breve, un tasso non usurario in origine resta tale per l’ordinamento anche se diventa superiore al limite in un momento successivo. Chi presta denaro, quindi, può continuare a esigere gli interessi pattuiti, e ciò non è considerato abuso né mala fede contrattuale solo per il sopraggiunto mutamento dei parametri normativi. La Corte richiama espressamente una sua decisione a Sezioni Unite del 2017 su questo punto, che aveva chiuso un dibattito giurisprudenziale: l’usura si valuta al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, non di volta in volta durante l’esecuzione.
In secondo luogo, la Cassazione ha affrontato la questione dell’ammortamento alla francese. Alcuni mutuatari lamentavano che nei loro contratti non fosse specificato esplicitamente che il piano di rimborso adottava questo metodo (che comporta interessi calcolati sul capitale residuo con capitalizzazione periodica). La mancanza di tale indicazione, a loro avviso, rendeva il contratto indeterminato nell’oggetto o contrario alle regole di trasparenza bancaria, al punto da richiederne la nullità parziale o la rinegoziazione. La Suprema Corte, richiamando anche un recente arresto delle Sezioni Unite del 2024, ha respinto queste pretese: la mancata indicazione espressa della modalità di ammortamento “francese” e del regime di capitalizzazione degli interessi non determina nullità del contratto di mutuo, né per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria. In sostanza, se il tasso nominale e le condizioni economiche essenziali sono chiaramente indicate, il fatto che il piano di calcolo degli interessi sia complesso o non esplicitato non invalida il contratto. Non è richiesto che il documento contrattuale contenga una lezione di matematica finanziaria sul calcolo delle rate: basta che il cliente conosca il tasso applicato e l’importo delle rate. Dunque, un mutuo con ammortamento alla francese non può essere annullato solo perché non spiegava la formula, a patto che gli interessi rientrino nei limiti di legge e le rate siano quelle concordate.
Questa pronuncia chiude definitivamente uno spiraglio che alcuni debitori speravano di utilizzare per far dichiarare nullo il calcolo degli interessi composti: la Cassazione ha chiarito che così non è. Pertanto, chi ha sottoscritto mutui a rata costante non può ottenere l’annullamento degli interessi sostenendo di non aver compreso il meccanismo finanziario, salvo naturalmente i casi di usurarietà originaria o altri vizi specifici. Per i mutuatari resta comunque fondamentale, prima di firmare, comprendere bene il piano di ammortamento, magari avvalendosi di un consulente, per evitare sorprese sull’ammontare degli interessi totali pagati nel tempo.
Una delle novità più rilevanti emerse dalle sentenze recenti riguarda il riparto dell’onere probatorio nelle cause di accertamento dell’usura. Spesso il debitore, convinto che il proprio finanziamento sia usurario, propone opposizione contro la banca (ad esempio resistendo a un decreto ingiuntivo o chiedendo la restituzione di interessi pagati). Ma quali elementi deve fornire chi allega l’usura? E spetta al cliente dimostrare che il tasso supera la soglia, o alla banca provare il contrario? Su questo punto la Cassazione è intervenuta per fugare ogni dubbio, con un principio netto che incide direttamente sulla strategia processuale di chi vuole far valere la nullità degli interessi usurari.
Con l’ordinanza n. 5709/2025 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un fideiussore che, opponendosi al pagamento di un mutuo garantito, aveva sollevato eccezione di usura senza fornire dettagli sufficienti. La Cassazione ha colto l’occasione per delineare chiaramente le regole dell’onere della prova in materia di usura bancaria: “onus probandi incumbit ei qui asserit” – l’onere della prova grava su chi afferma il fatto. In altre parole, è il debitore (o il garante) che denuncia l’usurarietà a doverla provare in modo puntuale. Ciò significa anzitutto un onere di allegazione specifica: non basta dichiarare genericamente “il tasso è oltre soglia”, ma occorre indicare con precisione nel proprio atto difensivo quali tassi di interesse sono stati applicati, quale fosse la soglia d’usura vigente nei periodi considerati e in quali trimestri o anni si è verificato il superamento. Deve insomma essere costruito un quadro chiaro, numeri alla mano, dell’andamento dei tassi e del momento esatto in cui si sarebbe oltrepassato il limite legale. Solo dopo aver allegato questi fatti in modo dettagliato, il debitore può passare alla fase della prova vera e propria, ad esempio depositando perizia econometrica, contratti e decreti ministeriali sui tassi soglia.
La Corte ha chiarito che se manca questa specifica allegazione iniziale, la questione dell’usura non può nemmeno essere esaminata nel merito. Il giudice, infatti, non è tenuto a supplire alle carenze dell’attore: se chi agisce non indica esattamente i dati, la sua eccezione risulta generica e viene dichiarata inammissibile. Nel caso concreto, il fideiussore opponente si era limitato a invocare l’applicazione di tassi usurari, senza specificare i valori soglia né fornire un raffronto periodo per periodo; la Cassazione ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto l’eccezione proprio per la sua genericità. Inoltre, la Suprema Corte ha ricordato che i decreti ministeriali trimestrali sui tassi soglia, pur avendo natura normativa secondaria, devono essere prodotti in giudizio dalla parte che intende giovarsene: non possono essere invocati se non sono stati allegati agli atti, a meno che il giudice non scelga discrezionalmente di acquisirli d’ufficio. Questo aspetto rafforza ulteriormente la necessità per il debitore di attivarsi e documentare con rigore la propria domanda di usura.
In sintesi, la lezione che proviene da queste pronunce è duplice. Da un lato, chi subisce interessi forse usurari ha oggi più strumenti normativi e giurisprudenziali per difendersi – come la possibilità di includere tutti i costi nel calcolo del tasso effettivo, facendo emergere eventuali superamenti dei limiti. Dall’altro lato, tuttavia, chi denuncia l’usura deve agire con estrema precisione, preferibilmente con l’assistenza di un legale esperto e di un consulente tecnico: bisogna raccogliere i contratti, calcolare i TEG, confrontarli coi tassi soglia di ogni periodo e presentare tutto ciò in modo chiaro al giudice. Solo un’azione ben preparata potrà portare al riconoscimento dei diritti del mutuatario, ad esempio l’ottenimento della declaratoria di nullità della clausola di interessi e la conseguente liberazione dal pagamento degli interessi indebitamente pattuiti.
Le recenti sentenze della Cassazione offrono un quadro aggiornato e coerente per affrontare le controversie sui mutui usurari. In concreto, cosa deve fare chi sospetta di essere vittima di usura bancaria? In primo luogo, è consigliabile far eseguire una perizia economico-finanziaria sul proprio mutuo o prestito da professionisti competenti: occorre determinare l’effettivo TAEG applicato tenendo conto di tutti i costi (tassi corrispettivi, tassi di mora, spese di istruttoria, commissioni, polizze, ecc.) e confrontarlo con il tasso soglia antiusura vigente nei vari periodi. Se dal calcolo emergono tassi superiori alla soglia, si è in presenza di interessi usurari. A questo punto, con il supporto di un avvocato, si potrà intraprendere la strada giudiziaria più opportuna: spesso si propone opposizione a decreto ingiuntivo (se la banca ha agito per recuperare il credito) o un’azione autonoma di accertamento negativo del debito e di restituzione di quanto pagato in eccedenza. In giudizio, come visto, sarà fondamentale presentare fin dall’atto introduttivo tutte le allegazioni dettagliate sui tassi e le soglie: i dati della perizia tecnica dovranno essere integrati nell’atto di citazione o di opposizione, per evitare declaratorie di inammissibilità.
È bene sottolineare che la legge e i giudici tutelano il cliente solo contro gli interessi usurari, non contro ogni forma di interesse elevato. Se un mutuo ha un tasso molto alto ma comunque sotto la soglia (ad esempio un tasso dell’8% annuo quando la soglia è 10%), il mutuatario non potrà invocare l’usura. In tali casi resta comunque la possibilità di negoziare con la banca una rinegoziazione o di ricorrere a strumenti come la surroga del mutuo presso altri istituti a condizioni migliori. Diverso è il caso in cui vi sia effettivamente usura: qui la legge è molto rigorosa verso l’istituto di credito, privandolo di ogni interesse. Addirittura, in ipotesi estreme, la concessione consapevole di credito a tassi usurari potrebbe integrare gli estremi del reato di usura (art. 644 c.p.), anche se in ambito bancario è più comune che le questioni vengano trattate in sede civile per ottenere la nullità delle clausole.
In conclusione, le pronunce del 2025 offrono un messaggio chiaro: trasparenza e legalità nei finanziamenti non sono optional. Le banche devono includere ogni costo nel TAEG e rispettare le soglie antiusura, pena la perdita degli interessi e gravi conseguenze legali. Dal canto loro, i debitori hanno sì diritto a difendersi dagli abusi, ma sono chiamati a farlo con metodo e precisione, fornendo al giudice tutti gli elementi per riconoscere l’usura. In questa rinnovata cornice, chi teme di essere vittima di interessi usurari può trovare nella legge un potente alleato: con l’assistenza di professionisti competenti è possibile far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia, trasformando un mutuo capestro in un debito più equo. “Nulla tenaci invia est via” – per i tenaci nessuna via è impervia: perseverando nella tutela dei propri diritti, anche le clausole più onerose possono essere superate e riportate nell’alveo della legalità.

Redazione - Staff Studio Legale MP