

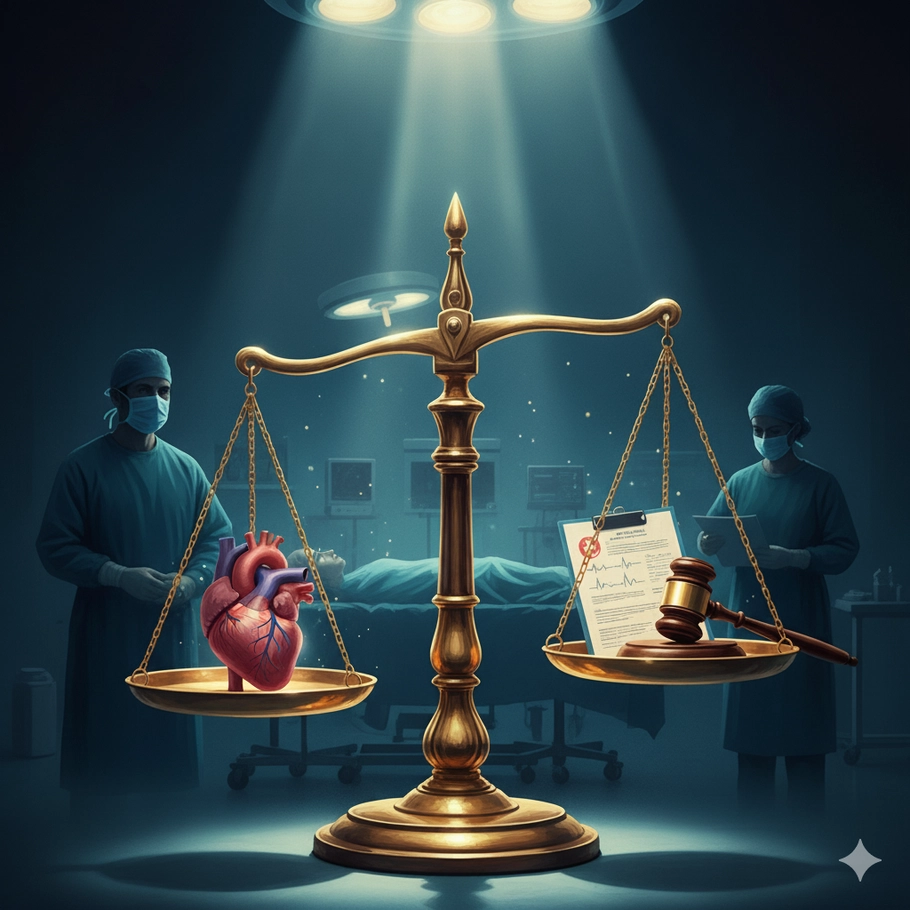
La giustizia italiana in materia di malasanità sta vivendo un’evoluzione importante, con pronunce che rafforzano le tutele per i pazienti vittime di errori medici. Di recente sono intervenute decisioni innovative su punti chiave: dall’obbligo di perizie medico-legali collegiali, alla definizione rigorosa del nesso causale nei casi di cure omesse, fino alla corretta valutazione delle patologie preesistenti nel calcolo dei risarcimenti. Queste sentenze, soprattutto della Corte di Cassazione, delineano un trend chiaro: processi più equi e risarcimenti più giusti, con i diritti del paziente posti in primo piano.
La causalità nei casi di cure omesse o ritardate (ad esempio una diagnosi mancata) è da sempre uno degli aspetti più delicati della responsabilità medica. Con la sentenza n. 547/2025 (Cass. civ., Sez. III) la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale su come valutare il nesso causale quando il medico è accusato non di un errore attivo, ma di non aver agito (omissione terapeutica). La Corte ha ribadito che il giudice deve ricostruire lo scenario ipotetico in cui l’errore non fosse avvenuto basandosi su un’“alta probabilità logica” di successo della terapia corretta. In altre parole, occorre dimostrare che, con un intervento tempestivo e adeguato, il decorso clinico del paziente sarebbe stato con elevata probabilità migliore. Non bastano supposizioni generiche: servono dati medici, linee guida e evidenze scientifiche a supporto di questa ricostruzione controfattuale rigorosa.
Per i pazienti, questo pronunciamento apre la strada a un riconoscimento del danno anche nei casi di diagnosi mancate o cure tardive, purché si riesca a provare con rigore che l’intervento omesso avrebbe avuto serie probabilità di evitare o attenuare il pregiudizio. Allo stesso tempo, per i medici, la decisione sottolinea l’importanza di documentare accuratamente anche le scelte di non intervento: potrebbero essere chiamati a rispondere delle conseguenze di un’omissione se questa ha privato il paziente di concrete chance di guarigione. Si rafforza quindi la tutela del paziente senza pretendere certezze assolute, ma richiedendo che le probabilità di un esito migliore siano fondate, ragionate e dimostrabili con criteri scientifici.
La perizia medico-legale (CTU – consulenza tecnica d’ufficio) è spesso il cuore di una causa per malasanità: dal suo esito dipende l’accertamento della colpa medica e la quantificazione del danno. Una recente pronuncia della Cassazione ha rafforzato le garanzie di imparzialità di questo strumento probatorio. Con la sentenza n. 15594/2025 (Cass. civ., Sez. III), la Suprema Corte ha sancito che nelle cause di responsabilità sanitaria è inderogabile l’obbligo – introdotto dalla “Legge Gelli-Bianco” (L. 24/2017) – di nominare un collegio peritale, composto almeno da un medico legale e da uno specialista della disciplina coinvolta, anziché affidare l’accertamento a un unico consulente. Di conseguenza, il giudice che basi la propria decisione su una CTU svolta da un solo perito quando la legge ne richiedeva due incappa in un vizio insanabile: la sentenza risultante è nulla.
Questa decisione tutela il diritto delle parti a una valutazione tecnica completa e multidisciplinare. Le controversie mediche richiedono spesso competenze integrate: ad esempio, in un caso di errore chirurgico servono sia l’occhio del medico legale sia l’esperienza specifica di un chirurgo del settore. Imporre il collegio di periti significa evitare perizie lacunose o parziali, assicurando che il giudizio si fondi su basi scientifiche solide e condivise. La Cassazione, in sostanza, ha voluto scongiurare che il rispetto formale delle regole procedurali finisca per danneggiare la sostanza della giustizia. Non a caso, richiamando ironicamente il motto di Molière, «è preferibile morire secondo le regole che guarire contro di esse», la Corte ha reso chiaro che le norme sulla collegialità della perizia vanno applicate nell’interesse del paziente. Una sentenza basata su un accertamento tecnico svolto in violazione di queste regole sarebbe un verdetto “monco” e inaffidabile – e per questo viene annullata. Così facendo, i giudici garantiscono processi più giusti, in cui nessuna scorciatoia procedurale possa sacrificare la verità e le ragioni del danneggiato.
Un altro tema cruciale nel risarcimento dei danni da malasanità riguarda i pazienti che avevano già problemi di salute prima dell’errore medico. In passato, le strutture sanitarie cercavano spesso di ridurre o negare il risarcimento attribuendo i postumi alle condizioni preesistenti del paziente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17006/2025 (Cass. civ., Sez. III), ha stabilito principi chiari per evitare automatismi penalizzanti in questi casi:
Danno integralmente risarcibile: il danno causato dall’errore medico va risarcito per intero, a meno che vi sia una concausa preesistente provata in concreto.
Concausa preesistente effettiva: una riduzione del risarcimento è ammissibile solo se, ipotizzando a posteriori un decorso senza l’errore, lo stesso esito negativo si sarebbe comunque verificato a causa della patologia pregressa.
Coesistenza vs concorso causale: occorre distinguere tra coincidenze (malattie preesistenti indipendenti dall’evento dannoso) e concorso causale (la patologia preesistente che interagisce con l’errore). Solo in quest’ultimo caso è possibile un abbattimento proporzionale del risarcimento, commisurato all’effettivo aggravamento prodotto dall’errore.
Nel caso concreto esaminato dalla Cassazione, un ragazzo aveva riportato un grave accorciamento dell’arto dopo un intervento chirurgico; i giudici di merito avevano ridotto il risarcimento del 45% sostenendo, in modo sommario, che alcune fratture avvenute l’anno prima avessero inciso sul risultato. La Suprema Corte ha censurato questo approccio: ogni decurtazione va motIVata rigorosamente con un’adeguata perizia medico-legale, spiegando quanto e come la condizione pregressa abbia contribuito al danno finale. In assenza di tale prova rigorosa, non si può diminuire l’importo dovuto. Se l’errore medico ha aggravato la situazione del paziente oltre ciò che la malattia di base avrebbe causato da sola, il medico risponde pienamente di tale aggravamento (il cosiddetto danno differenziale). Al contrario, se la condizione del paziente sarebbe stata la stessa anche senza errore, solo in tal caso la responsabilità risarcitoria del sanitario può essere ridotta proporzionalmente.
In sintesi, il medico non può “fare sconti” sul risarcimento invocando fragilità preesistenti del paziente, a meno che tali fragilità abbiano inciso in modo determinante e comprovato. Questa linea garantisce una valutazione tecnica concreta e giusta: ci si chiede cosa sarebbe accaduto al paziente senza l’errore. La risposta a questa domanda – supportata da evidenze scientifiche – guida il risarcimento, evitando sia indebite riduzioni sia duplicazioni. Inoltre, la Cassazione ha richiamato l’attenzione dei giudici sul danno morale e sulla personalizzazione del risarcimento: specialmente nei casi gravi (come nel caso di un minorenne con conseguenze permanenti), il tribunale deve considerare adeguatamente la sofferenza interiore e l’impatto sulla vita quotidiana, senza appiattirli nelle tabelle standard. In questo modo ogni vittima di malasanità ottiene non solo un indennizzo, ma un risarcimento equo e adeguato, calibrato sulla propria specifica situazione.
La direzione tracciata da queste sentenze è netta: la giustizia in ambito sanitario sta diventando sempre più a misura di paziente. Le corti, applicando con rigore sia le norme sostanziali sia quelle procedurali, mirano a riequilibrare un rapporto – quello tra il cittadino malato e la struttura sanitaria – tradizionalmente segnato da asimmetria. Oggi il paziente vede riconosciuti più pienamente i propri diritti: nessun errore viene minimizzato per cavilli procedurali o per condizioni di salute preesistenti, e ogni decisione deve poggiare su basi tecnico-scientifiche solide. In definitiva si concretizza il principio che chi ha subìto un danno abbia diritto a un ristoro completo e giusto, senza zone d’ombra o scorciatoie a vantaggio del responsabile. Salus aegroti suprema lex: la salute (e la giustizia dovuta a chi la perde) vengono davvero poste al centro, come legge suprema, nelle aule dei tribunali.

Redazione - Staff Studio Legale MP