

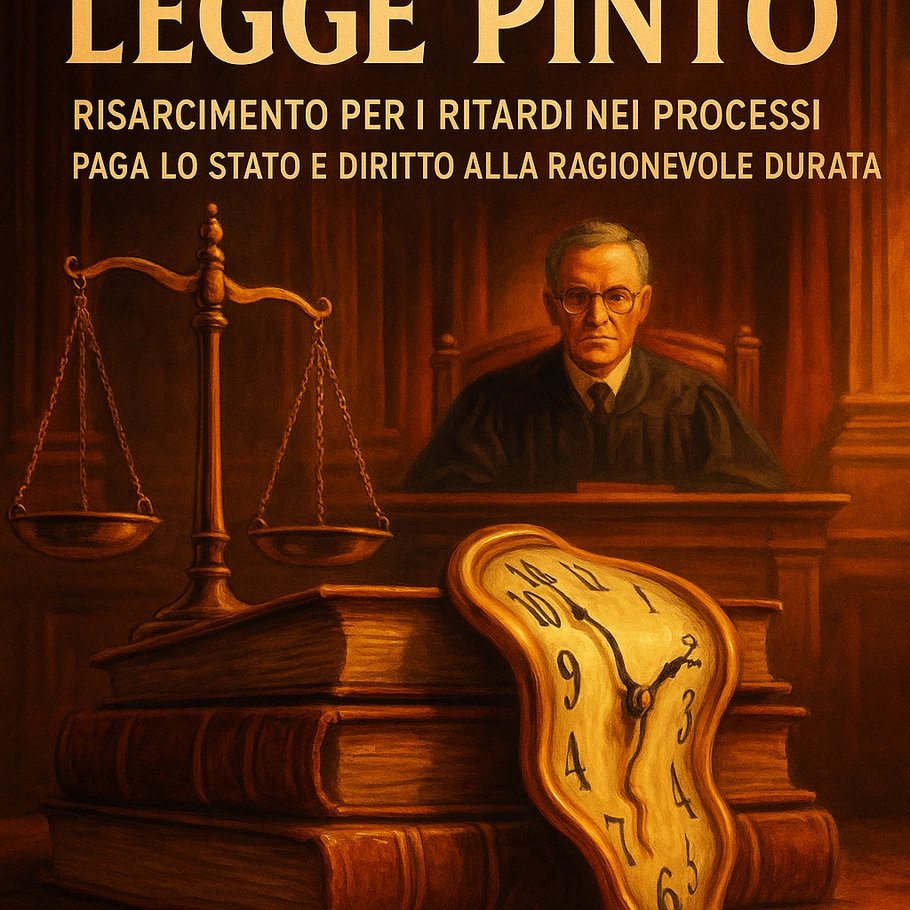
«La giustizia ritardata è giustizia negata», ammoniva Montesquieu. Un concetto anticipato anche dal motto latino iustitia dilatio est quaedam negatio, che sottolinea come un eccessivo ritardo nel rendere giustizia equivalga a negarla. Nell’ordinamento italiano, la tutela contro la “giustizia lumaca” è affidata alla legge Pinto (legge 24 marzo 2001 n. 89), che prevede un’equa riparazione – in forma di indennizzo monetario – per il danno (patrimoniale o non patrimoniale) subìto a causa dell’irragionevole durata di un processo. A oltre vent’anni dalla sua introduzione, la legge Pinto è stata oggetto di diverse riforme, nonché di significative pronunce giurisprudenziali (fino alla Corte costituzionale), volte a definirne limiti e condizioni. Di seguito esaminiamo in ottica tecnico-giuridica come funziona il risarcimento per i processi troppo lunghi, quali sono le novità normative più recenti – come il progetto di digitalizzazione “PintoPaga” – e i principali orientamenti giurisprudenziali emersi in materia, il tutto con attenzione alla SEO per una migliore fruizione dei contenuti.
Il principio della ragionevole durata del processo è consacrato sia a livello internazionale che interno. L’Italia, avendo ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) già nel 1955, è tenuta a garantire il diritto di ogni persona a un processo equo entro un termine ragionevole (art. 6, §1, CEDU). Tale principio è divenuto anche precetto costituzionale con la riforma dell’art. 111 Cost. nel 1999, che recita: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Nonostante ciò, per decenni l’ordinamento italiano non ha previsto rimedi interni efficaci contro l’eccessiva lentezza dei giudizi. Il risultato è stato un elevato numero di ricorsi alla Corte di Strasburgo e numerose condanne dell’Italia per violazione del diritto al processo in tempi ragionevoli, con conseguenti esborsi di milioni di euro a titolo di riparazione. Di fronte alle reiterate critiche europee e al rischio di sanzioni (si parlò persino dell’ipotesi di “espulsione” dal Consiglio d’Europa), il legislatore corse ai ripari introducendo finalmente un rimedio nazionale ad hoc: la legge n. 89/2001, comunemente detta “legge Pinto” (dal nome del senatore proponente).
La legge Pinto ha istituito uno strumento giurisdizionale interno per ottenere un’equa riparazione del danno causato dalla durata eccessiva di un processo. L’idea di fondo è permettere al cittadino di agire dinanzi a un giudice nazionale (anziché dover ricorrere direttamente alla Corte EDU) per conseguire un risarcimento in caso di violazione del termine di durata ragionevole del procedimento. Si tratta, in altre parole, di una valvola di sfogo interna: lo Stato riconosce la propria responsabilità nel non aver garantito tempi ragionevoli e indennizza la parte lesa, evitando così ulteriori ricorsi a Strasburgo. Va sottolineato che la legge Pinto non accelera i procedimenti né incide sull’organizzazione giudiziaria per ridurne i tempi: è un rimedio indennitario ex post, che interviene a posteriori a riparare il pregiudizio patito. La stessa Corte EDU ha osservato, con una punta di ironia, che “il miglior rimedio [contro i ritardi] è la prevenzione” e che un sistema di soli risarcimenti potrebbe addirittura indurre qualcuno a provocare ritardi deliberati pur di ottenere un indennizzo certo. Non a caso, nelle nostre corti d’appello si è assistito al fenomeno paradossale della “Pinto sulla Pinto”: cause di risarcimento per il ritardo nella definizione della precedente causa Pinto sul ritardo di un primo processo. Ciò malgrado, l’equa riparazione Pinto resta uno strumento fondamentale per dare attuazione concreta al principio “justice delayed is justice denied” e scongiurare la totale denegata giustizia nei confronti di chi ha subito procedimenti estenuanti.
La legge Pinto identifica con precisione i parametri temporali oltre i quali la durata di un processo diviene presumibilmente irragionevole. Tali parametri, inizialmente desunti dalla giurisprudenza europea, sono stati poi codificati (oggi all’art. 2, comma 2-bis, L.89/2001). In generale, si considera violato il termine ragionevole quando la durata del processo eccede: tre anni per il primo grado (tribunale o giudice di pace in sede civile, tribunale in sede penale), due anni per il secondo grado (Corte d’appello o assise d’appello), e un anno per il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione). Per procedimenti speciali vi sono termini ad hoc: ad es. nel processo esecutivo il termine ragionevole è considerato di 3 anni, mentre nella procedura fallimentare (che spesso coinvolge molteplici parti e fasi) è di 6 anni. In ogni caso, la legge prevede una clausola di salvaguardia: nessun indennizzo è dovuto se il processo, pur superando i singoli limiti di fase, viene definito in modo irrevocabile entro 6 anni complessivi (termine che funge da tetto massimo per presumere la ragionevole durata, salvo eccezioni).
Va precisato che questi termini decorrono dall’inizio formale del procedimento: in ambito civile, dal deposito dell’atto introduttivo (ricorso) o dalla notifica della citazione; in ambito penale, dal momento in cui l’indagato/imputato assume tale qualità (o la parte civile viene costituita), quindi tipicamente dalla richiesta di rinvio a giudizio o dall’avviso di conclusione indagini. Inoltre, alcuni periodi non vanno conteggiati ai fini Pinto: ad esempio, il tempo in cui il processo è sospeso per legge, oppure i periodi morti tra la scadenza del termine per impugnare e la proposizione effettiva dell’impugnazione. La giurisprudenza ha escluso dal computo anche i ritardi “voluti” dalla parte che poi si duole: emblematicamente, non si calcola il rinvio d’udienza chiesto dal difensore aderendo a uno sciopero degli avvocati, trattandosi di scelta imputabile alla parte stessa (Cass. civ. Sez. VI, 16 giugno 2015, n. 12447). In sostanza, la “lumaca” della giustizia viene misurata sul tempo impiegato dallo Stato per giungere a una decisione definitiva, al netto di pause fisiologiche o dilazioni dovute alla condotta delle parti.
Occorre però chiarire che i termini suindicati non sono assoluti: rappresentano indici di durata ragionevole, superati i quali scatta la presunzione di violazione. Nel giudizio Pinto, infatti, il giudice non si limita a un riscontro cronometrico, ma valuta anche altri fattori qualitativi: la complessità del caso, la natura del procedimento e degli interessi coinvolti, e soprattutto il comportamento delle parti e del giudice. Se, ad esempio, un processo civile di primo grado dura 4 anni (quindi oltre il triennio standard) ma la lentezza è dipesa da continue istanze di rinvio di entrambe le parti, oppure dalla complessità estrema della causa, tali elementi potranno essere considerati per attenuare o talora escludere la responsabilità dello Stato. Al contrario, se il processo ha superato i termini senza giustificato motivo, il ritardo si considera ingiustificato e dà luogo al diritto all’indennizzo.
Hanno diritto a richiedere l’indennizzo Pinto tutti i soggetti che abbiano subìto un danno a causa dell’eccessiva durata di un processo, indipendentemente dall’esito dello stesso. In primo luogo, ovviamente, ne ha diritto la parte vittoriosa nel giudizio “lumaca” (che magari, pur vincendo la causa, ha visto tardivamente soddisfatto il proprio diritto); ma anche la parte soccombente può lamentare il danno da ritardo, ad esempio per aver vissuto troppo a lungo sotto la spada di Damocle di un possibile esito sfavorevole. Rientrano tra gli aventi diritto tutte le parti processuali, comprese quelle intervenute o i chiamati in causa. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che possono agire per equa riparazione anche gli eredi della parte originaria (se questa è deceduta pendente causa – la pretesa risarcitoria si trasmette iure hereditatis), nonché le persone giuridiche (società, enti) coinvolte in processi irragionevolmente lunghi. Si pensi, ad esempio, a una società parte in una causa civile durata molti anni: anch’essa, pur non essendo una “persona” in senso stretto, subisce potenzialmente un danno (patrimoniale, per le spese legali prolungate; o non patrimoniale come lesione dell’immagine commerciale) e perciò ha diritto all’indennizzo (Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 2007, n. 8604).
Di converso, non tutti possono agire ai sensi della legge Pinto. In particolare, non è legittimato a chiedere l’indennizzo l’avvocato che abbia partecipato al giudizio in qualità di difensore e si sia fatto attribuire le spese processuali “antistatariamente” (ossia con distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c.). La Corte di Cassazione ha infatti ribadito di recente che l’avvocato antistatario non assume il ruolo di parte nel procedimento (agendo solo in nome del cliente per le spese) e dunque non può qualificarsi come “parte lesa” dalla durata del processo ai fini dell’equa riparazione (Cass. ord. 6 marzo 2025, n. 6070). In altre parole, se il difensore ha chiesto le spese a sé distratte, non potrà poi domandare allo Stato il risarcimento per il ritardo di quel giudizio, non essendo portatore di un diritto autonomo nel processo stesso. Si tratta di un limite giurisprudenziale volto a evitare indebite duplicazioni di pretese risarcitorie e a chiarire che il rimedio Pinto tutela solo chi personalmente subisce il pregiudizio da eccessiva durata.
Un aspetto procedurale cruciale è il termine entro cui proporre la domanda di equa riparazione. La legge Pinto richiede di attivarsi tempestivamente: il ricorso va depositato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il processo presupposto è divenuta definitiva. In pratica, si deve agire entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (o decreto) che ha definito il procedimento “lumaca”. Questo termine di decadenza, introdotto in un secondo momento per evitare richieste tardive a distanza di molti anni, impone dunque ai danneggiati di non attendere oltre sei mesi dalla fine del processo principale per far valere il loro diritto al risarcimento Pinto. La competenza a decidere su tali ricorsi è attribuita alle Corti d’appello: precisamente, per garantire terzietà ed evitare conflitti d’interesse, la domanda si propone alla Corte d’Appello di un distretto diverso da quello in cui ha sede il giudice che ha ritardato. Una specifica tabella di legge individua per ogni ufficio giudiziario competente un diverso distretto d’appello “vicino ma non troppo” (analogo meccanismo previsto nell’art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti magistrati). Ad esempio, per un processo civile durato troppo a lungo presso il Tribunale di Roma (distretto Corte d’Appello di Roma), l’eventuale ricorso Pinto va presentato alla Corte d’Appello di Perugia, e così via. Questa scelta organizza una sorta di giudice del reclamo esterno e imparziale rispetto all’ufficio inerte.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello competente, il quale designa poi un giudice relatore (consigliere) per decidere. Il procedimento si svolge attualmente in camera di consiglio (non in udienza pubblica), con la partecipazione facoltativa del Pubblico Ministero. La legge prevede che il giudice designato provveda “con decreto motivato” entro 30 giorni dal deposito del ricorso. In caso di accoglimento, il decreto ingiunge all’amministrazione convenuta (Ministero competente) il pagamento dell’indennizzo liquidato, senza dilazione, e contestaulmente liquida le spese legali ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente. Il decreto viene poi notificato in forma autentica alle parti convenute (tipicamente al Ministero della Giustizia) entro 30 giorni dal deposito, a cura del ricorrente; se tale notifica non avviene tempestivamente, il decreto diviene inefficace e la domanda è tamquam non esset (come se non fosse mai stata proposta). Questa previsione sanziona l’inerzia del ricorrente nell’ultimare il procedimento e mira a dare certezza agli esiti.
Se il ricorso Pinto risulta fondato, il giudice riconosce l’indennizzo con il decreto suddetto. Se invece reputa la domanda insufficientemente motivata o provata, può invitare il ricorrente a fornire un supplemento di prova (entro 60 giorni). Qualora il ricorrente non ottemperi all’invito o non integri gli atti richiesti, il giudice può rigettare la domanda. Il decreto che respinge in tutto o in parte il ricorso è impugnabile: in passato era prevista l’opposizione allo stesso collegio della Corte d’Appello, oggi si ritiene esperibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto sfavorevole (così da assicurare un vaglio di legittimità). Da notare che, dopo le modifiche normative, la procedura Pinto ha natura sostanzialmente monitoria: il decreto emesso dal consigliere designato somiglia a un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, contro cui la parte soccombente (tipicamente il Ministero) può proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello in composizione collegiale. Su questo punto la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti tecnici, come la natura “in parte decisoria in parte monitoria” dell’opposizione ex art. 5-ter L.89/2001 (Cass. civ. Sez. II, 13 aprile 2022, n. 12027). Senza entrare nei dettagli, va ricordato che il pagamento dell’indennizzo da parte dello Stato non è immediato: una volta ottenuto il decreto Pinto favorevole, il creditore deve presentare un’istanza di pagamento all’amministrazione debitrice, allegando una dichiarazione sostitutiva sull’assenza di precedenti riscossioni e l’indicazione delle coordinate per il versamento. La burocrazia finanziaria ha i suoi tempi: spesso trascorrono mesi (se non anni) prima che il Ministero effettui materialmente il pagamento dovuto, con ulteriori possibili ritardi che – in passato – hanno generato nuovi conteziosi (da qui il citato fenomeno “Pinto sulla Pinto”).
Un tema oggetto di pronunce recenti riguarda la decorrenza degli interessi sull’indennizzo Pinto. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10096 del 17 aprile 2023, ha affrontato il dubbio se gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dal momento del decreto che liquida l’indennizzo oppure da un momento successivo (es. dalla domanda o dalla comunicazione del decreto). Tale intervento giurisprudenziale rientra nell’ottica di definire meglio il quantum dovuto, ma va oltre lo scopo di questa trattazione entrare nei dettagli specifici. Basti notare che, in linea generale, all’importo liquidato dal giudice Pinto si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri ordinari dei debiti di valore, per compensare la svalutazione subìta durante il tempo trascorso.
L’importo dell’indennizzo riconosciuto ex lege Pinto ha natura di danno forfettario, in parte standardizzato dalla legge e in parte modulabile dal giudice. In origine (dal 2001 al 2015) la giurisprudenza, rifacendosi ai parametri CEDU, aveva individuato un range di circa €500 a €1.500 per ogni anno di ritardo eccedente il ragionevole. Questo intervallo è stato poi formalizzato e ridotto dal legislatore con la riforma del 2016: attualmente l’art. 2, co. 1-bis L.89/2001 stabilisce che l’indennizzo non può essere inferiore a €400 né superiore a €800 per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) di ritardo. Dunque, per un processo protrattosi ad esempio 3 anni oltre il termine, la parte lesa potrà ottenere tra un minimo di €1.200 e un massimo di €2.400 circa. La forbice risarcitoria è stata quindi compressa dal legislatore per contenere la spesa pubblica conseguente ai risarcimenti (esplicitamente, la finalità dichiarata era “razionalizzare i costi” dei processi lumaca).
Tuttavia, la legge prevede alcune modulazioni percentuali sull’importo base, per tenere conto di situazioni particolari. In aumento: l’indennizzo può essere incrementato fino al 20% per ogni anno successivo al terzo oltre la soglia, e fino al 40% per ogni anno successivo al settimo. Ciò riconosce che i ritardi molto lunghi aggravano esponenzialmente il patimento della parte (dopo molti anni di attesa, il danno morale cresce). Viceversa, in presenza di cause con molte parti, l’importo può essere ridotto: fino al 20% in meno se le parti sono più di 10, e fino al 40% in meno se superano 50. L’idea è che in processi collettivi o di massa il pregiudizio individuale per ciascuna parte sia in proporzione minore. Inoltre, l’indennizzo non può mai superare il valore della causa in cui il ritardo è maturato: ad esempio, se un giudizio verteva su €5.000, l’indennizzo Pinto non potrà eccedere tale cifra, anche se in base agli anni di ritardo il calcolo forfettario portasse a una somma maggiore. Questo per evitare che il risarcimento per il ritardo diventi ulteriore lucro rispetto all’oggetto del contendere originario.
Nel determinare concretamente l’indennizzo entro i limiti suddetti, il giudice segue i criteri generali dell’art. 2056 c.c. (danni da fatto illecito), tenendo conto dell’esito del processo presupposto, del comportamento del giudice e delle parti, della natura e valore della causa e delle condizioni personali del danneggiato. Ad esempio, una causa di importanza vitale per la parte (come una causa di lavoro da cui dipende il sostentamento) potrebbe giustificare un indennizzo verso l’alto della forbice, mentre un contenzioso bagatellare potrebbe essere liquidato al minimo. È importante notare che, nonostante la discrezionalità, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’indennizzo non dev’essere meramente simbolico né irragionevole rispetto agli standard CEDU. In altre parole, sebbene il giudice nazionale non sia vincolato in modo matematico ai precedenti di Strasburgo, egli deve mantenersi coerente con la “tradizione giuridica” e il tenore di vita del Paese. Un indennizzo irrisorio (es. pochi euro per anno di ritardo) sarebbe cassato perché contrario allo scopo stesso della legge Pinto, che è offrire una riparazione equa e dissuasiva di future violazioni.
La legge Pinto esclude espressamente il diritto all’indennizzo in talune situazioni peculiari, per evitare abusi del rimedio. Non viene riconosciuto alcun indennizzo:
Alla parte soccombente condannata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.: chi ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, subendo una condanna aggravata, non può poi lamentarsi della durata (una causa temeraria non andava neppure iniziata, figuriamoci risarcirne il ritardo).
Alla parte che ha rifiutato una proposta conciliativa del giudice senza motivo (art. 91 c.p.c.) quando la sentenza finale corrispondeva a quella proposta: se il giudice aveva offerto una soluzione e la parte l’ha rifiutata allungando il processo, non merita indennizzo.
Nel processo penale, all’imputato che ha causato la prescrizione con condotte dilatorie: ad esempio, se l’imputato ha sfruttato ogni stratagemma per far prescrivere il reato, allungando i tempi, non potrà poi ottenere equa riparazione perché la lentezza è dipesa anche da lui.
Sempre in ambito penale, all’imputato che non ha depositato istanza di accelerazione entro 30 giorni dal superamento dei termini di fase (prevista dall’art. 2-bis L.89/2001): introdotta dal 2012, questa condizione punisce chi resta inerte di fronte al ritardo. (Va detto però che una recente sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima proprio la previsione di improponibilità del ricorso Pinto se l’imputato non presentò istanza di accelerazione in Cassazione – v. oltre).
In ogni altro caso di abuso del processo da parte di chi invoca Pinto: formula generale per coprire situazioni in cui il ritardo è dipeso essenzialmente da manovre o atteggiamenti dilatori della parte stessa.
In sintesi, la legge mira a indennizzare solo chi subisce passivamente la lentezza della giustizia, non certo chi vi contribuisce attivamente o ne approfitta. Come scriveva il poeta inglese John Dryden, “La giustizia è lenta per chi ha torto” – ma la legge Pinto vuole che sia equa per chi ha ragione.
Sin dalla sua applicazione, la legge Pinto ha mostrato criticità, come l’elevato numero di ricorsi e i costi a carico dello Stato (centinaia di milioni di euro). Per questo motivo, è stata oggetto di riforme significative volte sia a ridurre l’impatto finanziario sia a incentivare le parti a sollecitare i processi prima di chiedere indennizzi. Una prima revisione è avvenuta con il decreto “Crescitalia” (D.L. 83/2012 conv. L.134/2012), che ha introdotto vari accorgimenti per snellire i giudizi Pinto e limitare alcuni automatismi ritenuti eccessivamente onerosi. Ad esempio, è stato imposto il termine decadenziale di 6 mesi per proporre il ricorso (prima non previsto), ed è stata normata la prenotazione a debito delle spese di giustizia nei ricorsi Pinto per evitare esborsi anticipati.
La riforma più incisiva è però giunta con la legge di stabilità 2016 (L.208/2015, commi 777-781), che ha introdotto i cosiddetti “rimedi preventivi” e rideterminato la misura dell’indennizzo come visto sopra. L’idea centrale è stata quella di obbligare la parte, prima di poter chiedere l’indennizzo, a esperire almeno una mossa acceleratoria durante il processo presupposto, così da tentare di evitare o ridurre il ritardo. Tali “rimedi preventivi” sono ora condizione di procedibilità della domanda Pinto. In particolare, la legge Pinto (artt. 1-bis e 1-ter introdotti nel 2016) prevede rimedi diversi a seconda del tipo di processo:
Nel processo civile: la parte deve aver richiesto la trattazione con rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) oppure la trasformazione del rito ordinario in sommario, oppure – se il rito sommario non è ammesso – deve aver depositato un’istanza di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.. Questa norma spinge i difensori ad utilizzare il rito sommario (più snello) o comunque a sollecitare una decisione immediata dopo la fase scritta, anche nei tribunali collegiali. Tali richieste vanno fatte nel primo grado di giudizio. Restano escluse le cause iniziate prima del 1990 (vecchio rito) e quelle in materia di lavoro, dove già esiste il rito speciale che non consente simili opzioni.
Nel processo penale: la parte (imputato) deve aver presentato una istanza di accelerazione al giudice competente, secondo modalità fissate dalla nuova legge. Questa istanza sollecita la fissazione di udienza o decisione entro termini più brevi. Una versione embrionale esisteva già (art. 2, co. 2-quinquies lett. e, L.89/2001 introdotto nel 2012), ma è stata sostituita da una disciplina più puntuale, in vigore dal 31 ottobre 2016.
Nel processo amministrativo: il rimedio preventivo è l’istanza di prelievo (art. 71 c.p.a.), cioè la richiesta al TAR o al Consiglio di Stato di dare priorità al ricorso evidenziandone l’urgenza. Già dal 2010 l’istanza di prelievo era condizione per il Pinto amministrativo, ma la riforma del 2016 ha ribadito tale necessità posticipandola ai procedimenti divenuti irragionevoli dopo il 31/10/2016.
Nei processi contabili, pensionistici e nei giudizi in Cassazione: sono previste analoghe istanze di accelerazione ad hoc (a volte ritenute “necessarie” dalla giurisprudenza, altre no).
L’effetto della riforma è stato che, per i processi la cui durata è divenuta irragionevole dopo il 31 ottobre 2016, la parte che vuole poi chiedere l’indennizzo deve dimostrare di aver attivato uno di questi rimedi in corso di causa. In caso contrario, la sua domanda Pinto è improcedibile. Lo scopo dichiarato è rendere l’equa riparazione “remedio extremo”, spronando invece le parti a “fare qualcosa” mentre il processo è in corso, per evitarne la stasi. Si tratta di una filosofia in linea con il principio, caro alla Corte EDU, secondo cui “il miglior rimedio è prevenire i ritardi”. Tuttavia, questa impostazione ha suscitato dubbi di costituzionalità quando il rimedio preventivo richiesto non incide realmente sui tempi del processo. Ad esempio, l’istanza di accelerazione in Cassazione (che chiede di fissare l’udienza prima) è ritenuta una mera sollecitazione priva di effetti obbligatori sul calendario della Suprema Corte. La Corte costituzionale, con sentenza n. 142/2023, ha infatti dichiarato illegittima la norma che rendeva improcedibile la domanda Pinto per mancato deposito dell’istanza di accelerazione in Cassazione. La Consulta ha rilevato che tale istanza non garantisce alcuna effettiva accelerazione (la Cassazione non è vincolata a dare priorità al ricorso) e pertanto non può costituire un filtro ai risarcimenti. In motivazione, la Corte afferma che imporre adempimenti “inefficaci” come condizione di ammissibilità viola sia l’art. 111 Cost. che l’art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo). Viene però aggiunto che la mancata presentazione di tali istanze potrà semmai rilevare nella determinazione del quantum (se indice di disinteresse sopravvenuto), ma non precludere il diritto all’indennizzo.
Al di là del caso Cassazione, il sistema dei rimedi preventivi rimane in vigore per civile, penale e amministrativo. Una recente applicazione interessante riguarda i giudizi civili dinanzi al Giudice di pace. Ci si chiedeva se anche in quei procedimenti, generalmente di modesta entità e trattati con rito semplificato, fosse necessario proporre istanza di trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.) come rimedio acceleratorio. La Corte di Cassazione, interpellata in via di rinvio pregiudiziale (nuovo istituto introdotto dalla riforma Cartabia), ha chiarito che sì, anche nei processi davanti al Giudice di pace la parte deve presentare istanza di decisione a seguito di trattazione orale per poter poi accedere alla legge Pinto. In una pronuncia storica (Cass. civ. Sez. II, sent. 21 luglio 2023, n. 21876) la Suprema Corte ha enunciato il principio che l’istanza ex art. 281-sexies, pur non tipica del rito del Giudice di pace, non è strutturalmente incompatibile con esso e ha comunque una funzione acceleratoria sulla definizione della causa. Dunque, anche nelle cause minori è richiesto attivismo: la parte che è rimasta inerte di fronte alla lentezza del giudizio di pace non potrà poi dolersene con Pinto.
La problematica dei ritardi nei pagamenti degli indennizzi Pinto e del massiccio arretrato di pratiche ha portato di recente a un intervento straordinario da parte del Ministero della Giustizia. Nel 2023 è stato lanciato il progetto “PintoPaga”, con l’obiettivo ambizioso di azzerare entro il 31 dicembre 2026 tutte le domande di equa riparazione pendenti presso le Corti d’Appello. Si parla di circa 80.000 ricorsi arretrati relativi a ritardi maturati tra il 2015 e il 2022, per un debito complessivo stimato di 400 milioni di euro a carico dello Stato. Questo arretrato giaceva in gran parte in formato cartaceo presso gli uffici di via Arenula (Ministero), rendendo lenta la procedura di liquidazione. L’innovazione introdotta è stata la digitalizzazione del processo di pagamento: il Ministero ha esteso l’uso della piattaforma informatica SIAMM Pinto (Sistema Informativo degli Affari Monitori e del Pinto digitale) anche ai decreti di pagamento relativi agli anni 2015-2022. In pratica, tutti i beneficiari di indennizzi decretati in quelle annualità – e non ancora pagati – sono invitati a ripresentare le istanze di liquidazione in formato digitale sulla piattaforma SIAMM Pinto.
Questa procedura straordinaria è stata formalizzata con una modifica normativa inserita nella legge di bilancio 2025, che ha appunto autorizzato la ri-presentazione telematica delle domande di pagamento degli indennizzi Pinto arretrati. Il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso l’invito a tutti gli avvocati affinché aderiscano: le vecchie istanze cartacee vanno caricate online entro il 30 giugno 2025, pena la perdita di questa finestra privilegiata. Una volta caricate le pratiche sul portale (accessibile con SPID o CNS), l’Amministrazione avrà tempo fino alla fine del 2025 (prorogabile al 2026) per esaminarle e disporre i pagamenti. I primi risultati sono incoraggianti: nei soli primi cinque giorni di operatività del sistema, la Direzione Generale affari giuridici ha emesso oltre 600 ordinativi di pagamento. Il sistema digitale consente al creditore di monitorare lo stato della pratica, ricevere notifiche automatiche sui progressi e soprattutto di correggere eventuali dati errati (es. IBAN, intestazione) senza bisogno di contatti diretti con gli uffici. Ciò dovrebbe velocizzare notevolmente l’erogazione delle somme dovute.
Il progetto PintoPaga rappresenta dunque una svolta tecnologica nella gestione di questi indennizzi, tradizionalmente afflitta da lungaggini burocratiche e mancanza di fondi. Grazie alla transizione digitale e allo stanziamento di risorse dedicate (inserite in bilancio), si punta a smaltire un arretrato storico che aveva fatto lievitare il debito Pinto a cifre record. Basti pensare che già nel 2014 il debito accumulato ammontava a oltre 450 milioni di euro. L’intervento corrente mira non solo a pagare il pregresso, ma anche a prevenire nuovi ritardi: una volta a regime, la piattaforma SIAMM dovrebbe gestire tutte le future domande Pinto per i decreti emessi dal 2023 in poi, riducendo drasticamente i tempi di pagamento rispetto alla gestione cartacea. Insomma, la giustizia lenta reclama risarcimenti che non siano a loro volta lenti: una contraddizione che il sistema PintoPaga vuole risolvere, realizzando il paradosso di “snellire la lentezza”. Come ha commentato il Presidente del CNF, “è un’occasione da non perdere” per l’Avvocatura, perché consentirà di dare finalmente soddisfazione (anche economica) a migliaia di cittadini e professionisti che attendono il dovuto.
Nel corso degli anni, numerose pronunce di merito e di legittimità hanno affinato l’interpretazione della legge Pinto. In tempi recenti, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale sono intervenute su questioni chiave, delineando i confini del diritto all’equa riparazione. Abbiamo già richiamato alcune decisioni: ad esempio, la Cass. 21876/2023 sul rimedio preventivo davanti al Giudice di pace, e la sentenza della Consulta n. 142/2023 sull’illegittimità dell’istanza di accelerazione in Cassazione come condizione di ammissibilità. Val la pena di ricapitolare brevemente questi ed altri spunti giurisprudenziali di rilievo:
Corte Cost. n. 88/2018: dichiarò incostituzionale l’art. 4 della legge Pinto nella parte in cui non prevedeva che il termine semestrale per agire decorresse dal giorno in cui la parte aveva avuto conoscenza legale della definizione del processo. Questa pronuncia ha “aggiustato” la decorrenza della decadenza, evitando che il termine iniziasse a decorrere prima che la parte fosse effettivamente informata della conclusione del giudizio (principio di effettività della tutela).
Cass. Sez. Unite 22 luglio 2015, n. 15352: ha stabilito che il decreto Pinto che riconosce l’indennizzo ha natura di titolo immediatamente esecutivo contro lo Stato e che all’ottemperanza si applicano le regole del processo esecutivo ordinario, salvo il regime speciale di pagamento introdotto poi nel 2016 (dichiarazione/autocertificazione del creditore ogni 6 mesi per mantenere attuale il credito, art. 5-sexies).
Cass. Sez. II, 25 luglio 2023 n. 22365: ha chiarito la nozione di “violazione di carattere continuativo” nel contesto Pinto. In particolare, ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, il termine ragionevole può considerarsi violato anche se una singola fase del processo eccede la durata dovuta, purché l’intero procedimento non si sia concluso entro sei anni (ribadendo così l’importanza della soglia dei 6 anni complessivi).
Cass. Sez. II, ord. 17 aprile 2023 n. 10096: (già menzionata) ha affrontato la debenza degli interessi sull’indennizzo Pinto, statuendo – per quanto noto – che gli interessi legali sono dovuti dal momento in cui il diritto all’indennizzo sorge (cioè dalla data di domanda di equa riparazione o dalla data di maturazione del ritardo, a seconda dei casi), e comunque non prima della domanda stessa. Questo per evitare che lo Stato debba interessi su periodi in cui ancora non era formalmente in mora.
Cass. Sez. II, ord. 5 gennaio 2023 n. 1: ha inaugurato il 2023 con una pronuncia sulla notifica del decreto Pinto al Ministero: ha precisato che il termine di 30 giorni per notificare decorre dalla comunicazione ufficiale del decreto al ricorrente e non dalla mera pubblicazione, armonizzando la prassi con i principi generali. Ciò per garantire che il ricorrente abbia effettiva contezza del provvedimento prima che inizi a correre il breve termine decadenziale di notifica.
Cass. Sez. VI, ord. 21 luglio 2020 n. 15503: ha definito la natura del procedimento Pinto come giudizio autonomo rispetto al processo presupposto e ha stabilito come vadano liquidati i compensi dell’avvocato nel procedimento di equa riparazione (applicando le tabelle del DM compensi avvocati alla fase monitoria e all’eventuale fase di opposizione, equiparandole rispettivamente a un procedimento sommario e a un giudizio ordinario di primo grado).
Cass. Sez. II, 4 agosto 2022 n. 24174: intervenendo su un caso di procedura fallimentare, ha ribadito che il termine semestrale per proporre la domanda Pinto decorre, per i creditori insinuati al fallimento, dalla chiusura della procedura concorsuale o dall’esaurimento delle possibilità di soddisfo del credito, non già da ogni singolo atto (questo per evitare il proliferare di più domande Pinto riguardo a diverse fasi dell’unico fallimento).
Cass. Sez. II, 23 dicembre 2024 n. 34183: ha affermato che anche il soggetto intervenuto in un processo (in intervento adesivo dipendente, cioè a sostegno di una delle parti originarie) è legittimato a chiedere l’indennizzo Pinto se il processo è durato troppo, in quanto anch’egli acquisisce la qualità di parte del procedimento, sebbene con posizione subordinata. Ciò conferma l’orientamento inclusivo sulla legittimazione, già richiamato supra.
Cass. Sez. II, 6 marzo 2025 n. 6070: (citata sopra) ha negato l’indennizzo all’avvocato distrattario delle spese, consolidando un indirizzo rigoroso sulla legitimatio e ribadendo principi deontologici: l’avvocato che ottiene le spese vive dal soccombente non può poi pretendere dallo Stato il risarcimento per un ritardo che riguarda il cliente (il diritto è del cliente, non dell’avvocato).
Infine, vale la pena menzionare uno spunto letterario che ben illustra la percezione popolare della giustizia lenta: nel celebre romanzo “Bleak House” di Charles Dickens, viene descritta la causa Jarndyce vs Jarndyce, una vertenza testamentaria protrattasi così a lungo nei labirinti della Court of Chancery inglese che, al termine, “non c’era più nulla da ereditare perché le spese legali avevano divorato tutto”. È un monito narrativo di come la lentezza giudiziaria possa frustrare i diritti sostanziali rendendo vane le stesse vittorie processuali. La legge Pinto, con tutti i suoi limiti, ha cercato di evitare che in Italia si ripetano “cause infinite” senza rimedio: indennizzando le vittime dei ritardi, essa fornisce almeno un ristoro simbolico e economico, mantenendo vivo il principio che un giusto processo deve essere anche un processo tempestivo. Come detto in apertura, summum ius, summa iniuria – una giustizia troppo tardiva rischia di non essere più giustizia; ma grazie a strumenti come la legge Pinto, l’ordinamento riconosce il torto e in qualche misura vi pone rimedio, riaffermando la fiducia dei cittadini nella Giustizia, quella con la “G” maiuscola.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.