

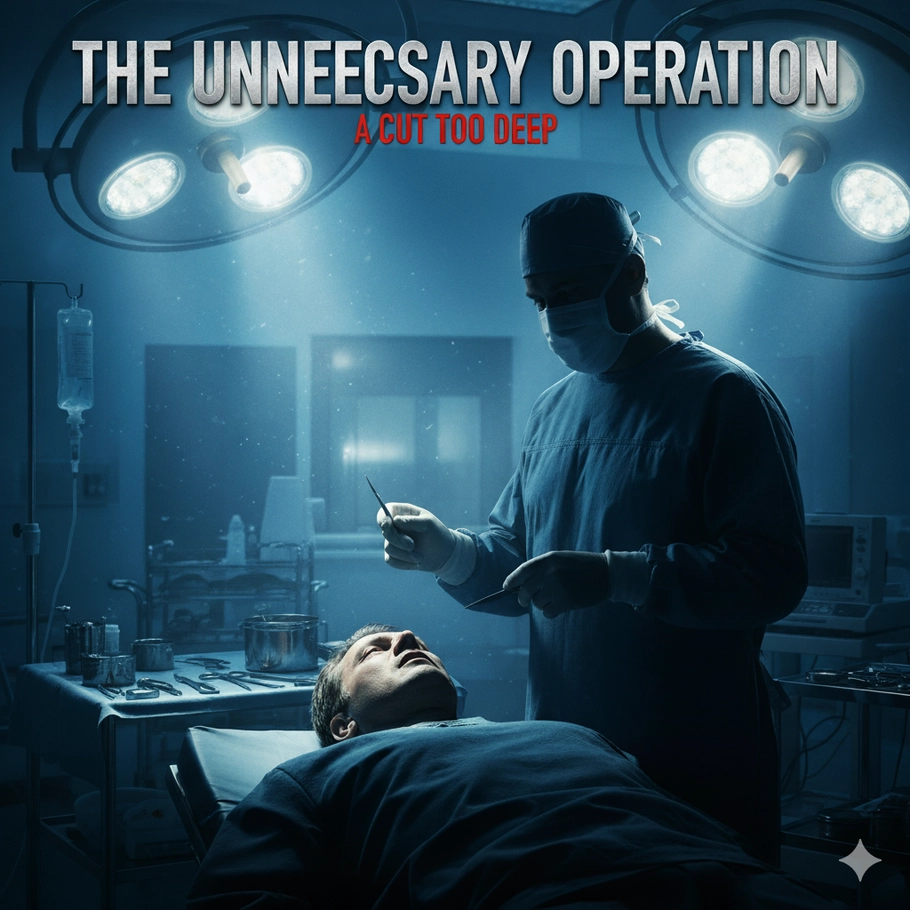
Un intervento chirurgico eseguito senza necessità – come l’asportazione di un organo sano a causa di una diagnosi sbagliata – non è solo uno scenario da incubo, ma una realtà documentata. In Italia si sono verificati casi in cui pazienti hanno subìto operazioni invasive in assenza di reale indicazione clinica, ritrovandosi poi con danni anziché benefici. La massima latina primum non nocere (innanzitutto, non nuocere) dovrebbe guidare ogni atto medico; eppure, quando si pratica una terapia non necessaria, quel principio viene tradito. Come recita un mordace aforisma di Molière, “gli uomini muoiono tutti quanti per via dei farmaci e non per via delle malattie”: è un’esagerazione satirica, ma che fa riflettere sull’importanza di evitare cure superflue e potenzialmente dannose. In ambito sanitario, infatti, fare troppo può essere dannoso quanto fare troppo poco.
Quando un paziente si sottopone a un trattamento inutile, si verificano due tipologie di lesione dei suoi diritti. La prima è il danno alla salute in senso stretto: ogni intervento chirurgico comporta rischi, dolore, stress e possibili complicanze. Se questi effetti negativi vengono subìti inutilmente – perché l’intervento non era necessario per curare alcuna patologia – il paziente subisce un pregiudizio concreto alla propria integrità psicofisica. Ad esempio, in un caso recente la Corte d’Appello dell’Aquila ha riconosciuto un risarcimento di oltre 120.000 euro a un uomo al quale era stato erroneamente asportato un rene per sospetto tumore poi rivelatosi inesistente (Corte d’Appello dell’Aquila, sent. n. 25/2025 del 9 gennaio 2025): quell’operazione invasiva, svolta in assenza di un carcinoma effettivo, ha provocato al paziente una menomazione permanente e sofferenze del tutto evitabili, dando luogo a responsabilità della struttura sanitaria.
La seconda lesione, meno tangibile ma fondamentale, è la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente. Ogni persona ha il diritto di essere informata in modo completo e di scegliere liberamente se sottoporsi o meno a un trattamento. Quando viene effettuata una cura senza che il paziente sia stato adeguatamente informato della sua non indispensabilità, si lede la sua libertà di decidere consapevolmente. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mancanza di un consenso informato valido configura un illecito a sé stante: anche se un intervento è tecnicamente corretto, il medico risponde dei danni se non ha messo il paziente in condizione di capire che quell’atto poteva essere evitato o differito. In particolare, una recente pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di consenso effettivamente informato, il sanitario (e la struttura) possono essere ritenuti responsabili dei danni derivanti dall’intervento, anche se eseguito senza errori tecnici (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1443/2025). In sostanza, chi subisce un intervento non necessario senza saperlo ha diritto al risarcimento sia per l’eventuale danno biologico subito, sia per la lesione del proprio diritto di scelta (il cosiddetto “danno da violazione del consenso informato”).
Dal punto di vista giuridico, praticare un trattamento inutile può costituire una forma di colpa medica. Il medico ha il dovere di attenersi alla lex artis, ossia alle regole della buona pratica clinica, che comprendono non solo il fare ciò che è necessario, ma anche il non fare ciò che non serve. Questo implica, ad esempio, approfondire la diagnosi con esami appropriati prima di decidere un intervento invasivo, valutare terapie alternative meno rischiose e adottare un atteggiamento prudente. L’errore può consistere tanto in un eccesso di zelo ingiustificato (ad esempio, operare subito una lesione benigna senza valutare l’opzione di tenerla sotto osservazione) quanto in una valutazione frettolosa o sbagliata che porta a scambiare per patologia ciò che non lo è. In tutti questi casi, il sanitario viola l’obbligo di diligenza, perizia e prudenza professionale sancito dall’art. 1176 c.c. e dalle norme speciali in materia di sicurezza delle cure (Legge Gelli-Bianco n. 24/2017).
Va sottolineato che non ogni esito insoddisfacente configura colpa: in medicina può accadere che un intervento necessario non dia i risultati sperati o che insorgano complicanze imprevedibili. Qui però stiamo trattando della situazione in cui l’intervento non andava proprio fatto. Se il paziente prova (anche tramite perizia medico-legale) che l’operazione era inutile rispetto alle condizioni cliniche, si instaura una presunzione di responsabilità a carico del medico e della struttura. Spetterà ai sanitari dimostrare il contrario, ad esempio provando che, in base alle conoscenze e ai protocolli del momento, quell’intervento appariva giustificato. In effetti, la giurisprudenza italiana da tempo agevola il paziente sul piano probatorio: una recente ordinanza della Cassazione ha confermato che, una volta dimostrati dal paziente il danno e un nesso causale anche solo probabilistico con l’operato dei medici, tocca al medico o all’ospedale provare di aver agito correttamente o che l’esito sarebbe stato lo stesso comunque (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5922/2024 del 5 marzo 2024). Questo principio, applicato ai casi di interventi non necessari, significa che se un paziente mostra di aver subìto un pregiudizio da una cura superflua, saranno il chirurgo e la struttura a dover dimostrare che invece quell’atto era giustificato secondo la lex artis o che il paziente avrebbe comunque avuto lo stesso danno senza intervenire.
Un aspetto cruciale in questi casi è il consenso informato. Il paziente ha il diritto di conoscere prima tutti i dettagli significativi: la natura dell’intervento proposto, i benefici sperabili, i rischi e anche le possibili alternative, compresa la non esecuzione dell’intervento stesso qualora non strettamente indispensabile. Fornire un modulo prestampato generico da firmare non basta: il dovere del medico è quello di personalizzare l’informazione, spiegando con chiarezza perché ritiene utile una certa procedura e quali conseguenze può comportare, inclusa l’eventualità che l’operazione risulti non risolutiva o addirittura inutile. Solo con queste informazioni il paziente può dare un consenso effettivamente libero e consapevole.
In caso di consenso informato mancante o inadeguato, la legge riconosce due possibili profili di danno risarcibile. Il primo è il già citato danno alla salute eventualmente derivante dall’intervento: se, poniamo, un paziente subisce complicanze o menomazioni da un’operazione che non avrebbe accettato se correttamente informato della dubbia necessità, tali conseguenze configurano un danno ingiusto risarcibile. Il secondo profilo, anche in assenza di specifiche complicanze, è il danno da lesione del diritto di autodeterminazione: il paziente avrebbe potuto scegliere diversamente (magari optando per una terapia conservativa o rifiutando l’intervento), e gli è stata negata questa possibilità a causa dell’omessa informazione. La Cassazione ha chiarito che questo danno sussiste in concreto solo se il paziente prova che, se adeguatamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’atto terapeutico poi rivelatosi inutile. In altre parole, l’assenza di consenso apre la strada a un risarcimento “ulteriore” rispetto al danno biologico solo quando c’è un’effettiva incidenza sulla sfera di autodeterminazione: ad esempio, se un intervento invasivo lascia esiti cicatriziali e il paziente dimostra che non si sarebbe sottoposto a tale intervento conoscendone l’inutilità o i rischi, potrà ottenere il risarcimento anche per il turbamento e la violazione della propria libertà di scelta. Viceversa, se l’informazione carente non ha influito sul processo decisionale (perché magari l’intervento sarebbe stato accettato comunque), non vi è un danno risarcibile sotto questo profilo.
In pratica, comunque, nei casi di interventi non necessari la mancanza di un consenso veramente informato è quasi sempre presente e rilevante: difficilmente un paziente, ben conscio che un’operazione comporta rischi senza un chiaro beneficio, acconsentirebbe a cuor leggero. Ecco perché i giudici tendono a valutare con rigore questo aspetto, sanzionando i sanitari che non documentano un’adeguata informazione. Come ha affermato di recente la Cassazione, se manca la prova di un consenso effettivo e dettagliato, si presume il dissenso del paziente rispetto all’atto medico (principio richiamato, ad esempio, in Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9269/2024): ciò mette i medici in una posizione di responsabilità, richiedendo loro di dimostrare di aver ottemperato ai doveri informativi.
Quando un intervento inutile viene eseguito in ospedale o in clinica, la responsabilità civile investe non solo il singolo medico, ma anche la struttura sanitaria. In base al noto principio del “contatto sociale” e all’art. 1218 c.c., l’ospedale risponde contrattualmente dei fatti colposi dei propri operatori verso il paziente. Ciò significa che la struttura ha l’obbligo di risarcire il danno causato al malato dai medici di cui si avvale, salvo poi rivalersi eventualmente su di essi. Nei casi di malasanità, questa forma di responsabilità “indiretta” dell’ente ospedaliero assicura al paziente maggiori tutele, perché l’ospedale (o la clinica) di solito ha una copertura assicurativa e una solidità patrimoniale superiore a quella del singolo dottore. Dunque, se un intervento chirurgico non necessario provoca un danno, il paziente potrà convenire in giudizio sia il medico sia la struttura, chiedendo il risarcimento in solido.
Va però fatta una precisazione per le cliniche private e i casi di medici che operano come liberi professionisti al loro interno. Se la struttura privata ha direttamente in cura il paziente (ad esempio tramite un ricovero o una prestazione concordata), allora risponde anch’essa dell’intervento ingiustificato come farebbe un ospedale pubblico. Se invece la clinica si è limitata a mettere a disposizione sale e servizi a un medico esterno scelto dal paziente (ad esempio nelle cosiddette “cliniche a gettone” o centri polispecialistici dove il professionista affitta la sala operatoria), la situazione cambia. La Cassazione ha recentemente escluso la responsabilità della casa di cura in un caso in cui un odontoiatra aveva eseguito un intervento nei locali di una clinica che gli li concedeva in locazione, senza alcun coinvolgimento organizzativo della clinica stessa (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8163/2025). In tale pronuncia si è affermato che la mera messa a disposizione di locali e attrezzature non basta a configurare un obbligo di garanzia in capo alla struttura, se il paziente era seguito privatamente dal singolo medico. Questo significa che, in contesti simili, il risarcimento andrà richiesto principalmente al medico autore dell’intervento inutile, a meno che non si provi una corresponsabilità della clinica (ad esempio per carenze igieniche, difetti attrezzature, organizzazione inadeguata, ecc.). È sempre importante, dunque, capire che rapporto lega il medico alla struttura: se c’è un rapporto di lavoro o di convenzione, la struttura risponde ex art. 1228 c.c.; se il medico era del tutto indipendente, la clinica potrebbe non essere chiamata in causa per la decisione clinica errata di effettuare una cura non necessaria.
Oltre agli aspetti civilistici (risarcimento del danno), un intervento eseguito senza necessità può assumere rilievo anche sul piano penale. In particolare, se la condotta del medico è talmente grave da integrare negligenza, imprudenza o imperizia macroscopica, e dal fatto deriva una lesione personale al paziente o addirittura il decesso, possono configurarsi reati rispettivamente di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.). Ad esempio, si pensi a un intervento non necessario che provochi al paziente un danno permanente – come la paralisi di un arto, la perdita di un senso, una cicatrice deturpante – oppure a un peggioramento tale delle condizioni da contribuire a esiti fatali: il chirurgo potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente. La valutazione in sede penale richiede di accertare il nesso causale in termini di certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” e il grado di colpa. Spesso, nei procedimenti penali per malasanità, la difficoltà sta nel dimostrare che l’atto medico non necessario è stata la causa diretta del peggioramento o della morte (specialmente se il paziente era già affetto da patologie). Tuttavia, la giurisprudenza sta ampliando la tutela penale anche ai casi di ritardo o aggravamento non letale: per la Cassazione, anche solo il prolungamento della malattia o dei tempi di guarigione causato da un errore sanitario è da considerarsi lesione punibile (si veda ad es. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 5315/2020). Questo principio può riflettersi sui casi di interventi inutili: se un paziente ha avuto un decorso post-operatorio difficile e più lungo a causa di un’operazione non necessaria, quel prolungamento della sofferenza può essere valutato come “danno alla persona” anche penalmente rilevante.
In concreto, casi di condanne penali per cure non necessarie non sono frequenti, ma esistono esempi di medici perseguiti per aver causato danni gravi con interventi inappropriati. Ad esempio, un odontoiatra esperto è stato condannato per lesioni colpose gravi dopo aver provocato la paralisi di un nervo facciale durante un’estrazione del dente del giudizio in condizioni anatomiche delicate ma non tali da giustificare quell’esito: in quel caso, pur trattandosi di un intervento forse indicato, la grave imperizia nel valutarne i rischi e nell’eseguirlo lo ha reso penalmente responsabile (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 22474/2025). Se invece il paziente muore in seguito a una procedura non necessaria (magari per complicanze anestesiologiche o settiche), al medico potrebbe essere contestato l’omicidio colposo. Ovviamente, il profilo penale richiede un grado di colpa elevato (colpa grave, violazione di protocolli fondamentali, ecc.) e un nesso certo, ed è distinto dalla causa civile: anche in assenza di condanna penale, il paziente può comunque ottenere giustizia in sede civile con prova a livello di “più probabile che non” anziché di certezza.
Per un paziente che scopra di essere stato vittima di un intervento inutile, è fondamentale attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti. In primo luogo, è consigliabile raccogliere tutta la documentazione clinica relativa al caso: cartella clinica dell’intervento, referti di esami pre- e post- operatori, eventuali consensi informati firmati, e così via. Questi documenti saranno essenziali per ricostruire l’accaduto e per una valutazione medico-legale. È opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità medica, il quale potrà avvalersi di consulenti medico-legali: una perizia preliminare indipendente aiuterà a stabilire se effettivamente l’intervento era non indicato e se ha causato danni al paziente.
Dal punto di vista legale, le strade percorribili sono principalmente due: la trattativa stragiudiziale/assicurativa oppure l’azione giudiziaria (causa civile) per risarcimento danni. La Legge Gelli-Bianco prevede, prima di andare in giudizio, un tentativo obbligatorio di risoluzione alternativa della controversia (mediazione civile oppure una particolare consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi). In tale sede, spesso si può trovare un accordo: di fronte a una perizia medico-legale che evidenzi l’errore, la compagnia assicurativa della struttura o del medico può preferire liquidare un risarcimento al paziente anziché affrontare un lungo processo dall’esito incerto. Se però la via conciliativa non dà esito, si procederà con la causa civile. In giudizio, spetterà al paziente fornire la prova del danno e del nesso causale (anche mediante presunzioni e criteri probabilistici, come detto), mentre i convenuti dovranno provare di aver agito senza colpa. I danni risarcibili comprendono: il danno biologico per le lesioni fisiche subite (temporanee e permanenti, valutate in punti percentuali di invalidità), il danno morale per la sofferenza interiore e psicologica causata dall’esperienza (incluso lo shock di aver scoperto che un’operazione invasiva era in realtà inutile), l’eventuale danno esistenziale per le ripercussioni negative sulla vita quotidiana e relazionale, oltre ai danni patrimoniali (spese mediche sostenute, costi di ulteriori cure riabilitative o correttive, mancati guadagni durante il periodo di malattia prolungato, ecc.).
Nei casi più gravi, come la perdita di un organo o un’invalidità permanente da intervento superfluo, i risarcimenti possono essere molto consistenti, in base alle tabelle del danno biologico vigenti (oggi uniformate a livello nazionale dalla Tabella Unica di cui al D.P.R. 12/2025). È importante ricordare che il diritto al risarcimento si prescrive in genere in 10 anni (se si procede per responsabilità contrattuale verso la struttura) o in 5 anni (se si agisce solo contro il medico in regime extracontrattuale, ipotesi talora applicabile dopo la L. 24/2017): per questo è essenziale muoversi per tempo. Già entro pochi mesi dall’evento, è consigliabile consultare un legale, far eseguire una CTU medico-legale in sede di ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) o in mediazione, e mettere in mora i responsabili. In questo modo si potranno cristallizzare le prove e avviare il percorso risarcitorio senza rischiare decadenze.
In conclusione, subire un intervento chirurgico non necessario è un’esperienza traumatica che comporta danni fisici e morali, ma l’ordinamento italiano fornisce gli strumenti per ottenere giustizia. Salus aegroti suprema lex – la salute del paziente è la legge suprema: quando questa viene compromessa da un errore di valutazione in eccesso, il paziente ha il diritto di essere risarcito e di vedere riconosciuta la responsabilità di chi ha sbagliato. Anche se “errare è umano”, chi veste il camice ha il dovere di non nuocere inutilmente: la legge vigila affinché a pagare le conseguenze di una cura sbagliata non sia mai la vittima, ma chi quella cura l’ha indebitamente praticata.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.