

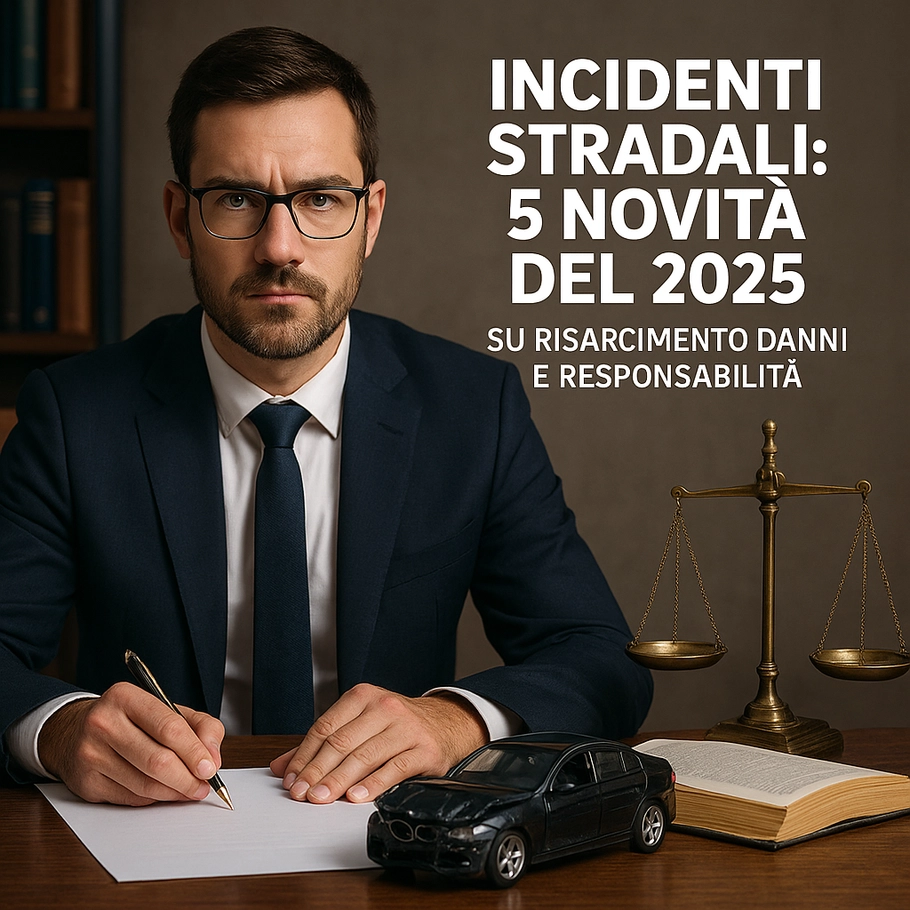
Nel campo dei sinistri stradali la tutela tempestiva delle vittime è fondamentale. Le più recenti sentenze del 2025 offrono chiarimenti importanti su risarcimento danni e responsabilità negli incidenti stradali, introducendo principi innovativi e confermando l’orientamento verso una maggiore protezione del danneggiato. Di seguito analizziamo cinque pronunce chiave della Cassazione e dei tribunali italiani, che toccano temi cruciali come l’azione diretta anche senza assicurazione, i criteri di liquidazione del danno biologico, le microlesioni in ambito di trasporto, la presunzione di corresponsabilità nei sinistri e la prescrizione nelle obbligazioni solidali. Queste novità giurisprudenziali, serie e tecniche, possono aiutare chi ha subito un incidente a capire meglio i propri diritti e gli avvocati a orientarsi nelle ultime evoluzioni normative.
Una prima e fondamentale novità è arrivata con la Cassazione civile (Sez. III, ord. 3 marzo 2025, n. 5653), la quale ha chiarito che il proprietario di un veicolo non assicurato, danneggiato in un sinistro non causato da lui, può comunque agire direttamente per il risarcimento nei confronti dell’assicurazione del veicolo responsabile. In altri termini, la mancanza di copertura assicurativa sul veicolo della vittima non gli preclude il diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore del veicolo antagonista assicurato. Questo principio impone un’interpretazione dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private conforme al diritto dell’Unione Europea, privilegiando la tutela del danneggiato.
Dal punto di vista normativo, l’art. 144 cod. ass. prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione del responsabile civile. Parallelamente, l’art. 122 dello stesso Codice impone l’obbligo di assicurazione RCA a chiunque metta in circolazione un veicolo. La Cassazione 2025 sottolinea però che questi piani sono distinti: l’obbligo assicurativo (la cui violazione comporta sanzioni amministrative) non incide sulla legittimazione ad esercitare l’azione risarcitoria. Non è quindi applicabile l’art. 1227 c.c. per escludere o ridurre il risarcimento solo perché il veicolo danneggiato era privo di assicurazione – tale circostanza infatti non è causa del sinistro, ma una violazione a sé stante. In sostanza, chi subisce un danno ingiusto in un incidente stradale ha diritto al risarcimento integrale dal responsabile assicurato, anche se circolava senza RCA.
Questo orientamento, oltre ad allinearsi ai principi UE di protezione delle vittime della strada, supera precedenti interpretazioni più punitive. Ad esempio, in passato alcune decisioni di merito avevano negato il ristoro al proprietario non assicurato ritenendo che, poiché il suo veicolo non avrebbe dovuto circolare, neppure il danno da lui patito meritasse tutela. La Suprema Corte già nel 2022 aveva però smentito tale impostazione definendola “manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tutto il Codice delle assicurazioni”, evidenziando che l’art. 122 cod. ass. (obbligo assicurativo) “non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144”, trattandosi di piani diversi. Negare il risarcimento al danneggiato senza polizza sarebbe in effetti un caso di “summum ius, summa iniuria” – applicare in modo eccessivamente rigoroso la norma assicurativa tradirebbe lo scopo ultimo di giustizia sostanziale a tutela dei feriti. La Cassazione 5653/2025 conferma dunque che il danneggiato può esercitare l’azione diretta ex art. 144 cod. ass. anche se il proprio veicolo era sprovvisto di assicurazione, sancendo definitivamente il principio pro-vittima.
(Giurisprudenza recente: Cass. civ. Sez. III, ord. 03/03/2025 n. 5653; in linea con Cass. civ. Sez. III, 17/01/2022 n. 1179).
Una seconda pronuncia di rilievo (Cass. civ. Sez. III, ord. 24 marzo 2025, n. 7841) ha ribadito il criterio temporale da adottare nella liquidazione del danno alla persona derivante da sinistro stradale. La regola affermata è chiara: il danno biologico va liquidato secondo le norme e le tabelle vigenti al momento della liquidazione (sentenza o accordo), e non in base alle norme esistenti alla data del fatto illecito. Questo significa che, se nel frattempo la legge è cambiata (ad esempio sono entrati in vigore nuovi parametri risarcitori), il giudice deve applicare quelli nuovi, in quanto incidono sulle modalità di accertamento e quantificazione del diritto e non sulla sua esistenza.
Nella fattispecie, la Cassazione ha richiamato i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) – norme introdotte nel 2012 per disciplinare il risarcimento delle lesioni micropermanenti (di lieve entità) – affermando che essi si applicano anche ai giudizi in corso relativi a incidenti avvenuti prima della loro entrata in vigore. Ciò in virtù della natura di tali disposizioni: non modificano il contenuto sostanziale del diritto al risarcimento, ma dettano criteri su come accertarlo in concreto (come già ritenuto dalla Corte Costituzionale n. 235/2014). In altre parole, se un incidente è avvenuto, ad esempio, nel 2010 ma la causa si definisce oggi, si applicano le regole attuali (ad esempio l’obbligo di riscontro clinico strumentale per il danno biologico lieve, introdotto dal 2012) invece di quelle vigenti nel 2010. Del resto, osserva la Corte, “in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev’essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”. Questo principio era già stato espresso in passato (si cita Cass. ord. 19229/2022 in materia di micropermanenti da sinistro del 2005 liquidate secondo art. 139 cod. ass. entrato in vigore successivamente) ed ora viene confermato autorevolmente.
Fa eccezione – come evidenziato dagli stessi giudici – un nuovo intervento normativo: il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico. Tale regolamento prevede espressamente l’applicazione solo ai sinistri occorsi dopo la sua entrata in vigore, derogando alla regola generale sopra detta. Dunque, per le lesioni verificatesi prima dell’entrata in vigore della TUN, continueranno a valere le tabelle e i criteri precedenti, mentre per gli incidenti successivi si applicheranno i nuovi valori uniformi a livello nazionale. Si tratta di una novità di grande interesse in ottica di armonizzazione delle liquidazioni del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La sentenza 7841/2025 ha inoltre toccato importanti aspetti processuali. In particolare, la Corte ha ribadito il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.: nei giudizi civili, i fatti allegati da una parte e non espressamente contestati dalla controparte sono da ritenersi provati, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni. Ciò incentiva le parti a chiarire fin da subito quali elementi sono controversi e quali no, snellendo il procedimento. Inoltre, la Cassazione ha richiamato la disciplina delle spese processuali in caso di rifiuto di una proposta conciliativa (art. 185-bis c.p.c.): se una parte rifiuta senza valido motivo una proposta di accordo del giudice e poi in sentenza ottiene un risultato non più favorevole di quanto avrebbe ottenuto accettando la conciliazione, potrà essere sanzionata nella regolazione delle spese legali. Questo principio sprona le parti ad accogliere soluzioni transattive ragionevoli, evitando il prolungarsi dei giudizi.
(Giurisprudenza: Cass. civ. Sez. III, ord. 24/03/2025 n. 7841).
Una terza decisione di particolare interesse (Cass. civ. Sez. III, ord. 25 maggio 2025, n. 13885) ha affrontato il tema dei danni micropermanenti (lesioni di lieve entità, tipicamente fino a 9% di invalidità permanente) subìti in ambito di un contratto di trasporto. La questione posta era se, in caso di incidente stradale occorso durante un trasporto (ad es. un passeggero su un autobus che subisce un trauma per una frenata brusca), la liquidazione del danno biologico debba seguire le regole generali del contratto di trasporto o quelle speciali previste dal Codice delle Assicurazioni per i sinistri stradali.
La Cassazione ha enunciato un principio chiaro e innovativo: “La liquidazione del danno biologico per lesioni c.d. micropermanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D.lgs. n. 209/2005 (Cod. Assicurazioni) anche quando il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore”. In altre parole, se il danno alla persona è causato dalla circolazione stradale di un veicolo, si applicano i parametri dell’art. 139 Cod. Ass. Private per quantificare il danno biologico lieve, indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato (contrattuale o extracontrattuale).
Nel caso specifico, una passeggera era caduta sull’autobus a causa di una ripartenza improvvisa del conducente, riportando lesioni guarite con un’invalidità permanente del 3-4%. In primo grado, il tribunale aveva condannato il vettore pubblico ex art. 1681 c.c. (responsabilità contrattuale del vettore) risarcendo il danno non patrimoniale secondo le tabelle del tribunale, senza applicare l’art. 139 cod. ass.. La società di trasporto sosteneva invece che anche in tale ipotesi andassero utilizzati i valori previsti per i sinistri stradali. La Corte d’Appello aveva confermato la liquidazione “contrattuale”, ritenendo di non dover applicare le regole RCA poiché la vittima non aveva nemmeno indicato una violazione specifica del Codice della Strada da parte dell’autista.
La Suprema Corte ha capovolto questo approccio, affermando che ciò che conta, ai fini dell’applicazione dell’art. 139, è il collegamento eziologico dell’evento lesivo con la circolazione stradale. L’art. 139 CdA, infatti, si riferisce al risarcimento del danno biologico per lesioni lievi “derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore”. Dunque l’elemento dirimente è che il danno alla salute sia causato dalla circolazione di un veicolo. Nel nostro caso, era evidente che la brusca manovra dell’autobus (veicolo in circolazione) fosse la causa del danno. Il fatto che la responsabilità del vettore discenda da un inadempimento contrattuale (art. 1681 c.c.) e non da un illecito aquiliano (art. 2054 c.c.) non rileva ai fini dei criteri di liquidazione: la fonte del danno rimane la circolazione stradale.
La Corte ha sottolineato che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale rientra comunque nelle obbligazioni del vettore verso il passeggero (tutela del diritto alla salute, diritto inviolabile), e può essere esercitata in sede contrattuale senza necessità di cumulare un’azione extracontrattuale. Ciò però non toglie che, nella quantificazione delle microlesioni, debbano applicarsi i medesimi parametri previsti per qualsiasi sinistro stradale, assicurando uniformità di trattamento. In definitiva, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, rinviando ai giudici di Venezia di rideterminare il risarcimento sulla base dei valori di cui all’art. 139 Cod. Assicurazioni (ovvero quelli previsti per le micropermanenti). Questo principio garantisce che, ad esempio, un colpo di frusta o altra lesione lieve subita in autobus sia risarcita né più né meno come se fosse avvenuta in auto privata, evitando disparità dovute al diverso titolo giuridico dell’azione.
(Giurisprudenza: Cass. civ. Sez. III, ord. 25/05/2025 n. 13885).
La quarta pronuncia che esaminiamo proviene da un giudice di merito, il Tribunale di Mantova (sent. 10 gennaio 2025, n. 10), ed offre spunti applicativi sulla presunzione di pari responsabilità nelle collisioni stradali e sul relativo onere della prova. In base all’art. 2054, comma 2, c.c., quando due veicoli sono coinvolti in un incidente e non è possibile determinare esattamente le rispettive colpe, si presume che entrambi i conducenti abbiano concorso in ugual misura a causare il danno (presunzione di corresponsabilità al 50%). Questa presunzione ha carattere sussidiario: opera tipicamente quando mancano prove o testimonianze certe sulla dinamica del sinistro. La sentenza mantovana ha ribadito che tale regola si applica soprattutto in assenza di testimoni oculari o di elementi oggettivi certi circa le modalità del sinistro; se non si possono ricostruire con esattezza le condotte di guida, nessuno dei conducenti può essere interamente scagionato e si opta per un concorso paritario.
Un punto cruciale chiarito dal Tribunale (in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente) è che la presunzione di pari colpa non si considera automaticamente superata nemmeno quando sia accertata una colpa evidente di uno dei conducenti. L’altro, infatti, per evitare di esserne coinvolto, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile. Se non fornisce questa prova rigorosa, la presunzione permane e il giudice dovrà comunque distribuire una parte di responsabilità anche a suo carico. In altri termini, aver individuato una grave infrazione o errore di un conducente non libera l’altro dall’onere di dimostrare la propria diligenza estrema: solo se la colpa dell’uno è stata tale da rendere impossibile qualsiasi manovra evasiva da parte dell’altro, si potrà attribuire il 100% della colpa al primo. Qualora resti anche solo il dubbio che l’altro conducente avrebbe potuto evitare l’incidente con maggiore attenzione, non è corretto esonerarlo totalmente: “pur accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l’altro non può ritenersi liberato dalla presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.”. Questo principio ricorda ai conducenti coinvolti in cause per incidenti che entrambe le condotte saranno vagliate attentamente: dimostrare la colpa altrui non basta, bisogna anche provare la propria irreprensibilità per evitare addebiti.
La stessa sentenza del Tribunale di Mantova affronta poi il tema della compensatio lucri cum damno in ambito di risarcimento del danno da incidente. Viene ribadito che dal risarcimento spettante al danneggiato vanno detratte le somme già eventualmente ricevute per lo stesso fatto a titolo di indennizzo da enti o assicurazioni. In particolare, nel caso di specie si è disposto di sottrarre dal quantum debeatur sia l’indennizzo INAIL percepito dal danneggiato (trattandosi probabilmente di infortunio in itinere o sul lavoro collegato al sinistro), sia le somme corrisposte da una polizza assicurativa privata infortuni di cui il danneggiato beneficiava. Questo perché tali importi costituiscono vantaggi economici connessi all’evento dannoso (lucro) che non possono cumularsi al risarcimento del danno (damnum), al fine di evitare una duplicazione del ristoro. Il principio della compensatio lucri cum damno, elaborato dalla giurisprudenza, impone dunque di sottrarre ciò che il danneggiato ha già ottenuto da altre fonti risarcitorie/indennitarie per il medesimo evento, prima di liquidare il saldo finale dei danni. Ciò rende il risarcimento equo e commisurato al reale pregiudizio economico subito.
(Giurisprudenza: Trib. Mantova, sez. civ., 10/01/2025 n. 10; conforme Cass. civ. Sez. III, ord. 20/11/2024 n. 29927).
L’ultima novità concerne la complessa interazione tra prescrizione e obbligazioni solidali nel caso di sinistri stradali con più soggetti obbligati in solido al risarcimento. La Corte di Cassazione (Sez. III, ord. 3 aprile 2025, n. 8837) ha stabilito un importante principio: l’eccezione di prescrizione sollevata da uno dei coobbligati solidali ha effetto estintivo dell’obbligazione risarcitoria anche a favore degli altri coobbligati, ogniqualvolta dalla mancata estensione di tale effetto deriverebbero conseguenze pregiudizievoli per chi ha eccepito la prescrizione. In altri termini, se in un incidente vi sono più responsabili civili obbligati al risarcimento in via solidale (ad esempio il conducente e la sua assicurazione), e uno di essi eccepisce validamente la prescrizione, ciò estingue l’intero debito risarcitorio verso il danneggiato per tutti i condebitori, purché ovviamente il coobbligato beneficiato non abbia rinunciato alla prescrizione né abbia omesso di eccepirla a sua volta quando ne aveva la possibilità. Questo principio evita che il danneggiato, non potendo più agire contro uno dei debitori perché il suo obbligo è prescritto, possa però rivalersi per l’intero importo solo sugli altri: una situazione che indirettamente danneggerebbe chi ha eccepito la prescrizione, il quale potrebbe trovarsi esposto ad un’azione di regresso. La Cassazione precisa comunque che se un coobbligato intende rinunciare alla prescrizione o non sollevarla, può farlo, ma in tal caso rimarrà l’unico obbligato (non potrà poi giovarsi dell’eccezione altrui).
La vicenda esaminata riguardava un sinistro stradale con decesso di uno dei conducenti e lesioni ad un trasportato sull’auto di quest’ultimo. In tale scenario, la domanda risarcitoria del passeggero veniva rivolta contro gli eredi del conducente deceduto e contro l’assicurazione di quest’ultimo (oltre che, presumibilmente, contro l’altro veicolo coinvolto rimasto in vita). La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro mortale del responsabile civile si prescrive nel termine breve di due anni, decorrenti dalla data dell’incidente. Ciò perché la morte del reo estingue ipso iure il reato (omicidio colposo o lesioni colpose) imputabile al defunto proprio alla data del decesso, che di solito coincide con il momento del sinistro stesso. Dunque non opera l’estensione della prescrizione civilistica a 5 anni (prevista dall’art. 2947 c.c. in presenza di reato) nei confronti degli eredi del conducente defunto, dato che nessun procedimento penale può proseguire a carico di chi è deceduto. Il dies a quo del termine di due anni resta la data dell’evento dannoso. Inoltre, l’eventuale pendenza di un procedimento penale verso altri soggetti coinvolti (ad esempio l’altro conducente superstite) non incide sulla posizione degli eredi del deceduto: non essendo costoro chiamati a rispondere di un reato (il reato si estingue con la morte del responsabile), la loro obbligazione civile conserva la natura di obbligazione da circolazione stradale, assoggettata al termine biennale.
Nella causa in esame l’assicuratore del veicolo del defunto, chiamato in manleva dagli eredi, ha eccepito la prescrizione biennale del diritto del trasportato. La Cassazione, applicando il principio di cui sopra, ha confermato che tale eccezione giovava anche agli eredi coobbligati, estinguendo l’azione risarcitoria pure nei loro confronti. Ha fatto eccezione solo uno degli eredi che, pur costituito in giudizio, non aveva sollevato egli stesso la prescrizione: costui è rimasto obbligato personalmente, avendo sostanzialmente rinunciato alla tutela del termine (probabilmente perché non tempestivamente eccepita in sede di merito). La regola generale che emerge è dunque questa: in una obbligazione solidale da fatto illecito stradale, l’eccezione di prescrizione di uno libera tutti i coobbligati, salvo chi volontariamente vi rinunci o resti inerte, e il termine di prescrizione in caso di decesso del responsabile decorre dalla data del sinistro, essendo da subito estinto il reato che avrebbe potuto ampliarne la durata. Ci troviamo di fronte ad un’interpretazione rigorosa, che premia la diligenza di chi eccepisce la prescrizione nei tempi giusti e penalizza invece chi resta passivo. Del resto, vigilantibus non dormientibus iura succurrunt: la legge soccorre chi vigila sui propri diritti, non chi dorme.
(Giurisprudenza: Cass. civ. Sez. III, ord. 03/04/2025 n. 8837).

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.