

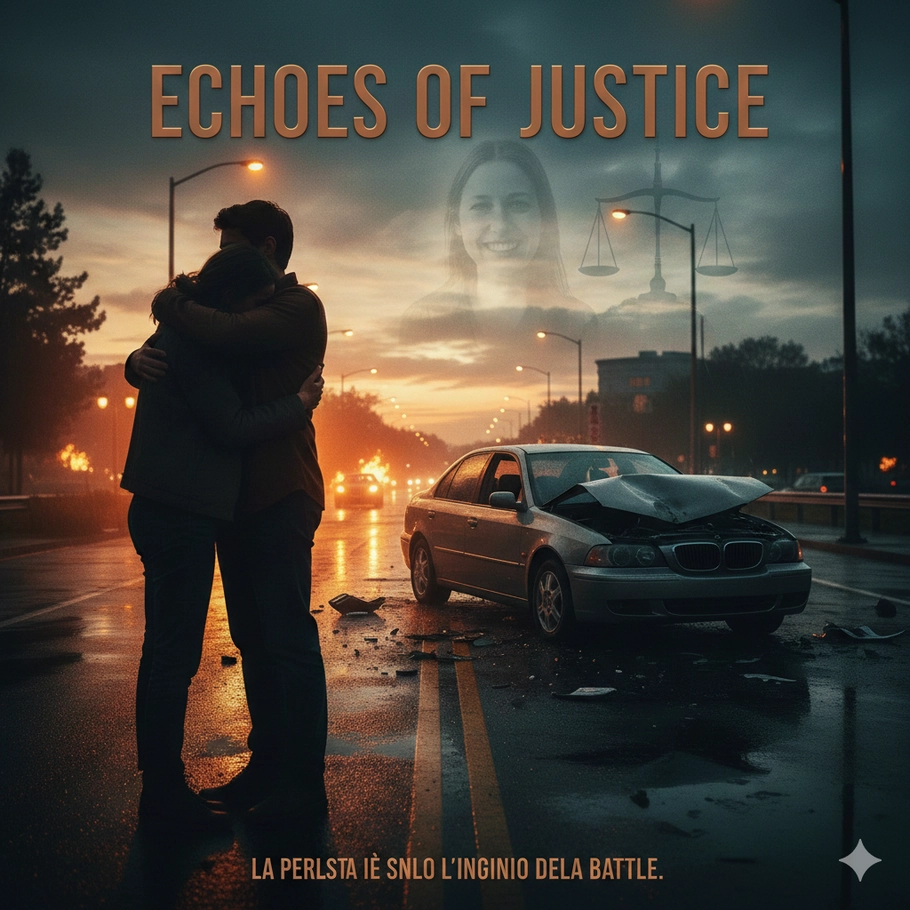
«Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria.» – Dante Alighieri
Perdere un familiare in un incidente stradale mortale comporta, oltre all’immenso dolore, anche la necessità di affrontare aspetti legali complessi per ottenere un giusto risarcimento. In ambito civilistico, il danno subito dai congiunti per la morte di una vittima viene comunemente definito danno parentale: si tratta del pregiudizio non patrimoniale che colpisce i familiari stretti a causa della perdita del rapporto affettivo, della sofferenza morale e dello sconvolgimento delle abitudini di vita. Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha rafforzato la tutela di questi soggetti, adottando un approccio sempre più sostanziale e inclusivo nel riconoscere chi può ottenere il risarcimento e come quantificare in modo equo i danni subiti.
Chi ha diritto al risarcimento: Tradizionalmente, il risarcimento del danno da perdita di un congiunto spettava ai familiari in senso stretto (coniugi, genitori, figli, fratelli), presumendo che il legame di sangue comportasse un naturale affetto e quindi una sofferenza in caso di decesso. Oggi, però, si riconosce che anche altre figure possono aver subito un analogo trauma. La Corte di Cassazione ha ribadito che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale”. In altre parole, ciò che conta è l’effettività del legame affettivo. Ad esempio, la Cassazione civile (Sez. III) con la sentenza 06/03/2025 n. 5984 ha riconosciuto il risarcimento al compagno della madre di una bambina deceduta in un incidente, pur non essendovi alcun rapporto di parentela biologica tra l’uomo e la vittima. In quel caso è stato provato in giudizio che l’uomo aveva di fatto assunto il ruolo di padre “putativo” della bambina, instaurando con lei un rapporto stabile di amore e cura: elemento sufficiente per la Suprema Corte a equipararlo a un familiare degno di tutela risarcitoria. Allo stesso modo, è ormai acquisito che il risarcimento spetta anche ai parenti non conviventi, purché sia dimostrata l’esistenza di uno stretto legame affettivo: la convivenza, un tempo ritenuta essenziale per provare la profondità del rapporto, oggi non è più un requisito minimo indispensabile. Conta la sostanza del vincolo: amicizie plasmate come rapporti di famiglia, fidanzati o conviventi more uxorio, figure come padrini o matrigne che abbiano svolto un ruolo genitoriale – tutti costoro, se possono attestare una relazione affettiva solida e quotidiana con la vittima, hanno diritto al risarcimento del danno parentale. Ovviamente il grado di parentela o vicinanza sentimentale inciderà poi sulla quantificazione: più il rapporto era stretto ed esclusivo, maggiore sarà in genere l’importo riconosciuto. Ma sul principio di legittimazione la linea è tracciata: la legge e i giudici guardano oltre lo status anagrafico, valorizzando la realtà effettiva dei rapporti umani.
Va precisato che, sebbene il dolore per la morte di un congiunto sia presunto data la natura stessa dell’evento (nessuno mette in dubbio che un genitore soffra immensamente per la perdita di un figlio, ad esempio), la giurisprudenza esige comunque che vi sia la prova – anche per presunzioni semplici – dell’effettivo pregiudizio sofferto. Ciò significa che i familiari più prossimi beneficiano di una sorta di presunzione di sofferenza (difficilmente confutabile), mentre per figure meno tradizionali o parenti più lontani diventa fondamentale dimostrare concretamente l’esistenza di quel legame affettivo e l’effetto devastante che la perdita ha avuto sulla loro vita. In quest’ottica, la convivenza, la quotidianità dei rapporti, le abitudini di vita condivise, gli eventuali progetti comuni interrotti dalla tragedia sono tutti elementi probatori che possono confermare la sussistenza e l’intensità del danno parentale. La Cassazione (Sez. III, ord. 15/11/2023 n. 31867) aveva già affermato che deve essere risarcito “qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva”, indipendentemente dal vincolo di sangue; e con una pronuncia del 2024 (Cass. civ. Sez. III, ord. 08/04/2024 n. 10416) ha chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale non è mai in re ipsa, richiedendo comunque una dimostrazione del pregiudizio effettivo, sebbene questa possa avvenire anche in via presuntiva quando si tratta di relazioni familiari strette e armoniose. In sintesi, la legge non risarcisce automaticamente chiunque dichiari di aver sofferto per una morte, ma allo stesso tempo fornisce ai prossimi congiunti un riconoscimento praticamente certo del loro diritto (salvo improbabili prove contrarie di rapporti inesistenti o conflittuali), estendendo tale riconoscimento anche a coloro che, pur fuori dall’albero genealogico stretto, possano essere considerati “famiglia” per la vittima.
Come si calcola il risarcimento: La quantificazione economica del danno parentale e degli altri pregiudizi non patrimoniali subiti dai familiari è forse l’aspetto più delicato. Il denaro non potrà mai colmare il vuoto affettivo, e proprio per questo occorre seguire criteri equi e omogenei, per evitare disparità di trattamento e arbitrarie valutazioni soggettive. In Italia, da diversi anni i tribunali fanno riferimento alle cosiddette Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (o di altre grandi città) per liquidare i danni non patrimoniali da lesione o da morte. Queste tabelle indicano un valore monetario “standard” per la perdita di un prossimo congiunto, modulato in base a vari parametri oggettivi: il grado di parentela, l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza, ecc. Ad esempio, la morte di un figlio giovane comporta un range risarcitorio tipico più elevato rispetto a quella di un fratello anziano, riflettendo l’idea che perdere un figlio in età tenera è, in via generale, un trauma ancor più devastante e contrario all’ordine naturale delle cose. Naturalmente ogni caso concreto può presentare peculiarità che giustificano un aumento dell’importo (personalizzazione in aumento) entro certi limiti: ad esempio, se il rapporto era eccezionalmente simbiotico, o se il superstite rimane totalmente privo di altri affetti o sostegni. Viceversa, circostanze attenuanti (un rapporto ormai distante, un supporto già ricevuto da altre fonti, ecc.) potrebbero, in teoria, indurre i giudici a collocare l’importo verso il minimo del range previsto. La Cassazione ha più volte avallato l’uso di queste Tabelle proprio per assicurare uniformità sul territorio nazionale: una recente sentenza (Cass. civ. Sez. III, sent. 01/08/2025 n. 22183) ha persino stabilito che il giudice d’appello deve applicare d’ufficio la versione più aggiornata delle Tabelle disponibili al momento della decisione, anche se la parte lesa non lo richiede espressamente. In pratica, se in primo grado il risarcimento era stato calcolato su parametri obsoleti (magari tabelle di anni precedenti con importi inferiori), la Corte d’Appello ha il dovere di ricalcolare il danno secondo i valori più recenti, per garantire una compensazione attuale e congrua. Inoltre, con la sentenza 2957/2025 (Sez. III, 10/02/2025) la Cassazione ha fornito un importante indirizzo metodologico: il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dev’essere quantificato mediante un sistema a punti che tenga conto in modo trasparente di tutti i fattori rilevanti (età, numero dei familiari, convivenza, intensità del legame, ecc.), prevedendo un punto di base variabile e circostanze specifiche che possano aumentare o diminuire il valore finale. Questa indicazione spinge verso l’adozione generalizzata di criteri standardizzati (sulla scia delle Tabelle milanesi aggiornate al 2022), abbandonando approcci forfettari o meramente equitativi privi di esplicita giustificazione. In sostanza, oggi chi chiede il risarcimento per la morte di un congiunto può confidare su importi allineati alle prassi nazionali e proporzionati alla gravità della perdita, con scostamenti possibili solo per tenere conto di situazioni eccezionali. Ciò garantisce da un lato certezza (casi analoghi ricevono risarcimenti analoghi) e dall’altro equità sostanziale, perché comunque il giudice ha margine per personalizzare la liquidazione quando le circostanze lo richiedono (purché motivi adeguatamente l’aumento oltre lo standard).
È importante ricordare, inoltre, che il risarcimento ai familiari in seguito a un sinistro mortale può comprendere anche voci di danno patrimoniale. Oltre al danno non patrimoniale (danno parentale in senso stretto, comprensivo del dolore morale e della perdita di godimento della vita familiare), i congiunti possono chiedere il rimborso delle spese funerarie e di altre spese sostenute a causa dell’evento (ad esempio spese mediche se la vittima è deceduta dopo un periodo di ricovero, spese di viaggio per assisterla, ecc.). Non solo: se la vittima contribuiva economicamente al mantenimento della famiglia, i superstiti (come il coniuge o i figli a carico) possono aver diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni o dei redditi che il defunto verosimilmente avrebbe fornito loro in futuro. Questo aspetto attiene al cosiddetto danno da lucro cessante per i familiari: la perdita delle entrate economiche dovuta alla prematura scomparsa del congiunto. La sua quantificazione richiede di solito di calcolare, con criteri attuariali, quanto il defunto avrebbe guadagnato negli anni restanti di vita e quale parte di quei redditi avrebbe destinato ai familiari, detraendo le quote di consumo personale. Si tratta di un calcolo tecnico che viene svolto caso per caso, spesso con l’ausilio di perizie, e che mira a ristorare i congiunti del mancato supporto economico futuro. Anche su questo fronte la Cassazione ha fornito indicazioni: ad esempio, con sentenza 15456/2025 si è affermato che nella quantificazione del danno patrimoniale futuro per i familiari occorre tener conto della concreta aspettativa di vita residua che la vittima avrebbe avuto (specie in presenza di patologie preesistenti), così da non liquidare periodi eccedenti la probabile durata della vita stessa. È un principio di logica e prudenza: se, ipotesi, il deceduto aveva già una grave malattia che ne limitava l’aspettativa di vita a pochi anni, il risarcimento per i familiari non potrà basarsi sull’idea di un sostegno economico che sarebbe durato decenni. In ogni caso, questi aspetti patrimoniali – per quanto rilevanti soprattutto quando la vittima era fonte di reddito principale – non intaccano il diritto dei congiunti al ristoro del danno morale ed esistenziale, che rimane dovuto a prescindere dalle condizioni economiche.
Danno tanatologico e danno catastrofale: Una domanda che talvolta ci si pone, come questione quasi filosofica oltre che giuridica, è se esista un risarcimento per la perdita della vita in sé, a favore degli eredi della vittima. In altri termini: al di là del dolore dei familiari, il nostro ordinamento riconosce un risarcimento per il danno subito dalla vittima consistente nella propria morte? La risposta della giurisprudenza, ribadita anche di recente, è negativa riguardo al “danno tanatologico” in senso stretto. La morte immediata non lascia spazio, in capo alla persona deceduta, ad alcuna sofferenza risarcibile: il diritto al risarcimento è infatti personale e presuppone che il soggetto leso abbia subito in vita un pregiudizio. Se la morte è istantanea o sopraggiunge dopo un periodo di incoscienza, non vi è stato per la vittima il tempo né la consapevolezza per patire una sofferenza psichica o fisica del cui risarcimento possano poi beneficiare i suoi eredi. Come affermato dalla Cassazione (Sez. III, ord. 04/02/2025 n. 2635), il danno da perdita della vita non è configurabile come autonomo diritto risarcibile iure hereditatis. Diverso, invece, è il caso in cui tra le lesioni riportate nell’incidente e il decesso intercorra un lasso di tempo durante il quale la vittima è cosciente di stare per morire, sperimentando dolore fisico e angoscia morale per la propria fine imminente. In tale circostanza si configura il cosiddetto danno catastrofale (detto anche danno terminale): è il pregiudizio psichico di intensità estrema provato dalla vittima nel lucido periodo di agonia. Questo danno, proprio perché sofferto dalla vittima prima di spirare, entra nel patrimonio giuridico della stessa e si trasmette agli eredi, i quali possono chiederne il risarcimento al responsabile. Si tratta dunque di un ristoro distinto rispetto al danno parentale: quest’ultimo attiene alla sfera dei familiari superstiti, mentre il danno catastrofale attiene alla sfera della vittima, ma viene fatto valere per loro tramite dopo la morte. La giurisprudenza è però molto rigorosa nel riconoscerlo: occorre provare in modo serio che il defunto ebbe coscienza della propria sorte incombente e ne patì uno sconvolgimento psichico apprezzabile. Spesso questa prova emerge dalle circostanze (ad esempio, testimoni che hanno udito le parole disperate della vittima intrappolata fra le lamiere, oppure dal tempo di agonia se la vittima è rimasta lucida per ore o giorni prima di morire). Se, viceversa, la morte è avvenuta dopo pochi secondi dall’impatto, o la persona è rimasta in coma fino al decesso, non vi è consapevolezza e dunque non vi è danno catastrofale da risarcire. Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, sent. 24/02/2025 n. 4776) ha proprio rigettato la domanda di risarcimento per danno catastrofale avanzata dagli eredi di una vittima, in assenza di prova che quest’ultima avesse avuto anche solo un brevissimo intervallo di coscienza prima di morire: in mancanza di coscienza, hanno spiegato i giudici, non si può parlare di sofferenza percepita, e quindi manca uno degli elementi essenziali del danno risarcibile. È bene dunque distinguere: non è risarcibile la morte in sé, intesa come evento immediato (damnum sine iniuria da questo punto di vista), mentre è risarcibile – e lo è da molti anni, con riconoscimento ormai pacifico – la sofferenza terminale consapevole patita dalla vittima tra l’evento lesivo e la morte. In termini pratici, agli eredi spetta chiedere quest’ultimo danno solo quando vi siano elementi per ritenerlo concretamente esistente nel caso specifico. In caso contrario, il risarcimento dovuto ai familiari si limiterà al loro danno parentale ed alle eventuali perdite patrimoniali, ma non comprenderà una voce di danno jure hereditatis per il defunto.
Il principio della “thin skull rule” – vittime fragili e nesso causale: Un importante corollario in tema di responsabilità civile è che il responsabile di un sinistro deve “prendere la vittima come si trova”. Questo significa che se la persona coinvolta nell’incidente aveva fragilità o condizioni di salute preesistenti che hanno aggravato gli effetti dell’evento, il danneggiante non può invocare tali condizioni per sfuggire (in tutto o in parte) alla propria responsabilità. Ad esempio, se un urto stradale di moderata entità provoca la morte della vittima perché quest’ultima aveva un cuore malato o un’osteoporosi avanzata che ha reso letali delle fratture altrimenti curabili, il fatto che la vittima fosse “già debole” non esonera chi ha causato l’incidente dal risarcire tutte le conseguenze, anche quelle più gravi. La logica è espressa dal brocardo latino cuius commoda, eius et incommoda: chi trae beneficio dall’attività che ha causato il danno (ad esempio l’uso dell’auto per spostarsi rapidamente) deve sopportarne anche gli inconvenienti, senza potersi difendere adducendo la particolare vulnerabilità altrui. La Cassazione ha affrontato proprio un caso simile con l’ordinanza 26/06/2025 n. 17179: in quel sinistro la vittima, tamponata, era deceduta in seguito a un infarto che – secondo la tesi della difesa – sarebbe comunque sopravvenuto per le sue condizioni cardiache precarie. La Suprema Corte ha invece confermato che, in materia di nesso di causa, vale il criterio del “più probabile che non”: se l’incidente ha con tutta probabilità innescato o anticipato l’evento letale, il responsabile ne risponde per intero, anche se la vittima versava già in uno stato di salute malfermo. Quello che conta, insomma, è che il sinistro abbia contribuito in maniera determinante al decesso. Se così è (e nel caso di specie le consulenze tecniche avevano accertato che il trauma dell’incidente aveva scatenato l’arresto cardiaco in una persona che altrimenti non sarebbe morta in quel momento), nessuna scusante può liberare il danneggiante. Non si può sostenere che “tanto la vittima sarebbe morta lo stesso prima o poi” o che “il suo cuore era già una bomba a orologeria”: dal punto di vista giuridico, quel che rileva è che l’illecito ha anticipato e causato il decesso, ed è dunque giusto che chi lo ha provocato risarcisca il danno nella sua interezza. Questo principio tutela in particolare le cosiddette vittime fragili: anziani, malati cronici, disabili, persone con deficienze fisiche che le rendono più vulnerabili. Nessuno vale di meno, nessuna vita “conta poco” solo perché segnata da patologie: la legge protegge il diritto alla vita e alla salute di ogni individuo nella condizione in cui si trova, senza sconti per il danneggiante. In un caso ancor più emblematico, la giurisprudenza ha escluso che si possano ridurre i risarcimenti ai genitori molto anziani per la morte di un figlio adulto non convivente: anche se l’aspettativa di vita dei genitori superstiti fosse limitata dall’età avanzata, ciò non toglie che abbiano subito la più innaturale delle perdite e che abbiano diritto a un ristoro, sia pure calibrato sulla loro specifica situazione. Allo stesso modo, non si può diminuire il risarcimento ai familiari solo perché la vittima aveva già problemi di salute che ne avrebbero abbreviato comunque la vita: se quel decesso è avvenuto qui ed ora per colpa del responsabile, tutto il danno va attribuito a quest’ultimo. In definitiva, il concetto di fondo è che il responsabile risponde delle conseguenze concrete del suo operato sul caso specifico, anche se tali conseguenze risultano più gravi a causa di fattori personali della vittima. L’evento naturale (la fragilità pregressa) non interrompe il nesso causale, a meno che – circostanza rara – non si configuri come un fatto eccezionale del tutto autonomo rispetto all’incidente (ad esempio un malore totalmente indipendente dal sinistro, coincidente per pura sfortuna con l’evento: situazione ben diversa dall’ipotesi in cui l’incidente scatena o aggrava il malore stesso).
Concorso di colpa della vittima e riduzione del risarcimento: Finora abbiamo considerato i casi in cui la vittima è del tutto innocente rispetto alla causa dell’incidente. Ma cosa accade se, al contrario, la condotta della vittima ha in qualche modo contribuito al verificarsi del sinistro o all’aggravamento delle sue conseguenze? Il nostro ordinamento prevede, all’art. 1227 del Codice Civile, che in tali ipotesi il risarcimento dovuto viene diminuito in proporzione al grado di colpa attribuibile al danneggiato. Nel contesto degli incidenti stradali mortali, ciò significa che se la vittima, con il suo comportamento, ha concorso a causare l’evento o a renderne più gravi gli esiti, l’indennizzo ai familiari potrà subire una decurtazione percentuale. Si pensi ad esempio al caso del pedone che attraversa improvvisamente fuori dalle strisce senza dare il tempo all’automobilista di frenare, oppure al motociclista che viaggiava senza casco e riporta traumi fatali che forse sarebbero stati evitati con l’utilizzo delle protezioni. In queste situazioni i giudici valutano attentamente il comportamento della vittima: se viene accertato che esso è stato causalmente rilevante (cioè ha contribuito in modo non trascurabile al verificarsi del danno), allora si applica il concorso di colpa. L’entità della riduzione dipende dalla gravità della colpa della vittima e dall’incidenza che tale condotta ha avuto sull’evento finale. Ad esempio, la giurisprudenza consolidata in tema di cinture di sicurezza stabilisce da tempo che il mancato utilizzo delle cinture da parte di chi era a bordo dell’auto può legittimare una riduzione del risarcimento per le lesioni o la morte conseguente, generalmente quantificata intorno al 20-25%. Questo perché si ritiene che una quota di quel danno (ossia l’aggravamento delle ferite o la letalità dell’incidente) sia ascrivibile alla scelta imprudente di non allacciarsi la cintura, dispositivo salvavita obbligatorio. Analogamente, il motociclista senza casco si vede solitamente decurtare una percentuale del risarcimento per i traumi cranici riportati, se viene provato che l’uso del casco avrebbe evitato o attenuato quelle lesioni mortali.
Un caso ancor più paradigmatico è stato affrontato dalla Cassazione con la sentenza 22/09/2025 n. 21896. Si trattava di un incidente mortale in cui un terzo trasportato aveva accettato incautamente un passaggio da un conducente in palese stato di ebbrezza. Purtroppo durante il tragitto si verificava un grave incidente causato dall’autista ubriaco, e il passeggero perdeva la vita. I familiari di quest’ultimo hanno ovviamente richiesto il risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile. Ebbene, la Suprema Corte – pur riconoscendo il diritto al risarcimento – ha confermato che dal totale dovuto andava sottratta una quota significativa a titolo di concorso di colpa della vittima, quantificato dapprima nel 50% e poi ridotto al 30%. In buona sostanza, un terzo dell’intero danno è rimasto a carico degli eredi della vittima, in quanto il loro congiunto, salendo volontariamente sull’auto con un guidatore evidentemente ubriaco, “ha cooperato colposamente al proprio danno”. I giudici hanno richiamato il brocardo latino «volenti non fit iniuria» – a chi acconsente non è fatto ingiusto danno – spiegando che chi accetta consapevolmente un rischio così elevato non può poi pretendere di esserne risarcito integralmente. Ciò non significa, beninteso, che la vittima perda del tutto tutela: l’ordinamento italiano, anche in casi di condotta imprudente, tende a non escludere mai in radice il diritto al risarcimento, se non quando il comportamento della vittima sia stato l’unica causa del sinistro. Nel caso appena citato, ad esempio, il fatto che il conducente fosse ubriaco e guidasse in modo pericoloso restava la causa principale dell’incidente, per cui una larga parte di responsabilità (e di risarcimento) è comunque rimasta a suo carico; tuttavia, si è ritenuto equo imputare al passeggero imprudente una fetta di corresponsabilità. Allo stesso modo, se un pedone attraversa di corsa e senza guardare, finendo investito mortalmente, i suoi parenti avranno diritto al risarcimento, ma probabilmente l’importo verrà ridotto – poniamo – del 50%, qualora risulti che nemmeno un guidatore diligente avrebbe potuto evitare l’impatto a causa dell’improvvisa condotta del pedone. In pratica, si cerca un bilanciamento: massima tutela alle vittime innocenti, ma anche responsabilizzazione di chi, pur vittima finale, abbia violato gravemente le regole di prudenza contribuendo al proprio fatale destino. È un approccio di giustizia sostanziale: il risarcimento deve sì ristorare interamente i danni causati da altri, ma non può diventare un ingiusto arricchimento o coprire anche le conseguenze di scelte sconsiderate di chi è rimasto vittima.
Giova evidenziare che, nelle controversie civili, l’accertamento del concorso di colpa della vittima (e la relativa percentuale di riduzione del risarcimento) avviene caso per caso, in base alle prove raccolte e spesso anche tramite consulenze tecniche sulla dinamica del sinistro. La semplice violazione di una regola da parte della vittima non comporta automaticamente un concorso: occorre che quella violazione abbia avuto effettiva incidenza causale. Ad esempio, il fatto che un pedone attraversasse fuori dalle strisce non esclude di per sé la colpa esclusiva del pirata della strada che lo ha investito a folle velocità; se però emerge che l’automobilista non avrebbe potuto evitare l’impatto neanche rispettando i limiti, allora la condotta imprudente del pedone diventa concausa e giustifica una riduzione. In ogni caso, l’onere di provare il concorso della vittima grava su chi lo eccepisce (di solito l’assicurazione o il responsabile civile): come ha chiarito da tempo la Cassazione, il mero addebito generico non basta, servono elementi concreti. Questo a tutela soprattutto dei familiari, affinché non vedano decurtati i loro diritti risarcitori senza una valida ragione dimostrata in giudizio.
Conclusioni: L’orizzonte normativo e giurisprudenziale attuale in materia di incidenti stradali mortali delinea un quadro di ampia protezione per i familiari delle vittime, improntato al principio per cui ad ognuno deve essere dato il suo. Chi subisce la perdita di una persona amata a causa di un fatto ingiusto altrui ha diritto a vedersi riconosciuto tutto il danno sofferto: sia quello morale ed esistenziale (il vuoto affettivo, il dolore interiore, i traumi psicologici), sia quello economico (le spese sostenute, il venir meno di un apporto reddituale fondamentale). Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e dei giudici di merito confermano e rafforzano questa impostazione: vengono rimossi formalismi e ostacoli che in passato potevano penalizzare qualche avente diritto (si pensi al compagno more uxorio non riconosciuto o all’anziano genitore considerato “troppo vecchio” per soffrire), e si tende a uniformare verso l’alto gli standard risarcitori, per assicurare ristori pieni e dignitosi. Al contempo, vi è attenzione a non trasformare il risarcimento in un benefit sganciato dalle effettive responsabilità: quando la vittima stessa ha contribuito al tragico evento violando gravemente le regole, ciò viene tenuto in conto per una questione di equità verso chi paga e – in fondo – di verità fattuale. In definitiva, l’obiettivo del sistema è duplice: garantire giustizia sostanziale ai familiari delle vittime innocenti (massima solidarietà nel lutto, tramite un risarcimento integrale) e preservare un principio di responsabilità personale, così che ciascuno risponda per la parte di colpa che eventualmente gli è attribuibile, anche quando purtroppo ne abbia pagato il prezzo più alto. In ogni caso, muoversi tra leggi, perizie, assicurazioni e sentenze non è semplice, specie in momenti di dolore così acuto: ecco perché affidarsi a professionisti esperti in infortunistica stradale è fondamentale per far valere tutti i propri diritti ed ottenere giustizia completa.

Redazione - Staff Studio Legale MP