

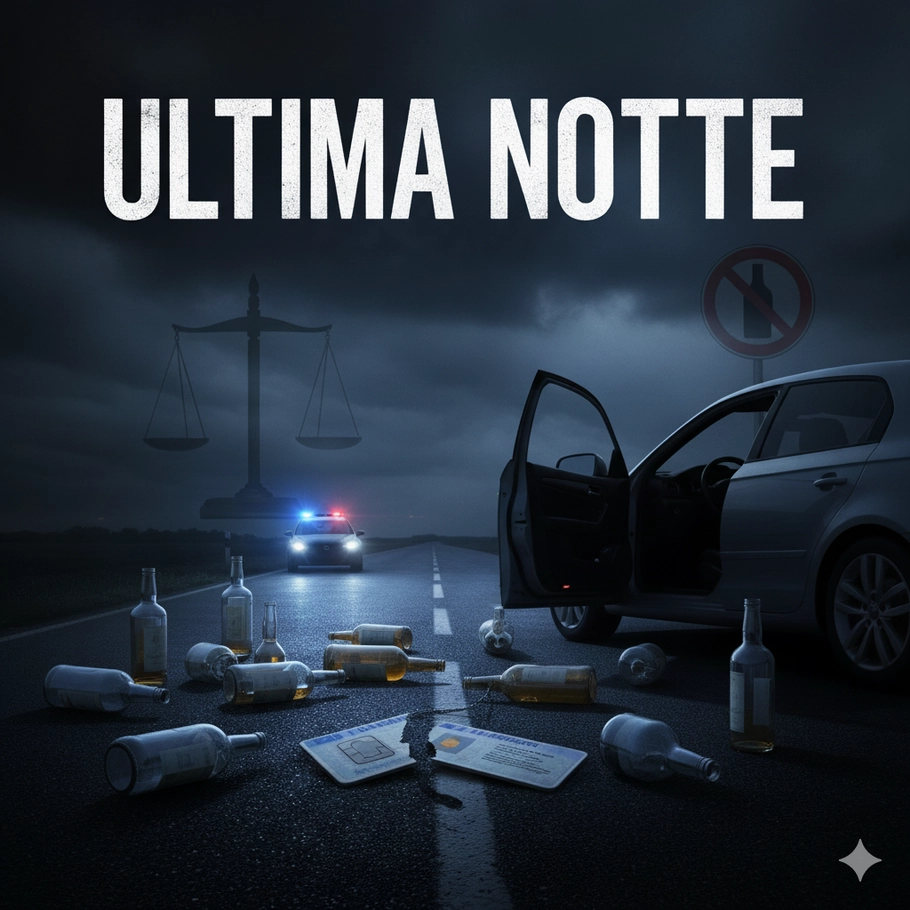
La guida in stato di ebbrezza è un reato che il Codice della Strada punisce severamente. L'art. 186 CdS prevede tre fasce di tasso alcolemico con relative sanzioni:
Tasso 0,5 – 0,8 g/l: illecito amministrativo con multa da circa 543 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Tasso 0,8 – 1,5 g/l: reato penale (prima fascia) con ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Tasso oltre 1,5 g/l: reato penale (seconda fascia) con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni. In questa fascia scattano anche la confisca del veicolo (se di proprietà del conducente) e, in caso di recidiva biennale, la revoca della patente.
Va ricordato che in presenza di aggravanti – ad esempio se il conducente provoca un incidente stradale – le sanzioni vengono raddoppiate e la legge prevede misure ancora più afflittive, come il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Guidare ubriachi, insomma, mette seriamente a rischio non solo la sicurezza stradale ma anche il proprio permesso di guida.
Negli ultimi tempi il legislatore ha ulteriormente irrigidito il regime sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza. La Legge n. 177/2024, entrata in vigore tra fine 2024 e 2025, ha introdotto una nuova sanzione accessoria: l'alcolock obbligatorio. Si tratta di un dispositivo elettronico che impedisce l'avviamento del veicolo se rileva nel conducente un tasso alcolemico superiore a zero. In base al nuovo comma 9-ter dell'art. 186 CdS, il Prefetto deve apporre sulla patente del condannato per guida in stato di ebbrezza i codici unionali 68 (divieto di assunzione di alcol) e 69 (obbligo di guidare solo veicoli dotati di alcolock) per un periodo di:
2 anni se la condanna riguarda un tasso accertato tra 0,8 e 1,5 g/l;
3 anni se il tasso accertato supera 1,5 g/l.
Queste prescrizioni si aggiungono alla normale sospensione della patente: in pratica, terminato il periodo di sospensione deciso dal giudice, il conducente potrà riottenere la patente ma dovrà attenersi a tali limitazioni. L'alcolock, a spese del trasgressore, deve essere installato sul veicolo e impedisce di fatto di mettersi alla guida dopo aver bevuto anche una minima quantità di alcol. È una misura pensata soprattutto per i recidivi e per i conducenti professionali, e rappresenta un ulteriore deterrente: in vino veritas, ma sulla strada la verità dell’etilometro non perdona.
Oltre all’alcolock, la riforma ha inasprito le sanzioni in generale, elevando gli importi delle ammende e prevedendo durate maggiori per le sospensioni in alcuni casi. L'obiettivo è chiaro: tolleranza zero verso chi guida in stato di ebbrezza. Le novità normative si integrano con un orientamento giurisprudenziale che nell’ultimo anno ha prodotto sentenze di rilievo su questo tema.
Un’importante novità giurisprudenziale arriva dalla Corte di Cassazione penale, Sez. IV, sent. n. 24614 del 4 luglio 2025, che ha affrontato un caso emblematico. Un automobilista fermato a un controllo risultava positivo all’etilometro con due valori diversi nelle due misurazioni di rito: prima rilevazione 1,56 g/l, seconda 1,32 g/l. La differenza non è di poco conto: il primo valore ricade nella fascia più grave (>1,5 g/l) comportando arresto, ammenda ai massimi, revoca della patente e confisca del veicolo; il secondo rientra nella fascia intermedia (0,8-1,5 g/l), con sanzioni più contenute e sospensione della patente ma senza revoca né confisca obbligatoria.
In primo e secondo grado i giudici avevano considerato prevalente il dato più alto, sostenendo che – data la variabilità dell'assorbimento dell'alcol – fosse più attendibile la prima misurazione. La Cassazione invece ha ribaltato questo approccio, richiamando il principio del favor rei (“in dubbio pro reo”): in presenza di due risultati discordanti, va preso in considerazione quello più favorevole all’imputato. La sentenza ha annullato la revoca della patente disposta nei giudizi di merito, chiarendo che la seconda misurazione (più bassa) doveva prevalere. In sostanza, non si può applicare la sanzione della revoca se il valore inferiore rilevato dall’etilometro non supera la soglia di 1,5 g/l prevista per tale sanzione.
Questa pronuncia, accolta con grande interesse, ribadisce che lo scopo delle due rilevazioni consecutive è proprio di garantire un esito affidabile evitando errori o oscillazioni fisiologiche. Se i numeri “ballano”, il diritto penale “respira”: il dubbio va risolto in senso favorevole al conducente. Si tratta di un’affermazione importante del diritto alla correttezza dell’accertamento, che funge da bilanciamento in un contesto normativo sempre più rigido.
Sul versante opposto, un’altra recente decisione della Cassazione ha confermato un orientamento di assoluta severità quando il tasso alcolemico è molto elevato. Con la sentenza n. 17468/2025 (depositata il 14 maggio 2025), la Cassazione penale, Sez. IV ha chiarito che – anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale sulla materia – alla condanna (o al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l consegue sempre la revoca della patente. In altri termini, il giudice penale non ha margine di discrezionalità: la legge impone che, nei casi più gravi, il colpevole perda il titolo di guida in via definitiva (salvo poter conseguire una nuova patente dopo i termini di legge). “Patente sospesa” diventa quindi un eufemismo: per i livelli di alcolemia più alti o se si causa un incidente grave, la patente viene proprio revocata, segnalando una cesura drastica e punitiva nei confronti del conducente.
Questa linea dura è coerente con la ratio di tutela della sicurezza collettiva: chi si mette al volante con un tasso alcolico elevatissimo rappresenta un pericolo grave e la risposta dell’ordinamento è la massima sanzione amministrativa sulla patente. "La legge è dura ma è la legge", verrebbe da dire richiamando il noto adagio latino: nel caso della guida in stato di ebbrezza, la dura lex si giustifica con la necessità di prevenire tragedie sulla strada.
Vale la pena sottolineare che la revoca scatta automaticamente anche in alcune situazioni particolari previste dal Codice della Strada: ad esempio, in caso di recidiva nel biennio (due violazioni art. 186 CdS in due anni) o se il conducente ubriaco provoca un incidente stradale con tasso superiore a 1,5 g/l. In queste ipotesi, l’art. 186 comma 2-bis CdS è tassativo nel disporre la revoca. La sentenza 17468/2025 conferma che neppure la concessione della sospensione condizionale della pena o altre attenuanti possono evitare questa conseguenza: la revoca della patente è un effetto ex lege inevitabile.
Un aspetto peculiare riguarda i casi in cui il procedimento penale si conclude senza condanna, ad esempio per esito positivo della messa alla prova. La messa alla prova (art. 168-bis c.p.) consente all'imputato di reati minori – come la guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi senza incidenti – di svolgere un programma di riabilitazione (lavori socialmente utili, terapie, ecc.) al termine del quale il reato viene dichiarato estinto. Ma cosa accade alle sanzioni amministrative accessorie sulla patente in questi casi?
La Cassazione penale, Sez. IV, sent. n. 33956/2025 ha fatto chiarezza: se il giudice dichiara il reato estinto per buona riuscita della messa alla prova, non può contestualmente applicare sanzioni come la sospensione o la revoca della patente. In una vicenda del 2025, il Tribunale di Ivrea aveva comunque inflitto un anno di sospensione della patente nonostante l’estinzione del reato per esito positivo della prova. La Cassazione ha annullato quel provvedimento, ricordando che in questi casi la competenza a decidere su eventuali sanzioni amministrative spetta al Prefetto ai sensi dell’art. 224 CdS, e solo se ne ricorrono i presupposti. Si tratta di una differenza procedurale rilevante: la messa alla prova elimina la condanna penale e con essa preclude al giudice penale di disporre le misure sulla patente, proprio perché manca una sentenza di colpevolezza. Diverso è il caso del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena (previsto dall’art. 186, comma 9-bis CdS in sede di patteggiamento): in quell’ipotesi la legge consente espressamente al giudice di applicare le sanzioni sulla patente (sospensione o perfino revoca) nonostante l’applicazione di una pena alternativa, trattandosi di condanna sia pure sostituita. In sintesi, probation e patente restano separati: il buon esito della probation evita all’automobilista sia la fedina penale sporca che sanzioni accessorie immediate, fermo restando che l’autorità amministrativa (Prefettura) potrà valutare provvedimenti di sospensione in via amministrativa.
Sul fronte delle contestazioni tecniche, la giurisprudenza del 2025 ha ribadito alcuni principi chiave riguardo all’etilometro, lo strumento cardine per l’accertamento dell’ebbrezza. In particolare, va segnalata la Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 26318/2025 che ha stabilito come, qualora il conducente intenda eccepire il malfunzionamento o l’inaffidabilità dell’etilometro, spetti a lui fornire elementi probatori concreti a sostegno di tale tesi. In altre parole, l’esito positivo dell’alcoltest fa piena prova dello stato di ebbrezza, essendo l’etilometro uno strumento omologato e soggetto a verifiche periodiche. Sta alla difesa eventualmente dimostrare irregolarità specifiche (ad esempio manutenzione omessa, taratura scaduta, errori tecnici documentati) per contestarne la validità. Questa posizione della Cassazione – già espressa in passato e confermata nel 2025 – mira a evitare facili scappatoie: non basta affermare genericamente che “l’etilometro potrebbe essere guasto”, occorre portare prove scientifiche o tecniche di segno contrario. In assenza di tali prove, la misurazione resta pienamente valida e il reato di guida in stato di ebbrezza risulta integrato.
Analogamente, un’altra pronuncia (Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 11892/2025) ha chiarito che il semplice fatto di essere risultati positivi all’etilometro costituisce di per sé prova dello stato di ebbrezza; sarà onere dell’imputato, eventualmente, provare circostanze eccezionali che rendano quel risultato inattendibile. È dunque consolidato l’orientamento secondo cui l’accertamento strumentale gode di una sorta di presunzione di affidabilità. Del resto, come osservato dalla Suprema Corte, l’intero sistema normativo ruota attorno all’alcoltest: l’art. 379 del Regolamento di attuazione CdS impone due misurazioni proprio per assicurare attendibilità, e non è richiesta – ai fini della condanna – nessun’altra evidenza sintomatica (come invece avveniva prima dell’introduzione degli etilometri, quando si valutavano segni clinici di ebbrezza). La tecnologia ha preso il posto degli “indizi” fisici, e il diritto si adegua: l’automatismo delle rilevazioni non esclude la difesa, ma ne alza l’asticella.
Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza non si esauriscono nell’ambito penale e amministrativo. Ubi ius, ibi remedium: ad ogni violazione corrisponde anche un profilo civilistico, in primis quello del risarcimento dei danni causati. Se un conducente ubriaco provoca un incidente, dovrà risarcire i danni a persone e cose. In tali casi interviene la compagnia di assicurazione RC Auto a indennizzare i terzi danneggiati, ma la legge e i contratti prevedono spesso una clausola di rivalsa: l’assicuratore paga la vittima ma poi può chiedere al conducente (suo assicurato) la restituzione di quanto pagato. Guidare in stato di ebbrezza rientra quasi sempre tra le cause di rivalsa. Ad esempio, una recente sentenza della Cassazione civile ha ribadito che l’assicurazione, pur dovendo indennizzare i danneggiati, può esercitare il diritto di rivalsa verso l’assicurato che ha guidato in condizioni vietate (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10394/2024). Ciò significa che chi causa un sinistro da ubriaco rischia, oltre al processo penale, anche di dover rimborsare somme ingenti alla propria assicurazione. Esistono polizze con rinuncia alla rivalsa dietro pagamento di un premio maggiorato, ma in assenza di tale garanzia l’esposizione patrimoniale è significativa.
Un tema collegato è quello della corresponsabilità del passeggero trasportato. Una pronuncia innovativa del 2025 ha stabilito che se il passeggero accetta consapevolmente un passaggio da un conducente palesemente ubriaco, può vedersi ridotto il risarcimento spettante in caso di incidente. La Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 21896/2025 del 30 luglio 2025 ha infatti affermato che la vittima trasportata concorre colposamente al danno quando sale in auto sapendo che il guidatore ha bevuto oltre il limite. In un caso tragico, i giudici hanno ridotto del 30% il risarcimento ai familiari di un passeggero deceduto, poiché era emerso che la vittima quella sera era perfettamente conscia dello stato di ebbrezza dell’amico alla guida (tasso 1,89 g/l) e tuttavia era salita ugualmente in auto. Pur ribadendo che la vita e l’integrità fisica restano beni indisponibili (nessuno “accetta” davvero di essere ferito), la Corte ha introdotto un principio di auto-responsabilità: chi è causa del suo mal pianga sé stesso, almeno in parte. In termini giuridici, ricorre l’art. 1227 c.c. (concorso di colpa del creditore) e il risarcimento può essere diminuito proporzionalmente. Questo non esonera il conducente ubriaco dalle proprie gravissime responsabilità civili, ma riconosce che anche il comportamento imprudente del danneggiato può avere rilievo causale.
Le evoluzioni normative e giurisprudenziali più recenti delineano un quadro sempre più rigoroso per chi guida in stato di ebbrezza. Da un lato, il legislatore introduce strumenti come l’alcolock e aumenta le pene accessorie, dall’altro la Cassazione consolida principi di severità (revoca automatica della patente nei casi estremi, tolleranza zero verso chi cerca scappatoie tecniche) ma anche di garanzia (favor rei in caso di accertamenti incerti, limiti ai poteri sanzionatori del giudice in caso di messa alla prova). Il messaggio è duplice: non mettersi al volante dopo aver bevuto è imperativo non solo etico ma giuridico, e chi sbaglia paga salato – in tutti i sensi; al contempo, il sistema deve essere applicato con correttezza formale, perché la legittimità delle prove e delle procedure è fondamentale per punire solo chi lo merita.
Come recita un amaro monito cinematografico: “Ogni volta che portava la bottiglia alla bocca, non era lui che la beveva: era la bottiglia che gli beveva il cervello.” (dal film Qualcuno volò sul nido del cuculo). L’abuso di alcol offusca la ragione e spesso conduce a decisioni fatali. Le norme attuali cercano di dissuadere i comportamenti a rischio con la minaccia di sanzioni durissime, ma la prima tutela viene dalla prudenza individuale.

Redazione - Staff Studio Legale MP