

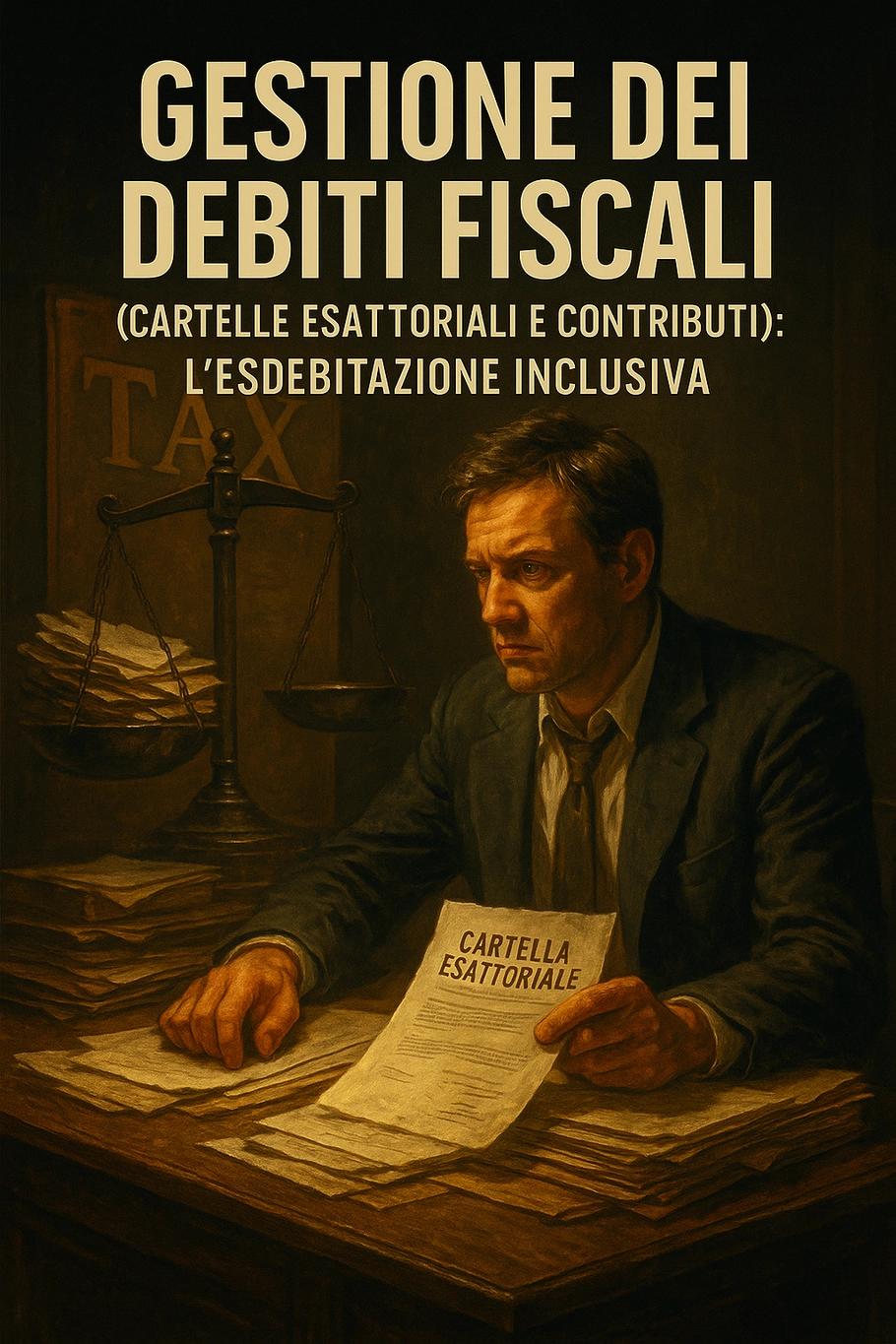
Le recenti riforme in materia di sovraindebitamento offrono ai contribuenti la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche per i debiti fiscali e contributivi. Ciò significa che, in presenza di specifici requisiti, è possibile liberarsi dal peso di cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione e di contributi previdenziali non versati, garantendo al debitore un vero “fresh start” finanziario.
I debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali rappresentano un problema diffuso e gravoso. Secondo stime recenti, circa 19 milioni di contribuenti italiani risultano avere pendenze con l’Agenzia delle Entrate. Si tratta spesso di piccoli imprenditori, lavoratori autonomi (partite IVA) o cittadini della classe media in difficoltà economica, i quali faticano ad onorare tasse e contributi e rischiano di accumulare somme ingenti. Nel tempo, queste esposizioni possono tradursi in cartelle esattoriali (o cartelle di pagamento), ovvero atti tramite cui l’Agente della Riscossione richiede il saldo di imposte o contributi non pagati, comprensivi di interessi e sanzioni.
Cartelle esattoriali non pagate comportano conseguenze molto onerose. Decorso il termine per il pagamento (tipicamente 60 giorni dalla notifica), l’ente riscossore può attivare procedure esecutive: dal pignoramento di beni mobili, immobili, conti correnti, stipendi o pensioni, fino all’iscrizione di ipoteche sugli immobili del debitore. Inoltre, sul debito originario si accumulano ulteriori oneri: interessi di mora, aggi e sanzioni per ritardato pagamento. In breve, ignorare le cartelle esattoriali può condurre a un rapido aggravio della posizione debitoria e al serio rischio di perdere il patrimonio personale o aziendale.
Va ricordato che anche gli omessi versamenti di contributi previdenziali (ad esempio i contributi dovuti all’INPS o alle casse professionali) seguono un percorso simile: l’ente creditore iscrive a ruolo il dovuto e notifica cartelle per recuperare le somme. Il debitore contributivo inadempiente può quindi subire, al pari del debitore fiscale, azioni di recupero coattivo (fermo amministrativo di veicoli, pignoramenti, ecc.) e l’addebito di sanzioni civili. I debiti verso gli enti previdenziali sono equiparati a quelli tributari per molti aspetti e spesso vengono riscossi anch’essi tramite Agenzia Entrate-Riscossione.
Di fronte a questa pressione fiscale e contributiva, il contribuente insolvente vive una situazione angosciante, spesso senza vedere vie d’uscita. Fino a qualche anno fa, i debiti verso lo Stato e gli enti pubblici erano considerati praticamente inesigibili in termini di sollievo: il principio di diritto tradizionale era “dura lex, sed lex” – la legge è dura ma va rispettata – e soprattutto nel campo fiscale valeva il rigore di pacta sunt servanda (i patti devono essere osservati). In altre parole, il debito tributario doveva essere pagato, a costo di sacrifici estremi, e poche eccezioni erano ammesse. Tuttavia, nella realtà, “ad impossibilia nemo tenetur” – nessuno è tenuto a fare l’impossibile –: molti contribuenti, schiacciati da eventi avversi (crisi economiche, perdita del lavoro, malattie, ecc.), si sono trovati oggettivamente impossibilitati a far fronte ai propri obblighi verso l’Erario. Il legislatore e la giurisprudenza hanno preso atto di queste situazioni, avviando un percorso normativo improntato a maggiore equilibrio e umanità, in cui la clemenza verso il debitore incolpevole mitiga la rigidità della legge. “A rigore di giustizia nessuno di noi troverebbe salvezza. Noi invochiamo clemenza […] e il potere terreno più si mostra simile al divino quando la clemenza mitiga la giustizia”, scrive Shakespeare nel Mercante di Venezia, ricordandoci che il diritto deve saper bilanciare la severità con la misericordia.
Chi accumula debiti fiscali spesso tenta anzitutto strade “tradizionali” per gestirli. I piani di rateizzazione con l’Agente della Riscossione consentono, quando ammessi, di diluire il pagamento in più anni, ma non eliminano il debito e anzi comportano il pagamento integrale (maggiorato di interessi) di tutte le somme dovute. Periodicamente il legislatore fiscale propone misure di definizione agevolata, come la rottamazione delle cartelle (l’ultima versione, cosiddetta “rottamazione-quater”, è degli ultimi anni) o il saldo e stralcio di alcune pendenze: queste misure permettono di ottenere uno sconto su sanzioni e interessi e di estinguere i debiti tributari versando una percentuale del dovuto. Tuttavia, si tratta pur sempre di dover pagare (seppur in parte) le somme iscritte a ruolo, entro termini prefissati e con stringenti condizioni di accesso. Chi non possiede le risorse per aderire a una rottamazione o onorare un piano di rientro non trova sollievo in tali strumenti.
Fino all’ultimo decennio, un soggetto non fallibile (come un privato cittadino, un professionista o un piccolo imprenditore sottosoglia) si trovava in un vicolo cieco di fronte a debiti fiscali insostenibili: non potendo ricorrere alle procedure concorsuali classiche (fallimento, concordato preventivo, ecc.), e non disponendo di mezzi per pagare, rischiava di restare perpetuamente inseguito dai creditori pubblici. A differenza di altri ordinamenti, in cui esisteva il “fresh start” (come la “bankruptcy discharge” statunitense) anche per le persone fisiche, in Italia il piccolo debitore era storicamente condannato a subire pignoramenti a vita, oppure a tentare difficili accordi transattivi con il Fisco, spesso senza successo. Non a caso la legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento è stata soprannominata “legge salva suicidi”: prima della sua introduzione molti debitori civili, schiacciati dai debiti (specialmente verso Equitalia, l’ente riscossore dell’epoca), cadevano nella disperazione più totale.
Con la Legge 3/2012 – e ancor più con la sua riforma attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – l’ordinamento italiano ha introdotto il concetto di esdebitazione a favore dei debitori civili sovraindebitati. Esdebitazione significa letteralmente “scancellazione dei debiti”: è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che dichiara inesigibili i debiti residui di una persona, al termine di una procedura concorsuale o di sovraindebitamento. In termini semplici, l’esdebitazione libera il debitore da tutte le obbligazioni pregresse non soddisfatte, consentendogli di ripartire da zero senza più quel fardello.
Questo istituto era già presente nella Legge Fallimentare per l’imprenditore fallito meritevole, ma la novità portata dalla L.3/2012 è stata di estenderlo anche ai soggetti “non fallibili” (consumatori, professionisti, ditte individuali fuori soglia, start-up innovative, enti non commerciali, ecc.), tramite apposite procedure:
Accordo di ristrutturazione dei debiti (ora chiamato “concordato minore” nel Codice della crisi): un piano proposto dal debitore a tutti i creditori, pubblici e privati, che diviene vincolante con l’approvazione dei creditori (almeno il 60% dei crediti) e l’omologazione del tribunale.
Piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): un piano simile al precedente ma riservato a chi non ha debiti da attività d’impresa, con la caratteristica che non richiede l’approvazione dei creditori ma solo la valutazione positiva del giudice sull’equilibrio e sulla meritevolezza del debitore.
Liquidazione controllata del patrimonio (già “liquidazione dei beni”): la procedura più drastica, in cui il debitore mette a disposizione tutti i propri beni ai creditori. Un liquidatore nominato dal tribunale li vende e ripartisce il ricavato; al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione sui debiti non soddisfatti.
Attraverso queste procedure, anche un debitore civile può ottenere la cancellazione di gran parte dei debiti insostenibili. In passato, però, restava il dubbio se debiti fiscali e contributivi potessero essere compresi in tale beneficio. Alcuni tipi di debito, infatti, per legge non sono dilazionabili né falcidiabili nelle procedure concorsuali (si pensi ad esempio all’IVA in certi concordati preventivi) oppure non erano teoricamente “perdonabili” perché derivanti da obblighi pubblicistici. La normativa sul sovraindebitamento, invece, non prevede esclusioni assolute per i debiti verso lo Stato, salvo la necessità di rispettare eventuali cause di prelazione (ad esempio i debiti tributari garantiti da ipoteca vanno trattati come un qualsiasi credito ipotecario).
Un chiarimento fondamentale è arrivato dalla Corte di Cassazione: con una decisione del 2016, gli “ermellini” hanno affermato che anche i debiti verso gli enti previdenziali (INPS, casse professionali) possono essere completamente esdebitati assieme agli altri debiti concorrenti. In quel caso (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 11 marzo 2016 n. 4844), l’INPS sosteneva che i propri crediti, in quanto di natura pubblica e obbligatoria, dovessero rimanere fuori dall’esdebitazione; la Suprema Corte ha invece rigettato questa tesi, osservando che la legge elenca tassativamente i debiti esclusi dal beneficio e non menziona affatto le contribuzioni previdenziali. Inoltre, i giudici hanno chiarito che tali contributi sono strettamente connessi all’attività d’impresa o di lavoro del debitore e non costituiscono affatto debiti “extranei” o sganciati dall’esercizio dell’attività economica. Dunque, già prima della riforma recente, la giurisprudenza di legittimità aveva posto le basi per un’esdebitazione inclusiva dei debiti verso lo Stato: il principio è che tutti i debiti concorsuali non esclusi espressamente dalla legge possono essere cancellati, incluse tasse e contributi non versati.
Il vero passo in avanti è avvenuto negli ultimi anni. A seguito della crisi economica e sanitaria, il legislatore ha accelerato la riforma delle procedure da sovraindebitamento per renderle più efficaci e accessibili. Con il Decreto Ristori (D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020) è stata introdotta, sulla falsariga del futuro Codice della crisi, una figura del tutto nuova: l’esdebitazione del debitore incapiente (priva di beni o redditi da offrire ai creditori). La norma – inserita come art. 14-quaterdecies nella L. 3/2012 – prevede che la persona fisica sovraindebitata “meritevole” e totalmente priva di patrimonio liquidabile possa chiedere al tribunale la cancellazione di tutti i suoi debiti senza dover pagare nulla ai creditori. Si tratta di un’esdebitazione a costo zero, un fresh start integrale rivolto a chi davvero non ha alcuna risorsa, neppure in prospettiva, da destinare ai creditori. È una misura di carattere premiale, che deroga al principio generale per cui i debiti dovrebbero essere onorati (limitazione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata ex art. 2740 c.c.). Di fatto, il legislatore ha riconosciuto che in circostanze estreme è preferibile offrire al debitore onesto la possibilità di riemergere dall’oppressione dei debiti, piuttosto che condannarlo all’inadempimento perpetuo.
Questa novità – definita dalla stampa anche come “esdebitazione inclusiva” perché include anche i debiti verso l’Erario e gli enti pubblici – è stata confermata e integrata dal Codice della Crisi, entrato completamente in vigore nel 2022. Oggi la disciplina organica si trova negli artt. 282-283 del D.Lgs. 14/2019. In particolare, l’art. 283 CCI regola l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, riprendendo i criterî già sperimentati con la L.3/2012 (come modificata nel 2020). La procedura prevede che il debitore depositi un ricorso in tribunale attestando la propria totale incapienza (assenza di beni liquidabili e di redditi attuali o futuri utilmente pignorabili) e chiedendo la cancellazione dei debiti. Il tribunale, verificate le condizioni di legge, emette decreto di esdebitazione, dichiarando inesigibili tutti i crediti anteriori. Va evidenziato che il beneficio non si estende ad eventuali coobbligati o fideiussori: ad esempio, se un soggetto aveva un garante, quest’ultimo resterà obbligato verso i creditori per l’intero, poiché l’esdebitazione vale solo per il debitore istante. Inoltre, l’esdebitazione non copre talune categorie di debito espressamente escluse dalla legge (in analogia a quanto avveniva per il fallito): tipicamente, gli obblighi di mantenimento (es. assegni di alimenti o familiare), le sanzioni penali e in genere i debiti derivanti da fatti illeciti non possono essere perdonati. Invece tasse, imposte e contributi rientrano tra i debiti cancellabili, senza più alcun dubbio. Lo stesso nome dato a questa nuova opportunità – ribattezzata dai media come “saldo e stralcio giudiziale” – sottolinea come persino le cartelle esattoriali possano trovare piena soluzione nell’ambito della procedura: non più tramite una parziale definizione agevolata, ma attraverso l’annullamento totale a seguito di una pronuncia del giudice.
La chiave di volta perché l’esdebitazione inclusiva funzioni, garantendo equità al sistema, è la verifica della meritevolezza (o non colpevolezza) del debitore. La legge richiede infatti che il sovraindebitato non abbia colpe gravi o comportamenti fraudolenti nella genesi dei suoi debiti o durante lo svolgimento della procedura. In altre parole, il beneficio è riservato all’“onesto ma sfortunato” e non a chi ha compiuto atti in frode ai creditori o ha contratto debiti con la dolosa premeditazione di non pagarli. Questo principio, presente fin dal 2012, resta centrale anche nella nuova esdebitazione dell’incapiente. La giurisprudenza recente di merito si è interrogata su come applicare in concreto il requisito della meritevolezza soprattutto in presenza di debiti fiscali e contributivi molto ingenti, magari accumulatisi per anni di omissioni.
Un orientamento significativo è quello espresso dal Tribunale di La Spezia (decreto 3 marzo 2022) in uno dei primi casi di esdebitazione dell’incapiente. In tale vicenda il debitore aveva principalmente debiti verso una Cassa previdenziale (oltre che debiti tributari). Il giudice ligure ha ritenuto il ricorrente meritevole, affermando un principio importante: nel caso di tasse e contributi, non si può parlare di una vera e propria “assunzione volontaria” del debito da parte del cittadino, poiché tali obblighi derivano ex lege. Di conseguenza – argomenta il Tribunale – è illogico valutare la meritevolezza basandosi sul momento di nascita di questi debiti (come si farebbe per debiti da finanziamenti volontari), dato che il contribuente non ha avuto un ruolo attivo nel “creare” il debito fiscale. In altri termini, contrarre un mutuo o usare una carta di credito è una scelta, mentre incorrere in debiti tributari (ad esempio perché il carico fiscale eccede le capacità di pagamento durante una crisi) è spesso una conseguenza obbligata della vita economica, non certo un atto voluto. Pertanto il giudice deve valutare la meritevolezza guardando alle cause dell’insolvenza e al comportamento complessivo del debitore, più che alla mera esistenza di debiti erariali. Questa impostazione, che potremmo definire di “favor debitoris”, tende a non penalizzare il contribuente per il solo fatto di avere omesso pagamenti al Fisco, se ciò è dipeso da circostanze eccezionali e indipendenti dalla sua volontà (es. perdita improvvisa del reddito, spese impreviste per motivi di salute, ecc.).
D’altro canto, la giurisprudenza pone dei paletti chiari per evitare abusi. Un caso emblematico è quello deciso dal Tribunale di Verona (Sez. II civ., decreto 7 settembre 2023, Giud. Pagliuca) riguardante proprio un debitore incapiente con un lungo storico di omessi versamenti di imposte e contributi. Il Tribunale scaligero ha negato l’esdebitazione ritenendo non meritevole il ricorrente, poiché il sistematico mancato pagamento degli obblighi fiscali protratto per anni è stato valutato come un comportamento di grave disvalore sociale, tale da escludere la buona fede richiesta. Nella motivazione si specifica che solo eventi eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del debitore (come gravi malattie, lutti, calamità naturali, perdita improvvisa ed incolpevole del lavoro, ecc.) possono giustificare l’inadempimento prolungato al Fisco senza intaccare la meritevolezza. In assenza di tali ragioni straordinarie, un contribuente che deliberatamente (o con colpa grave) ometta di pagare le imposte dovute traendo magari un vantaggio competitivo o personale indebito, non può accedere al beneficio dell’esdebitazione a costo zero. Questa decisione sottolinea come l’istituto non sia un “libera tutti” generalizzato, ma un rimedio destinato a casi limite, in cui il debitore si è trovato oggettivamente impossibilitato ad adempiere nonostante la diligenza ordinaria.
In sintesi, oggi i giudici adottano un approccio bilanciato: da un lato riconoscono che la presenza di debiti fiscali elevati non preclude di per sé l’accesso alla procedura (altrimenti verrebbero esclusi proprio i casi più comuni di sovraindebitamento, dati i tanti contribuenti in difficoltà con il Fisco); dall’altro ribadiscono che l’esdebitazione non spetta a chi ha tenuto condotte riprovevoli o abusato del sistema. Il filo conduttore è la ricerca della giustizia sostanziale caso per caso: il giudice valuta se il soggetto ha fatto tutto il possibile per evitare l’insolvenza (ad esempio, tentando di lavorare, riducendo le spese voluttuarie, cercando soluzioni per pagare) e se le sue difficoltà dipendono da fattori esterni e sfortunati. Se sì, allora il principio “nemo tenetur ad impossibilia” viene applicato – nessuno può essere tenuto a risultati impossibili – e il debitore merita l’esdebitazione integrale. Diversamente, se emergono indici di malafede o negligenza inescusabile, prevale l’esigenza di tutela del credito erariale e la domanda di esdebitazione viene respinta.
La gestione dei debiti fiscali attraverso l’esdebitazione inclusiva rappresenta una svolta epocale nel diritto concorsuale italiano. Oggi, grazie a un insieme di norme più inclusive e a una giurisprudenza attenta al contesto sociale, anche chi è oppresso dalle cartelle esattoriali e dai contributi non versati può sperare ragionevolmente in una soluzione definitiva, legale e dignitosa. Rimane cruciale affidarsi a professionisti esperti in crisi da sovraindebitamento, capaci di valutare la sussistenza dei requisiti di legge e di accompagnare il debitore nella procedura (che, pur semplificata, richiede rigore nella presentazione della documentazione e nelle attestazioni). Un esame preventivo della situazione patrimoniale e della storia debitoria consente di capire se si possa percorrere la strada dell’esdebitazione totale oppure se sia più adatto un diverso strumento (come un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti).
In ogni caso, il messaggio che emerge dalle riforme recenti è chiaro e incoraggiante: l’ordinamento italiano riconosce il diritto alla seconda chance economica. Dopo anni di incertezze, oggi i debiti con lo Stato non sono più un ostacolo insormontabile: se il contribuente ha agito onestamente e la sua insolvenza è frutto di sventure e non di frodi, la legge gli tende una mano. Si attua così, anche nel campo fiscale, quel bilanciamento tra giustizia e misericordia invocato da Portia nel Mercante di Venezia: la severità della legge viene temperata dalla clemenza, affinché dal rigore non derivi la rovina civile di chi merita di essere aiutato a rialzarsi senza debiti.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.