

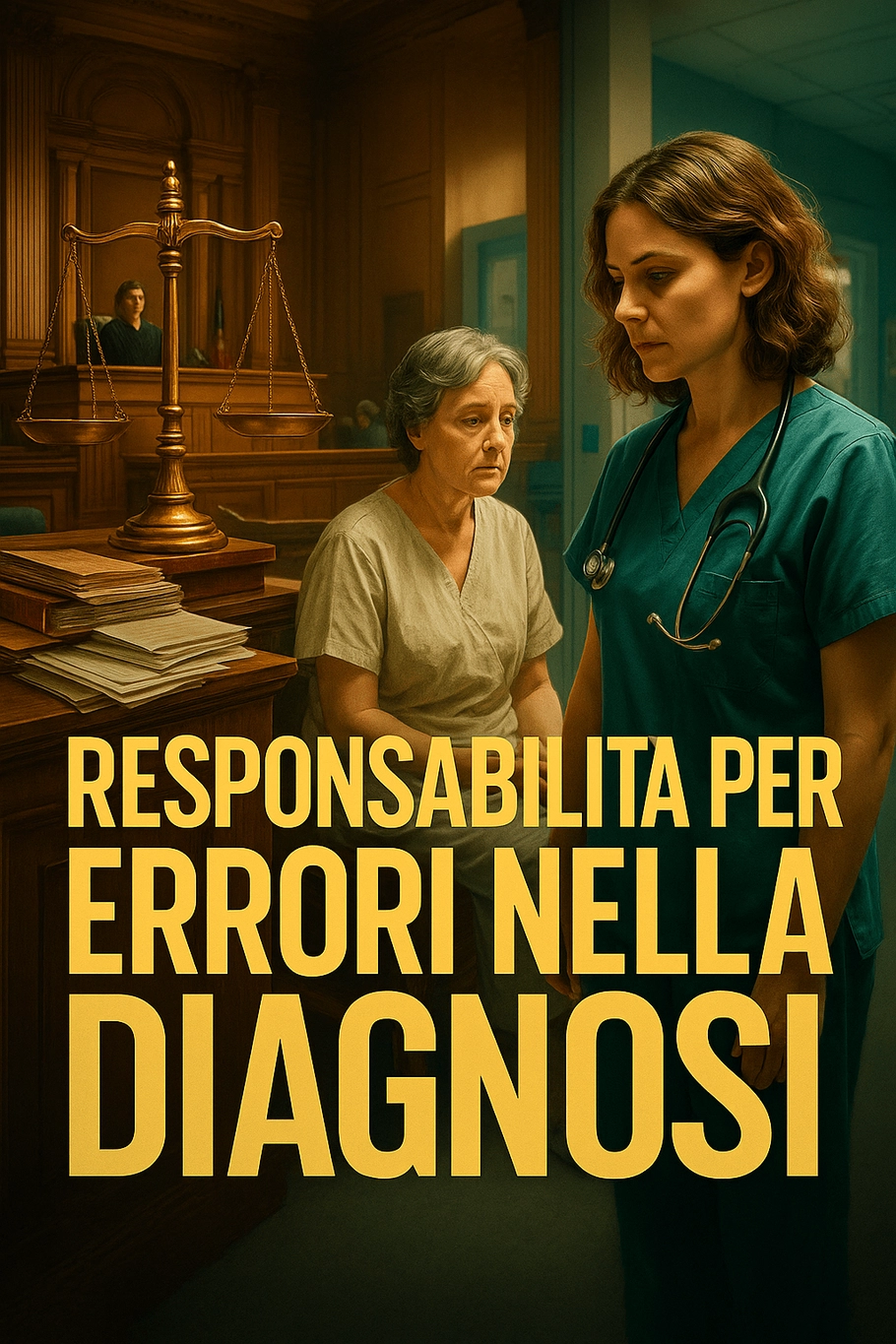
La responsabilità medica in caso di diagnosi sbagliate o tardive: un approfondimento sulle recenti sentenze (2024–2025) che chiariscono il risarcimento dei danni tra perdita di chance di sopravvivenza e tutela dei pazienti.
Una diagnosi sbagliata o comunicata in ritardo può avere conseguenze drammatiche: aggravamento della malattia o perfino il decesso del paziente. In questi casi di malasanità, la legge consente di chiedere un risarcimento, ma bisogna affrontare questioni tecniche complesse come la prova del nesso causale tra errore medico e danno, e la cosiddetta perdita di chance di guarigione o sopravvivenza. In questo articolo, con linguaggio chiaro ma rigoroso, esaminiamo la responsabilità medica per errore diagnostico alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (anni 2024–2025). Scopriremo quali diritti hanno i pazienti danneggiati e come i giudici valutano il risarcimento nei casi di diagnosi tardive o errate, integrando esempi concreti dalle sentenze più significative.
L’errore diagnostico è un errore medico che riguarda la fase di individuazione di una malattia: il medico può sbagliare diagnosi, mancandola del tutto (omessa diagnosi) o formulandola in ritardo (diagnosi tardiva), oppure scambiare una patologia per un’altra. In altre parole, si ha errore diagnostico quando, di fronte ai sintomi di una malattia, il sanitario non riesce a riconoscerla correttamente, oppure minimizza la gravità della condizione. Questo tipo di errore rientra nei casi di malasanità e può costituire un inadempimento della prestazione medica dovuta al paziente, con possibili profili di responsabilità sia civile (risarcimento del danno) sia talvolta penale (ad esempio, nei casi più gravi di colpa medica con decesso del paziente).
Va subito chiarito che non ogni complicazione o esito negativo equivale a un errore: in medicina esistono margini di rischio e possibilità di fallimento delle cure anche in assenza di colpa. Si parla di colpa medica (colpa professionale) solo quando il medico devia dai protocolli, dalle linee guida o dalla diligenza normalmente richiesta, provocando un danno evitabile. Ad esempio, non eseguire un esame diagnostico necessario, interpretare male i risultati di un test, oppure dimettere frettolosamente un paziente senza accertamenti possono essere condotte colpose se da esse deriva un peggioramento per il paziente. Il fondamento etico della professione medica è “primum non nocere”, ovvero “per prima cosa, non arrecare danno”: quando una diagnosi sbagliata viola questo principio e causa un danno, il medico e la struttura sanitaria possono essere chiamati a risponderne. In questi frangenti, il paziente (o i suoi familiari) possono agire legalmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Affinché un errore diagnostico dia diritto a un risarcimento, occorre dimostrare il nesso di causalità tra l’errore del medico e il danno subito dal paziente. In termini semplici, bisogna provare che, se la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, il paziente non avrebbe riportato quel danno (o avrebbe avuto esiti meno gravi). Questo accertamento causale è spesso la parte più complessa del contenzioso: può richiedere perizie medico-legali e valutazioni probabilistiche sugli esiti mancati. Valutare a posteriori cosa sarebbe successo “se” il medico avesse agito diversamente è un esercizio difficile – “del senno di poi ne son piene le fosse”, dice un proverbio reso celebre da Manzoni – ma il diritto ha stabilito criteri precisi.
In ambito civile vige infatti la regola del “più probabile che non” (principio della preponderanza dell’evidenza): il giudice, sulla base delle prove, deve ritenere causato dall’errore medico il danno se vi è almeno una probabilità prevalente (>50%) che, senza quell’errore, il paziente non avrebbe sofferto di quel pregiudizio.
In caso di diagnosi tardiva od omessa, occorre quindi valutare se un trattamento tempestivo avrebbe evitato o ritardato l’evento lesivo (ad esempio il decesso o un aggravamento) con ragionevole probabilità. Questo non si limita a mere statistiche, ma richiede un esame concreto di tutti gli elementi clinici disponibili nel caso specifico. Se la risposta è sì – ovvero è più probabile che sì che il paziente avrebbe avuto un esito migliore con una diagnosi corretta – allora il nesso causale è riconosciuto e il medico/struttura saranno responsabili a pieno titolo del danno. Viceversa, se risulta che una diagnosi corretta non avrebbe comunque cambiato le cose in misura significativa, il caso può essere rigettato per mancanza di nesso causale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo criterio nel valutare un caso di infarto non diagnosticato in tempo. I familiari di una paziente deceduta per infarto avevano citato la struttura sanitaria per ritardo nei soccorsi, ma i consulenti tecnici d’ufficio avevano concluso che anche un intervento tempestivo non avrebbe con maggior probabilità salvato la vita della signora. In altre parole, le chance di sopravvivenza con cure adeguate non superavano il 50%. La Cassazione, sentenza n. 2863/2025 ha così confermato il rigetto della domanda risarcitoria: pur riconoscendo la negligenza dei sanitari, tale condotta non si poneva come causa determinante, secondo il criterio del “più probabile che non”, dell’evento morte. Questo caso evidenzia che, se il paziente purtroppo non aveva prospettive concrete di salvezza neanche con cure corrette, il medico non viene ritenuto civilmente responsabile per il decesso – ferma restando la possibilità di altre responsabilità per la cattiva condotta, come sanzioni disciplinari o etiche.
Di converso, quando invece risulta probabile in modo prevalente che l’errore abbia inciso sull’esito, la Cassazione è chiara nel ritenere configurabile la responsabilità. Ad esempio, in un caso del 2025 relativo a una dissezione aortica non diagnosticata in pronto soccorso, la Suprema Corte ha censurato la decisione di merito che aveva escluso la colpa. In quella vicenda, un paziente era deceduto perché mantenuto in osservazione per ore in codice verde, senza esami adeguati, quando invece avrebbe dovuto essere trasferito d’urgenza in cardiochirurgia. La Cassazione, ord. n. 2122/2025 ha ritenuto che vi fosse un’elevata probabilità di successo (circa 75% di sopravvivenza) se il paziente fosse stato operato entro le prime 24 ore.
Dunque, l’omessa diagnosi tempestiva ha privato il paziente di un trattamento salvavita, soddisfacendo il criterio del “più probabile che non” in favore del nesso causale. La stessa pronuncia ha sottolineato che non spetta ai familiari dimostrare con assoluta certezza che l’intervento avrebbe evitato la morte; bensì, una volta provata la condotta negligente e un significativo potenziale terapeutico perduto, è la struttura sanitaria a dover provare che anche con cure corrette l’esito sarebbe stato comunque infausto. Questo principio, inquadrato nella responsabilità contrattuale del medico verso il paziente, mira ad agevolare la posizione del danneggiato: diversamente sarebbe praticamente impossibile per un paziente dimostrare “al 100%” cosa sarebbe accaduto in un mondo ipotetico privo di errore.
Spesso, nelle cause per errore diagnostico, ci si trova in una zona grigia: non si può affermare con probabilità prevalente che il paziente si sarebbe salvato o avrebbe evitato danni, ma al tempo stesso l’errore sanitario ha ridotto alcune possibilità di esito migliore. In tali situazioni entra in gioco il concetto di perdita di chance. La chance in questo contesto è la possibilità di ottenere un risultato favorevole (ad esempio la guarigione, la sopravvivenza, o anche una vita più lunga e con migliore qualità) che il paziente avrebbe avuto se correttamente curato. La giurisprudenza italiana, a partire da alcune sentenze pilota negli anni scorsi, ha riconosciuto la perdita di chance come una forma autonoma di danno risarcibile quando non sia possibile provare il pieno nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, ma vi sia comunque una probabilità apprezzabile, significativa e concreta perduta a causa dell’errore medico. In altre parole, anche se la guarigione completa non era assicurata, il paziente avrebbe avuto una certa percentuale di possibilità in più di sopravvivere o di evitare conseguenze gravi se il medico non avesse sbagliato: quella percentuale di possibilità, se seria, ha un valore giuridico ed economico.
Una chance perduta si risarcisce di regola in via equitativa, parametrando il risarcimento al grado di probabilità negato. Ad esempio, se un paziente aveva – in base alle conoscenze mediche – un 30% di probabilità di sopravvivere cinque anni in più con una diagnosi tempestiva, e l’errore gliele ha precluse, il danno da perdita di chance potrà essere quantificato come 30% del valore che si sarebbe riconosciuto per la morte (o per quei cinque anni di vita in più). Così ha fatto, per esempio, il Tribunale di Roma in una sentenza del 2024: pur non potendo stabilire con certezza il nesso diretto tra il ritardo diagnostico di un melanoma e il decesso del paziente, i giudici hanno riconosciuto che la negligenza ha ridotto significativamente le chances di sopravvivenza del malato. Hanno dunque accolto la domanda di risarcimento pro quota, condannando la struttura sanitaria a rifondere i familiari per il danno da perdita di chance di sopravvivenza, liquidato equitativamente in proporzione alla probabilità perduta e avuto riguardo alle tabelle del danno da perdita del rapporto parentale
È importante sottolineare che la perdita di chance risarcibile deve essere una possibilità concreta e realistica, non mera speculazione: occorrono basi scientifiche o dati statistici che attestino quella chance. La Cassazione ha chiarito che non sono indennizzabili chance irrisorie o puramente teoriche. Ad esempio, un ritardo diagnostico di pochi minuti su un evento acuto inevitabile non genera un danno risarcibile, mentre un ritardo di mesi nella diagnosi di un tumore aggressivo – se ha anche solo ridotto le aspettative di vita del paziente – può comportare il risarcimento di quella aspettativa in percentuale.
Quando viene accertata la responsabilità medica per un errore diagnostico (sia perché “più probabile che non” l’errore ha causato il danno, sia in termini di perdita di chance apprezzabile), si apre il capitolo della quantificazione dei danni risarcibili. Le categorie di danno in questi casi possono essere diverse, e la Cassazione recente ha fornito importanti precisazioni soprattutto nei tragici casi di decesso del paziente a causa di diagnosi errate o tardive.
In caso di morte del paziente, i familiari stretti (coniuge, figli, genitori, etc.) subiscono un danno proprio per la perdita del rapporto affettivo con il loro caro: è il cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, voce ormai riconosciuta dalla giurisprudenza e liquidata secondo specifiche tabelle (ad esempio le tabelle del Tribunale di Milano). Questo danno iure proprio spetta indipendentemente dalla colpa medica, in qualsiasi caso di morte causata da fatto illecito. Nel nostro contesto, se un errore diagnostico ha causato la morte di un paziente, i congiunti avranno diritto a questo risarcimento morale ed esistenziale per la perdita del familiare. Ad esempio, nel caso del melanoma con esito fatale citato sopra, il Tribunale ha liquidato ai familiari, oltre al danno da chance, proprio il danno da perdita del rapporto parentale, quantificandolo secondo i criteri equitativi usuali (grado di parentela, età della vittima, convivenza, ecc.).
Accanto a ciò, possono poi esistere danni subiti direttamente dal paziente prima di morire, trasmissibili agli eredi iure hereditatis. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21415/2024, ha fatto il punto su quali di questi danni “terminale” spettino agli eredi in caso di errore medico mortale. In particolare, la Suprema Corte ha distinto:
Danno biologico e morale “terminale”: se l’errore diagnostico ha solo anticipato la morte (cioè il paziente comunque aveva una malattia fatale, ma sarebbe vissuto più a lungo senza l’errore), agli eredi può spettare il risarcimento del danno biologico temporaneo sofferto dal paziente per la peggiore qualità della vita effettivamente vissuta in quello scorcio di tempo abbreviato, nonché dell’eventuale danno morale da lucida consapevolezza della fine anticipata. Quest’ultimo, detto anche danno catastrofale, ricorre se la vittima è stata cosciente, prima di morire, che la sua vita sarebbe finita prima del dovuto per via dell’errore: si pensi al malato oncologico che realizza, dopo la diagnosi tardiva, di aver perso mesi o anni di vita che avrebbe potuto avere con cure tempestive. Questo tipo di sofferenza interiore estrema viene riconosciuto e si trasmette agli eredi.
Danno da perdita di chance di sopravvivenza: se invece non è certo in che misura l’errore abbia influito sulla durata di vita (ad esempio, non possiamo stabilire esattamente quanti anni in meno il paziente abbia vissuto, ma solo che ha perso una possibilità di curarsi), allora agli eredi spetta il risarcimento della chance perduta di sopravvivere più a lungo, purché – come detto – tale chance sia seria e riconducibile con certezza causale all’errore. Questa viene valutata separatamente rispetto al danno biologico e morale.
Danno da “perdita anticipata della vita”: è il danno in sé per la vita abbreviata, a volte chiamato danno tanatologico. Ebbene, la Cassazione ha ribadito che questo tipo di danno non è in alcun caso risarcibile agli eredi come voce autonoma. La perdita della vita in sé non costituisce un diritto risarcibile trasmissibile (il defunto non può “godere” di un risarcimento per la propria vita persa). Tuttavia, attenzione: la perdita di vita anticipata viene considerata indirettamente risarcibile agli affetti stabili del defunto, come parte del loro danno da perdita del rapporto parentale – giacché i familiari hanno vissuto meno tempo insieme al loro caro proprio a causa dell’illecito.
Quindi, questo pregiudizio viene compensato ai congiunti superstiti, ma non come diritto ereditario.
Riassumendo gli orientamenti attuali: gli eredi di un paziente deceduto per malasanità diagnostica possono ottenere il risarcimento in proprio per la perdita del familiare, e subentrano inoltre nelle azioni risarcitorie che spettavano al paziente per le sofferenze subite prima della morte (sofferenza fisica, morale, consapevolezza della fine, ecc., se provate). Non possono invece chiedere un risarcimento per il valore astratto della vita persa oltre a queste voci, perché la legge (ad oggi) non lo contempla in modo autonomo.
Di fronte al sospetto di un grave errore diagnostico, è comprensibile provare smarrimento o rabbia. È importante però agire con metodo per tutelare i propri diritti. Primo passo, raccogliere tutta la documentazione clinica: richiedete la cartella clinica completa e ogni esame/rapporto medico disponibile. Questo perché la cartella è il documento chiave che registra sintomi, diagnosi formulate, terapie e interventi: eventuali omissioni o incongruenze in essa possono costituire prova della negligenza (ricordiamo che alterare o omettere dati in cartella è un illecito, come sottolineato anche da recenti pronunce penali). Secondo passo, consultare un medico legale o un esperto in valutazione del danno sanitario: uno specialista potrà esaminare il caso per capire se effettivamente vi è stato un errore e se ha causato un danno evitabile. Questa perizia preliminare vi aiuterà a decidere se intraprendere un’azione legale. Terzo passo, affidarsi a un avvocato esperto in responsabilità medica (malasanità). I casi di errore diagnostico sono tecnicamente complessi e richiedono competenze specifiche sia in ambito giuridico sia medico, quindi è fondamentale avere un legale che conosca bene la materia, sappia dialogare con i consulenti medici e sia aggiornato sulle ultime sentenze e normative.
Oggi la sensibilità verso gli errori medici è cresciuta e vi sono norme procedurali che agevolano il paziente nella ricerca di giustizia (come l’obbligo di un tentativo di conciliazione per accelerare i risarcimenti, o la possibilità di adire a fondi di garanzia in caso di insolvenza delle assicurazioni). Tuttavia, ogni caso è unico: i tempi e gli esiti possono variare a seconda della gravità del danno, della chiarezza della colpa e dell’atteggiamento della controparte (medico/ospedale e assicurazioni). È quindi consigliabile agire appena possibile, sia per evitare la prescrizione (in genere 10 anni per la responsabilità contrattuale medica, ma prima si agisce meglio è), sia per sfruttare al meglio le prove disponibili.
Contattaci: Se tu o un tuo familiare siete stati vittime di un errore diagnostico o di altri casi di malasanità, non affrontare da solo questa battaglia. Lo Studio Legale MP si occupa del campo della responsabilità medica e saprà valutare con professionalità il tuo caso. Contattaci senza impegno per una consulenza personalizzata: ti offriremo un’analisi tecnica chiara della situazione e ti guideremo nel percorso migliore per ottenere giustizia e il giusto risarcimento. In materia di malasanità, summum ius, summa iniuria – la massima severità del diritto può talvolta sembrare ingiusta – ma con l’assistenza giuridica appropriata potrai far valere i tuoi diritti e ritrovare fiducia nella giustizia.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.