

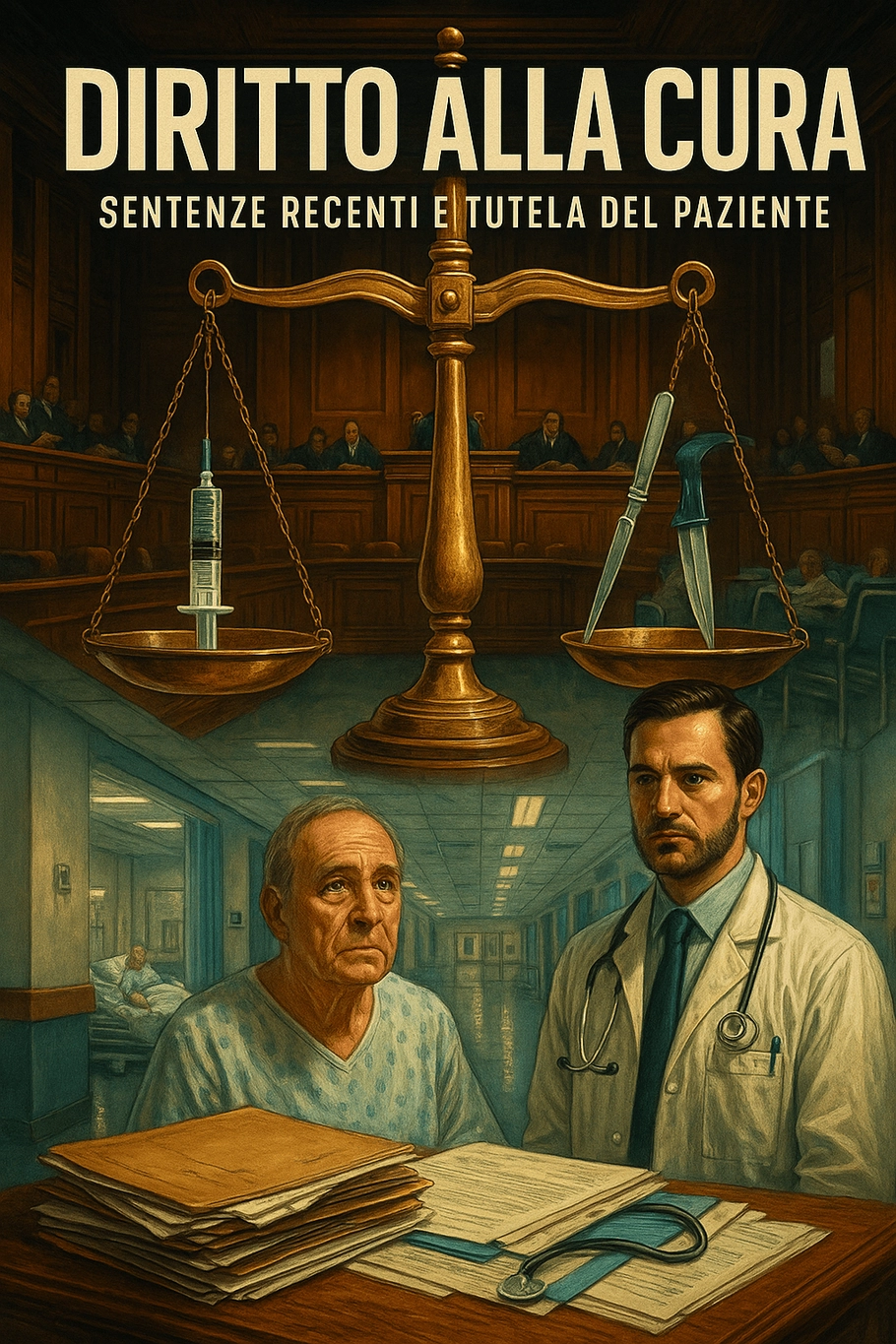
Il diritto alla cura è un principio fondamentale dell’ordinamento italiano, strettamente legato al diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. Negli anni più recenti, a fronte di liste d’attesa interminabili, carenze di risorse e bisogni crescenti, questo diritto è stato al centro di importanti interventi legislativi e giurisprudenziali. Le sentenze del 2024-2025 – dalla Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione – hanno ribadito e ampliato le tutele per i pazienti: dall’obbligo per le strutture pubbliche di garantire cure tempestive su tutto il territorio nazionale, al divieto di far gravare sulle famiglie i costi dell’assistenza sanitaria di base ai non autosufficienti, fino alla conferma del principio che la salute non può essere sacrificata per motivi di bilancio. In questo articolo esamineremo le novità normative e le pronunce chiave più recenti in tema di diritto alle cure, spiegando con linguaggio chiaro cosa significano per i cittadini e quali strumenti legali hanno a disposizione quando il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce pienamente la tutela della salute.
Il diritto alla cura rappresenta la concretizzazione operativa del diritto alla salute riconosciuto dalla Costituzione italiana. L’art. 32 Cost. proclama che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, impegnando lo Stato a garantire cure appropriate a tutti, senza distinzioni. Non si tratta solo di un principio astratto: esso implica che ogni persona, in caso di malattia o necessità sanitaria, abbia diritto a ricevere trattamenti medici adeguati, in condizioni di uguale dignità su tutto il territorio nazionale. Come scriveva acutamente Oscar Wilde, “La salute è il primo dovere della vita” – un’affermazione che evidenzia come la tutela della salute debba avere priorità assoluta nelle scelte etiche e politiche di una società.
Nel nostro ordinamento, il diritto alla cura va di pari passo con il dovere dello Stato di predisporre un sistema sanitario efficace e accessibile. La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. 833/1978) e i successivi provvedimenti (come i LEA – Livelli Essenziali di Assistenza) definiscono quali prestazioni sanitarie devono essere garantite ai cittadini. Tuttavia, la piena attuazione di questo diritto fondamentale incontra spesso ostacoli pratici: carenza di risorse, differenze regionali nell’offerta di servizi, lungaggini burocratiche e liste d’attesa eccessive. È qui che entra in gioco la funzione della giustizia e del diritto: ubi jus, ibi remedium, dove esiste un diritto deve esserci un rimedio. Le più recenti riforme normative e pronunce giurisprudenziali mostrano un trend chiaro: rendere sempre più effettivo il diritto alla cura, trasformandolo da enunciazione di principio in realtà quotidiana per ogni paziente.
Un aspetto cruciale del diritto alla cura è la tempestività delle prestazioni sanitarie. Un ritardo eccessivo in una visita, in un esame diagnostico o in un intervento può comportare aggravamenti della patologia o sofferenze evitabili per il paziente. Purtroppo, negli ultimi anni, il problema delle liste d’attesa è divenuto sempre più grave, acuito anche dall’emergenza pandemica che ha generato un forte arretrato di prestazioni non erogate.
Nel 2024 il legislatore è intervenuto con misure urgenti proprio per garantire tempi più brevi e uniformità di accesso. In particolare, il Decreto-legge 7 giugno 2024 n. 73, convertito con modificazioni nella L. 107/2024, ha introdotto una serie di novità per il governo delle liste d’attesa. Tra queste, vi è l’istituzione di una Piattaforma Nazionale delle liste di attesa (gestita da AGENAS) per monitorare in tempo reale i tempi di attesa in tutte le regioni, e soprattutto l’imposizione alle Regioni di rispettare rigorosamente i tempi massimi stabiliti per ciascuna prestazione in base alle classi di priorità clinica.
È stato previsto un obbligo chiaro: qualora una struttura pubblica non sia in grado di erogare una visita o un esame entro il tempo massimo garantito per quella priorità, l’azienda sanitaria deve attivare un percorso alternativo. In pratica, la direzione generale dell’ASL o dell’ospedale deve assicurare comunque la prestazione nei tempi dovuti, ricorrendo se necessario all’attività intramuraria (ovvero facendo effettuare la prestazione in regime libero-professionale intramoenia dentro l’ospedale, ma a carico del Servizio Sanitario Nazionale) oppure convenzionando strutture private esterne.
Queste misure vanno di pari passo con altre azioni: ad esempio, il Decreto 73/2024 ha eliminato alcuni vincoli di spesa che limitavano l’assunzione di medici e personale. Inoltre, sono state introdotte sanzioni raddoppiate per le aziende sanitarie che chiudono le liste d’attesa o sospendono le prenotazioni in violazione del divieto. Il sistema di prenotazione CUP è stato potenziato e reso obbligatorio e trasparente anche per le strutture private accreditate, con l’obiettivo di creare un’agenda unificata e visibile che eviti “buchi neri” nel monitoraggio.
Naturalmente, non basta una legge perché magicamente scompaiano le attese: la reale efficacia dipenderà dall’applicazione pratica, dai decreti attuativi e dalle risorse investite. Ma si tratta comunque di un segnale importante: il legislatore ha riconosciuto che il ritardo nelle cure costituisce una violazione del diritto alla salute, e ha delineato percorsi di garanzia.
Va sottolineato che, di fronte a liste d’attesa abnormi o dinieghi di cure, il cittadino non è privo di mezzi. Oltre a sollecitare per iscritto l’ASL (diffida tramite PEC citando la nuova normativa), è possibile attivare la via giurisdizionale. In sede amministrativa, si può proporre un ricorso al TAR – ad esempio un ricorso per silenzio-inadempimento se l’ente non risponde, oppure un ricorso avverso un eventuale rifiuto scritto di prestazione – chiedendo al giudice di ordinare all’azienda sanitaria di provvedere subito. Parallelamente, se il ritardo ha causato un danno, il paziente può agire in sede civile chiedendo un risarcimento danni all’azienda sanitaria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 195/2024, ha affermato un principio fondamentale: la tutela della salute non può essere subordinata a mere logiche contabili. In essa la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che permetteva allo Stato di ridurre i trasferimenti alle Regioni intaccando i fondi sanitari. Ha stabilito che non è ammissibile recuperare risorse riducendo quelle destinate a soddisfare i bisogni essenziali della persona, tra cui i servizi sanitari.
Viene così consacrata una sorta di clausola di salvaguardia per il finanziamento della sanità: i diritti fondamentali alla cura non possono essere sacrificati sull’altare del pareggio di bilancio.
Summum ius, summa iniuria: un’applicazione rigida e ottusamente aritmetica delle regole di bilancio rischiava di tradursi in somma ingiustizia verso i malati.
Con ordinanza n. 33394 del 19 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso riguardante il pagamento della retta di una RSA per una paziente affetta da Alzheimer. La Suprema Corte ha stabilito che occorre distinguere tra prestazioni socio-assistenziali e prestazioni sanitarie ad alta integrazione, e che queste ultime devono essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il principio generale ribadito è che quando le cure fornite hanno finalità essenzialmente sanitarie, i relativi costi non possono essere scaricati sulle famiglie. Solo l’eventuale quota di servizi a carattere sociale può prevedere una partecipazione economica dell’utente, ma mai le cure mediche necessarie.
Questa pronuncia fornisce un importante strumento di tutela: molte famiglie che in passato hanno pagato rette RSA elevate potrebbero avere diritto a chiedere la restituzione di quanto indebitamente versato, se dimostrano che si trattava di prestazioni sanitarie.
Il diritto alla cura comprende anche il diritto all’autodeterminazione terapeutica. In base alla legge 22 dicembre 2017 n. 219, ogni persona ha diritto di accettare o rifiutare qualsiasi trattamento sanitario. Voluntas aegroti suprema lex: la volontà del malato è legge suprema.
La Corte Costituzionale, sentenza n. 135/2024, è tornata sul tema del suicidio assistito, ribadendo che prima di ogni decisione deve essere garantito l’accesso alle cure palliative.
Con la sentenza n. 76/2025, la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 35 l. 833/1978 sul TSO, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di comunicare immediatamente all’interessato il provvedimento, né di ascoltare il paziente prima della convalida del giudice tutelare.
Le evoluzioni normative e giurisprudenziali degli ultimi tempi indicano che il diritto alla cura sta assumendo un ruolo sempre più concreto e tutelato nell’ordinamento italiano. Non siamo più di fronte a un principio astratto: attraverso leggi più efficaci (come quella sulle liste d’attesa) e pronunce coraggiose dei giudici, si stanno costruendo strumenti operativi perché ogni individuo possa davvero ricevere le prestazioni di cui ha bisogno, nei tempi giusti e senza discriminazioni.
“La sanità è un diritto, non una voce di bilancio”: questo concetto riassume il cammino verso un sistema che metta davvero il paziente al centro. Come scriveva Manzoni, “il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.