

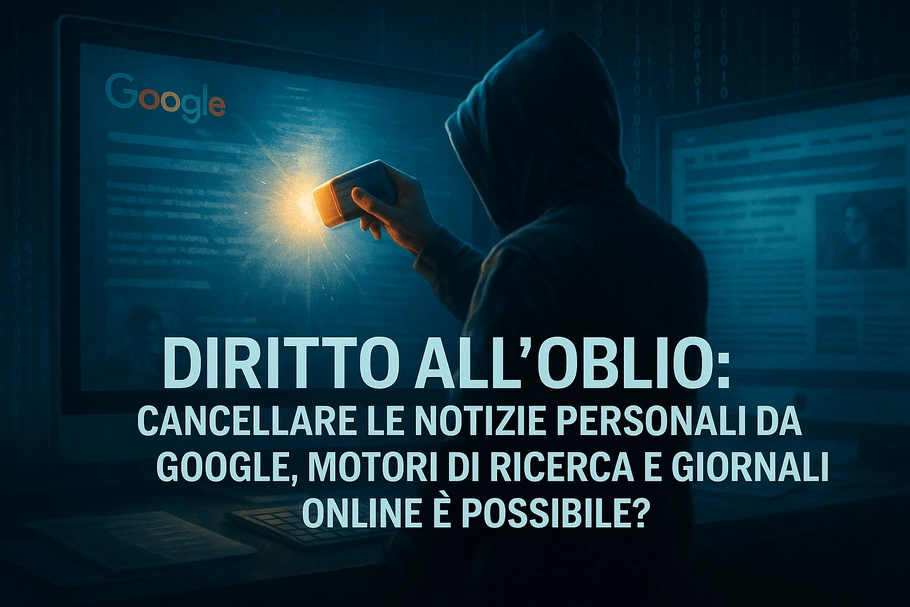
Una panoramica aggiornata sul “diritto all’oblio” e sulla cancellazione delle informazioni personali dal web: come la normativa sulla privacy e le più recenti sentenze italiane ed europee disciplinano la rimozione di notizie dai motori di ricerca e dagli archivi online dei giornali, tra tutela della reputazione individuale e diritto di cronaca.
Il diritto all’oblio è il diritto di un individuo a non rimanere esposto indefinitamente a informazioni sul proprio conto che, pur essendo state in passato di pubblico interesse, oggi risultano superate e non più attuali. In altre parole, è il diritto personale a “non essere più ricordato dalla collettività per fatti legittimamente oggetto di cronaca in un periodo ormai passato”. Si tratta di una forma di tutela dell’identità personale e della reputazione, strettamente collegata al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Proprio quest’ultima trova riconoscimento a livello europeo nell’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali UE e, in Italia, negli artt. 2 e 21 della Costituzione (tutela dei diritti inviolabili e libertà di espressione).
In origine il diritto all’oblio è nato per via giurisprudenziale, cioè attraverso le sentenze dei giudici, ed è stato per lungo tempo privo di una disciplina positiva. Oggi però è espresso nella normativa privacy europea: l’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) prevede il “diritto alla cancellazione” dei dati personali, definito proprio come “diritto all’oblio”. Il GDPR, applicabile dal 2018 e recepito in Italia con il D.lgs. 101/2018, elenca specifici presupposti in presenza dei quali una persona può chiedere ai titolari del trattamento la cancellazione dei dati che la riguardano “senza ingiustificato ritardo”. Tra questi presupposti rientrano ad esempio:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti;
l’interessato revoca il consenso al trattamento (e non sussiste altro fondamento giuridico per continuarlo);
i dati sono stati trattati illecitamente;
oppure va adempiuto un obbligo di cancellazione previsto dalla legge.
Viceversa, lo stesso art. 17 GDPR specifica anche limiti e eccezioni al diritto all’oblio: la cancellazione non va eseguita quando il trattamento dei dati rimane necessario, ad esempio, per l’esercizio della libertà di informazione, per motivi di interesse pubblico (sanità, ricerca storica o statistica) o per l’accertamento di un diritto in sede giudiziaria.
In sintesi, il diritto all’oblio non è un diritto “assoluto” e incondizionato, ma convive con altri diritti di pari rango. Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, esso deve essere bilanciato caso per caso con valori fondamentali come la dignità e identità personale da un lato, e la libertà di espressione e di informazione dall’altro. Proprio questo bilanciamento tra privacy individuale e interesse pubblico all’informazione è al centro delle decisioni più recenti in materia.
Un antico adagio latino recita: «verba volant, scripta manent» – le parole volano, gli scritti rimangono. Mai come nell’era di Internet questo detto si rivela vero: una notizia riportata online resta accessibile potenzialmente per sempre. Il diritto all’oblio nasce dunque per proteggere gli individui dai pregiudizi derivanti dalla “memoria indelebile” del web, soprattutto quando certe informazioni, sebbene veritiere, non hanno più alcuna attualità o rilevanza pubblica. D’altro canto, esiste un interesse della collettività a conservare la memoria storica di vicende e personaggi, interesse garantito dalla libertà di stampa e di cronaca (art. 21 Cost.) e dalla funzione documentale degli archivi giornalistici. Ne consegue che ogni richiesta di rimozione o deindicizzazione di contenuti deve essere valutata con attenzione, bilanciando reputazione personale e diritto di cronaca.
La Cassazione italiana ha delineato con chiarezza questo bilanciamento in alcune pronunce chiave. Già le Sezioni Unite della Cassazione nel 2019 (sentenza n. 19681/2019) hanno stabilito un importante principio di diritto: la menzione dei dati identificativi di persone coinvolte in vicende del passato è lecita solo se tali persone, al momento attuale, destano un interesse pubblico – ad esempio per la loro notorietà o per il ruolo pubblico ricoperto. Fuori da queste ipotesi, prevale l’esigenza di tutelare la persona dall’indebito pregiudizio di un’esposizione perpetua. In altre parole, non si può essere “gogne mediatiche” eterne per fatti ormai remoti.
Su questo solco, le pronunce più recenti hanno ulteriormente dettagliato i limiti del diritto all’oblio in rapporto al diritto di cronaca. Ad esempio, con l’ordinanza n. 3013/2024 (Cassazione, Sez. III Civile) è stato ribadito che il diritto all’oblio può essere compresso a favore del diritto di cronaca solo in presenza di precisi presupposti. In particolare, la Corte di Cassazione 2024 ha elencato una serie di condizioni che legittimano la permanenza online di una notizia con dati personali, nonostante il tempo trascorso:
Interesse pubblico attuale relativo all’immagine o alla notizia in questione;
Interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia (es. rilevanza presente dei fatti narrati);
Notorietà del soggetto coinvolto (personaggio pubblico o che riveste un ruolo pubblico di rilievo);
Verità della notizia e modalità espositive corrette, non eccedenti rispetto allo scopo informativo e prive di insinuazioni personali;
Rispetto del diritto di replica della persona menzionata (cioè possibilità per l’interessato di fornire la sua versione dei fatti).
Solo se tutti questi requisiti sono soddisfatti la libertà di informazione potrà prevalere sul diritto all’oblio. Fuori da queste condizioni, invece, la persona ha diritto a ottenere l’eliminazione o l’aggiornamento delle notizie che la riguardano. Come affermato in una celebre frase letteraria di Milan Kundera, “la lotta dell’uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l’oblio”. In uno Stato di diritto democratico, però, questa “memoria” collettiva non può spingersi fino a schiacciare la dignità individuale: va trovata una giusta misura, affinché la memoria storica non si trasformi in un pregiudizio perenne verso l’individuo. Il bilanciamento va operato in concreto dai giudici caso per caso, considerando la natura dei fatti, il tempo trascorso, il ruolo della persona e l’attualità dell’interesse pubblico.
Con l’avvento di Internet, il motore di ricerca (Google in primis) è divenuto lo strumento principale attraverso cui chiunque può reperire informazioni su una persona in pochi secondi. Il diritto all’oblio, in ambito digitale, si realizza spesso tramite la deindicizzazione: anziché cancellare completamente una notizia dal sito dov’è pubblicata, si interviene eliminando dai motori di ricerca i collegamenti (link) verso quella pagina, almeno quando la ricerca è effettuata a partire dal nome dell’interessato. In tal modo l’informazione non viene “soppressa” dal web, ma resasi molto meno visibile: resterà accessibile solo tramite l’archivio del sito originario (es. il sito del giornale) o con ricerche particolarmente mirate, ma non comparirà più tra i risultati cercando il nome della persona.
Il diritto all’oblio “digitale” è stato inaugurato a livello europeo dalla famosa sentenza Google Spain della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, causa C-131/12. In quel caso, riferito a un cittadino spagnolo i cui vecchi annunci di debiti erano ancora reperibili online, la Corte di Lussemburgo stabilì che il gestore di un motore di ricerca è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine web indicizzate e, su richiesta dell’interessato, può essere obbligato a rimuovere i link a pagine “inadeguate, irrilevanti o non più rilevanti” rispetto alle finalità del trattamento (cioè rispetto all’informazione originaria). Da allora, Google e gli altri motori di ricerca hanno predisposto procedure dedicate: è possibile inviare una richiesta di deindicizzazione compilando moduli online, che viene valutata caso per caso. Se il motore di ricerca rifiuta la deindicizzazione, l’interessato può rivolgersi all’Autorità Garante Privacy o al giudice per far valere i propri diritti.
Numerose pronunce recenti hanno affinato i contorni del diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca. Un tema caldo è quello della portata territoriale della deindicizzazione: la rimozione deve riguardare solo le versioni europee del motore (es. google.it, google.fr) o anche quelle extra-UE (.com, .jp ecc.)? Sul punto in passato la Corte di Giustizia UE aveva chiarito che il diritto europeo non impone il cosiddetto global delisting (cioè la deindicizzazione globale su tutti i domini), ma neppure lo vieta, lasciando la scelta alle legislazioni nazionali. La Corte di Cassazione italiana, con sentenza n. 34658/2022 depositata il 15 novembre 2022, ha compiuto un importante passo avanti: ha riconosciuto che in Italia è legittimo ordinare a Google la deindicizzazione “mondiale” di un risultato, se ciò risulta necessario a tutelare efficacemente i diritti dell’interessato. Il caso riguardava un professionista coinvolto anni prima in un’indagine penale poi archiviata perché infondata. Egli, risiedendo fuori dall’Europa, lamentava che le notizie superate su di lui fossero ancora facilmente accessibili tramite Google.com nel paese estero in cui viveva. La Cassazione ha stabilito che il giudice (o il Garante Privacy) italiano può, dopo adeguato bilanciamento tra privacy e interesse pubblico, ordinare la rimozione dei link non solo dalle versioni UE di Google ma anche da quelle extraeuropee, quando ciò sia necessario per dare piena tutela alla persona. In sostanza, “il diritto alla protezione dei propri dati personali […] non tollera limitazioni territoriali”, soprattutto se i dati in questione riguardano la reputazione e l’identità della persona.
Un altro aspetto delicato è la gestione delle “copie cache” dei motori di ricerca. Google e altri motori spesso conservano copie temporanee (cache) delle pagine web indicizzate, visualizzabili dagli utenti anche se il contenuto originale viene modificato o rimosso. Cosa accade se una pagina viene deindicizzata dai risultati per nome, ma rimane accessibile tramite altre chiavi di ricerca o tramite la cache? La Cassazione, sentenza n. 3952 dell’8 febbraio 2022, ha affrontato proprio il tema della cancellazione delle copie cache relative a informazioni non più attuali. La Suprema Corte ha chiarito che la rimozione della cache non consegue automaticamente alla deindicizzazione per nome, ma richiede un’ulteriore verifica comparativa degli interessi in gioco. In pratica, occorre bilanciare da un lato il diritto all’oblio dell’interessato, e dall’altro il diritto del pubblico di continuare ad accedere a quell’informazione tramite ricerche alternative (ad esempio mediante parole chiave diverse dal nome). Solo se, all’esito del bilanciamento, prevale l’interesse della persona, allora si potrà ordinare al motore di ricerca di eliminare anche la copia cache della pagina. Questo approccio evita soluzioni “automatiche” e impone un’analisi caso per caso: la deindicizzazione tutela la persona dall’associazione immediata nome→notizia, ma la rimozione totale di ogni traccia (cache inclusa) va valutata con maggiore cautela, specie se l’informazione può ancora avere un interesse pubblico residuale.
Infine, una novità di rilievo a livello europeo: la Corte di Giustizia UE ha recentemente rafforzato la tutela del diritto all’oblio nei confronti di informazioni false o inesatte. Con la sentenza dell’8 dicembre 2022 (causa C-460/20, Google contro CNIL), la CGUE ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca deve deindicizzare i contenuti indicizzati che risultino manifestamente inesatti, a condizione che sia l’interessato a fornire la prova di tale inesattezza. Importante, la Corte ha chiarito che l’interessato non ha bisogno di ottenere prima una sentenza in tribunale contro il sito web originario: può essere sufficiente dimostrare al motore di ricerca, con documenti o fonti attendibili, che l’informazione è chiaramente falsa o fuorviante. Questo principio – affermato in un caso riguardante due dirigenti la cui reputazione era lesa da articoli critici e immagini fuori contesto – segna un progresso significativo: il diritto all’oblio include anche il diritto a non essere associati nei risultati di ricerca a notizie gravemente inesatte. Resta fermo, comunque, che spetta alla persona fornire elementi di prova dell’errore; il motore di ricerca diventa così arbitro di un primo vaglio sulla veridicità dei contenuti indicizzati.
Oltre ai motori di ricerca, l’altra dimensione cruciale del diritto all’oblio riguarda i siti degli editori e i giornali online. Infatti, anche se un contenuto non compare più su Google, rimane comunque pubblicato nell’archivio del quotidiano o della testata che lo ha originariamente diffuso. È quindi fondamentale capire quando un editore è tenuto a rimuovere o modificare una notizia nel proprio archivio a tutela dell’oblio dell’interessato.
Su questo fronte, una sentenza molto significativa è l’ordinanza n. 2893/2023 della Cassazione (Prima Sezione Civile), che ha affrontato il caso di tre cittadini coinvolti decenni prima in un’inchiesta giudiziaria. All’epoca i loro nomi erano finiti sui giornali per via dell’arresto domiciliare e delle indagini a loro carico. Anni dopo, però, tutti e tre erano stati pienamente assolti con sentenza definitiva, ottenendo persino un indennizzo per ingiusta detenzione. Nonostante ciò, cercando i loro nomi online, gli interessati scoprivano che negli archivi digitali di alcune testate giornalistiche locali comparivano ancora gli articoli dell’epoca – articoli che riportavano dettagli di accuse e arresti, ma senza alcun riferimento all’esito finale favorevole a queste persone. In altre parole, la “memoria” del web restituiva solo la notizia negativa iniziale, ormai non più attuale e smentita dai fatti successivi, con grave danno per la loro reputazione.
La Cassazione 2023, in questo caso, ha tracciato principi importanti sugli obblighi degli editori. Anzitutto ha riconosciuto che un quotidiano, mantenendo online il proprio archivio storico, svolge una funzione preziosa di “memoria collettiva e documentale” protetta anche a livello costituzionale (artt. 21 e 33 Cost.). Tuttavia, questa funzione deve essere coniugata con il diritto all’oblio delle persone coinvolte negli articoli archiviati. Secondo la Suprema Corte, è lecita la permanenza negli archivi online di un articolo di cronaca anche a distanza di molto tempo e anche se la vicenda si è conclusa a favore dell’interessato, purché vengano adottate adeguate misure di tutela. In particolare, la Cassazione ha stabilito due obblighi a carico dell’editore:
Deindicizzazione su richiesta – Se la persona coinvolta lo richiede, l’articolo deve essere escluso dall’indice dei motori di ricerca esterni. Ciò significa che digitando il nome dell’interessato su Google o similari, quel pezzo non apparirà tra i risultati (sarà reperibile solo effettuando ricerche interne al sito del giornale).
Aggiornamento delle notizie – Sempre su richiesta espressa e documentata dell’interessato, l’editore deve aggiungere una nota informativa in calce o a margine dell’articolo, che riporti in forma sintetica l’esito finale della vicenda giudiziaria (ad esempio l’avvenuta assoluzione con sentenza irrevocabile).
Solo adottando entrambe queste misure si bilancia correttamente – secondo la Cassazione – il diritto della collettività a essere informata e a conservare memoria storica con il diritto della persona “a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale”. In pratica, l’articolo può rimanere nell’archivio (quindi non viene censurato né cancellato), ma dev’essere meno visibile e soprattutto contestualizzato in modo veritiero. Chi, in futuro, lo leggerà dall’archivio del quotidiano dovrà subito vedere l’aggiornamento sull’esito finale positivo per l’interessato, così da evitare impressioni distorte o lesive.
Questa pronuncia introduce un approccio equilibrato: non si richiede ai giornali di riscrivere la storia o eliminare pezzi d’archivio, ma di garantire un’informazione corretta e attuale quando quei vecchi articoli tornano alla luce. Vale la pena notare che, nel caso deciso, la Cassazione ha parzialmente smentito il tribunale di merito, il quale inizialmente aveva negato sia la cancellazione degli articoli che l’apposizione di note di aggiornamento, ritenendo sufficiente la sola deindicizzazione per proteggere l’oblio. La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che la sola deindicizzazione non bastasse: se l’interessato lo chiede, ha diritto anche a un aggiornamento testuale degli articoli, per ristabilire la verità storica a suo favore.
Da questa vicenda emerge anche il tema del risarcimento dei danni in caso di violazione del diritto all’oblio. La stessa Cassazione, con l’ordinanza 2893/2023, ha affermato che la lesione di questo diritto fondamentale può comportare un risarcimento del danno non patrimoniale a carico sia dell’editore sia del gestore del motore di ricerca coinvolto. Spetterà al giudice di merito liquidare equamente tale danno, valutando ad esempio la sofferenza morale causata alla persona, la portata della diffusione della notizia lesiva, la gravità della lesione della reputazione personale e professionale, ecc.. Si tratta di un aspetto di rilievo: il risarcimento civile funge da strumento di tutela ulteriore, sanzionando chi non rispetta le regole sull’oblio e dissuadendo i media dal persistere nella divulgazione di informazioni ormai obsolete e pregiudizievoli.
Un’importante novità normativa in materia di diritto all’oblio in Italia è stata introdotta con la recente Riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022). Questa riforma, che ha innovato il processo penale, ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il nuovo art. 64-ter denominato “Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini”. Tale norma mira a rafforzare la tutela della privacy e dell’onore di chi è stato coinvolto in procedimenti penali poi conclusi a suo favore. In particolare, l’art. 64-ter prevede che, su istanza dell’interessato, vengano annotate nei registri ufficiali le informazioni sull’esito favorevole (proscioglimento, non luogo a procedere, archiviazione) e dispone misure per evitare la diffusione incontrollata di dati personali di indagati e imputati non condannati. Una delle previsioni chiave – molto rilevante anche mediaticamente – è che in caso di sentenza di assoluzione, di archiviazione o proscioglimento, debba essere disposta l’immediata deindicizzazione dalle testate giornalistiche online delle notizie relative a quella specifica vicenda penale. In altre parole, se una persona viene definitivamente scagionata, ha diritto a essere “dimenticata” dal web quanto a quelle notizie giudiziarie: i giornali dovranno rendere i propri articoli non più reperibili tramite i motori di ricerca.
La ratio di questa norma è chiara: evitare che rimanga perennemente infamante l’ombra di un’accusa poi caduta. Prima della riforma, spesso accadeva che titoli di giornale clamorosi sull’arresto di Tizio facessero il giro del web, mentre la successiva assoluzione, magari anni dopo, passasse in sordina. Da ciò derivava un evidente pregiudizio per l’immagine della persona, condannata da “una memoria online senza diritto di replica”. Ora la legge cerca di rimediare, imponendo uno snellimento dei tempi: l’interessato non dovrà più attendere una lunga battaglia giudiziaria per ottenere tutela, ma potrà attivare subito la procedura di deindicizzazione una volta ottenuto l’esito a lui favorevole.
Su questo tema è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, sentenza n. 31859/2024 (Prima Sezione, depositata a fine 2024), ha offerto una nuova interpretazione in linea con la riforma Cartabia. In passato, l’orientamento prevalente riteneva che una richiesta di rimozione o deindicizzazione di notizie giudiziarie pregiudizievoli potesse essere accolta solo dopo una sentenza di assoluzione definitiva, così come previsto dall’art. 17 GDPR (diritto alla cancellazione) e previo bilanciamento con il diritto di cronaca. Oggi, invece, la Cassazione ha riconosciuto che il provvedimento di archiviazione o di assoluzione costituisce di per sé un titolo sufficiente per ottenere la deindicizzazione delle informazioni ad esso relative. In pratica, una volta che un tribunale accerta l’innocenza (o il non doversi procedere) di una persona, questa può far valere il suo diritto all’oblio immediatamente, senza ulteriore necessità di dimostrare l’assenza di interesse pubblico attuale – perché, come codificato dal nuovo art. 64-ter c.p.p., l’ordinamento considera prevalente l’interesse dell’ex indagato a non restare indebitamente esposto. La Cassazione 31859/2024 ha anche sottolineato che la riforma ha potenziato il diritto all’oblio prevedendo due strumenti distinti: uno volto a facilitare l’ottenimento della deindicizzazione, l’altro (inverso) teso a inibire l’indicizzazione di certe informazioni sin dall’inizio. Ciò conferma un trend chiaro: il legislatore e i giudici riconoscono sempre più importanza alla rapida eliminazione dal web delle “etichette” negative per chi non è stato ritenuto colpevole, al fine di garantire il pieno rispetto della presunzione di innocenza e il reinserimento sociale senza stigmi.
Il quadro emerso negli ultimi anni mostra un diritto all’oblio in continua evoluzione, arricchito da nuove norme e decisioni che ne precisano portata e limiti. In Italia, l’orientamento attuale – anche grazie al recepimento del GDPR e alla spinta della riforma Cartabia – è quello di assicurare una tutela effettiva e tempestiva a chi, altrimenti, vedrebbe la propria reputazione perennemente legata a vicende passate e non più rilevanti. Al contempo, i giudici ribadiscono costantemente che la tutela dell’oblio non può sconfinare in censura o riscrittura arbitraria della storia: il diritto di cronaca e la memoria collettiva mantengono un valore fondamentale, specie quando vi sia un perdurante interesse pubblico.
Si delinea così un sistema fatto di principi equilibrati. Da un lato, chiunque ha il diritto di “essere lasciato in pace” riguardo a fatti antichi che lo riguardano, soprattutto se la sua vicenda si è conclusa positivamente o se il tempo trascorso ha reso quei fatti non più pertinenti. Dall’altro lato, la società ha diritto di “conoscere e ricordare” eventi di interesse pubblico, e la stampa deve poter conservare gli archivi del proprio lavoro come giacimento di conoscenza storica. Le soluzioni adottate – dalla deindicizzazione globale alle note di aggiornamento negli archivi, fino alla deindicizzazione immediata per gli assolti – mostrano che è possibile trovare un punto di equilibrio, utilizzando anche la tecnologia a servizio dei diritti.
In definitiva, il diritto all’oblio si configura oggi come un diritto “complesso”, da esercitare con proporzionalità e buon senso, e che richiede il costante dialogo tra leggi, Autorità e giurisprudenza. Come insegnano le massime latine e la grande letteratura, il rapporto tra memoria e oblio è parte integrante della condizione umana: nel mondo digitale, sta a noi – attraverso le istituzioni e le regole – garantire che né la prima né il secondo prendano il sopravvento in modo ingiusto.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.