

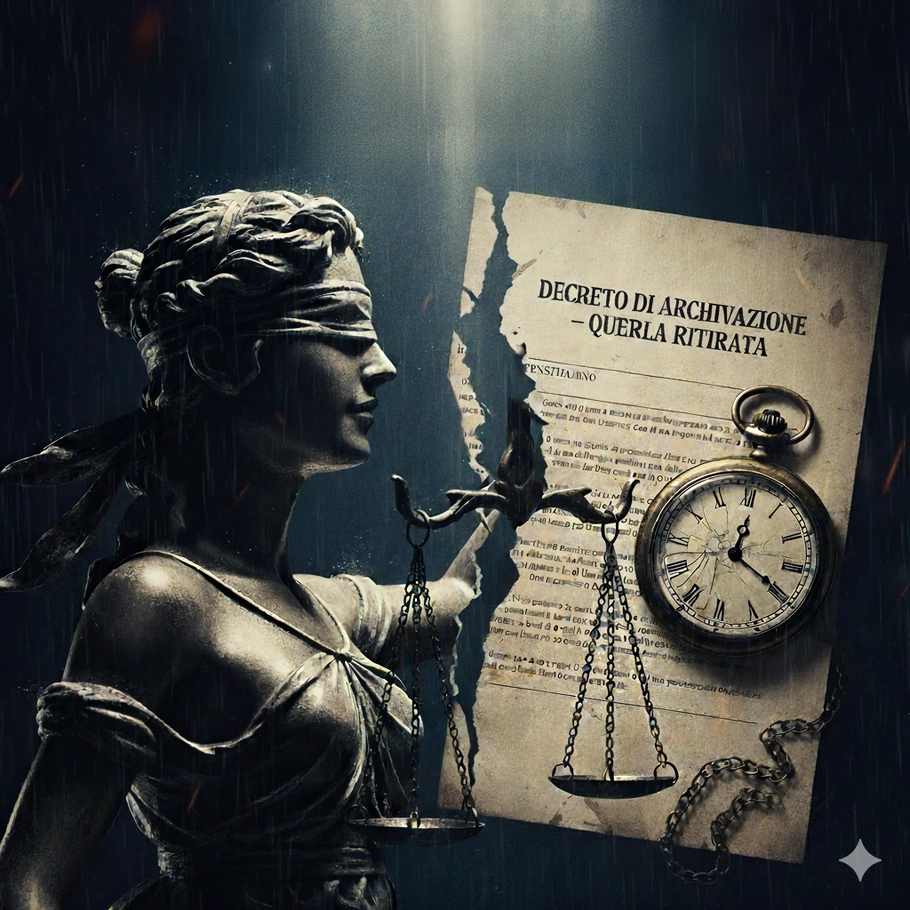
Denuncia e querela: significato e differenze
Nel linguaggio comune spesso si fa confusione tra denuncia e querela, usandoli come sinonimi. In realtà, la differenza è netta. La denuncia è un atto con cui chiunque (non solo la vittima) informa le forze dell’ordine o la Procura della possibile commissione di un reato. Può riguardare reati perseguibili d’ufficio, ossia quelli per cui lo Stato procede automaticamente appena viene a conoscenza del fatto (ad esempio furti aggravati, rapine, traffico di droga, ecc.). Una volta sporta una denuncia, le autorità avviano le indagini a prescindere dalla volontà della persona offesa.
La querela, invece, è un atto ben più “personale”: con la querela la vittima non si limita a segnalare il reato, ma dichiara di voler che il colpevole sia perseguito penalmente. La querela è necessaria per i cosiddetti reati procedibili a querela di parte, nei quali la legge richiede espressamente l’istanza della persona offesa come condizione di procedibilità. In assenza di querela in questi casi lo Stato non può intervenire: anche se il fatto è noto e provato, senza la volontà punitiva espressa dalla vittima il procedimento non parte o viene archiviato. Come scriveva Dante Alighieri, «Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?» – le norme esistono, ma occorre qualcuno che le faccia valere. La querela è proprio lo strumento che “muove” la legge penale in determinati casi. Un esempio classico: la diffamazione (offese all’altrui reputazione) è un reato per il quale è indispensabile la querela della persona offesa; se nessuno sporge querela entro i termini, l’autore degli insulti non potrà essere processato. Al contrario, per un reato grave come la rapina (furto con violenza) la legge tutela un interesse pubblico: la denuncia di chiunque è sufficiente a far partire l’azione penale d’ufficio, senza bisogno di querela della vittima.
Reati procedibili d’ufficio vs reati a querela. – Dietro questa distinzione c’è una scelta di politica criminale: si ritiene che per illeciti di minore allarme sociale o che toccano interessi strettamente individuali (onore, piccole lesioni, patrimonio privato senza rilevante impatto pubblico) debba essere la vittima a decidere se attivare o meno la macchina giudiziaria, evitando processi penali inutili quando non c’è un effettivo interesse della persona offesa. Per reati invece che ledono beni collettivi o particolarmente gravi (vita, incolumità pubblica, ordine pubblico, ecc.), lo Stato interviene comunque, anche contro la volontà della vittima, perché vi è un interesse superiore della collettività alla punizione. In sintesi: la denuncia può farla chiunque e fa partire le indagini per i reati procedibili d’ufficio; la querela può farla solo la vittima (o il suo legale rappresentante) ed è necessaria per far perseguire i reati procedibili a querela.
Novità della riforma Cartabia: più reati a querela, meno procedibilità d’ufficio
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per ampliare l’area dei reati perseguibili solo a querela, riducendo corrispondentemente i casi di intervento penale automatico. L’idea di fondo è concentrare le risorse giudiziarie sui fatti più gravi, lasciando invece che per i reati meno allarmanti sia la vittima a scegliere se procedere penalmente o magari risolvere la questione in via privata (ad esempio tramite un risarcimento). La riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022) ha rappresentato una svolta in tal senso. Essa ha reso procedibili a querela molti reati che prima erano d’ufficio, sia tra i delitti contro la persona sia tra quelli contro il patrimonio.
Ecco alcuni esempi di reati divenuti perseguibili solo a querela di parte dopo la riforma:
Furto semplice (art. 624 c.p.) – Il classico furto senza aggravanti (ad esempio il borseggio senza scasso) ora richiede la querela della persona offesa per procedere. Restano procedibili d’ufficio solo i furti aggravati (ad es. con scasso, destrezza, violenza sulle cose o alle persone).
Truffa (art. 640 c.p.) – Anche la truffa “semplice” è oggi a querela. Persino l’ipotesi aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità richiede la querela, secondo il nuovo comma 3 dell’art. 640 c.p. Rimane ovviamente punibile d’ufficio la truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici (ipotesi distinta).
Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) – Se un pedone o un altro utente della strada subisce lesioni gravi o gravissime da un automobilista che viola il codice della strada, il reato è procedibile a querela della persona offesa (salvo che ricorrano circostanze aggravanti speciali, come la guida in stato di ebbrezza grave, la fuga, ecc., che rendono il fatto più grave). Questa è una novità assoluta: prima le lesioni stradali erano perseguite d’ufficio, oggi nelle ipotesi “base” occorre la querela della vittima. Ciò responsabilizza maggiormente l’infortunato, che deve attivarsi se vuole che il conducente sia punito penalmente.
Lesioni personali dolose lievi (art. 582 c.p.) – Già in passato le lesioni volontarie lievi erano a querela quando la prognosi era inferiore a 20 giorni; la riforma ha esteso questo limite a 40 giorni. Significa che se una persona viene ferita volontariamente e guarirà in meno di 40 giorni, spetta a lei decidere se sporgere querela; diversamente, se le lesioni sono gravissime (oltre 40 giorni, o con pericolo di vita) si procede comunque d’ufficio data la gravità.
Danneggiamento (art. 635 c.p.) – Il danneggiamento semplice (distruggere o deteriorare cose altrui) oggi è perseguibile a querela, salvo alcune ipotesi aggravate. Ad esempio, se qualcuno vandalizza un oggetto di tua proprietà, dovrai presentare querela perché sia punito; diversamente, per danneggiamenti più gravi o commessi con metodo pericoloso (es. incendio) la legge procede d’ufficio. Una recente modifica del 2024 ha reso a querela anche l’ipotesi di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede (art. 635 comma 2 n.1 c.p.), prima punita d’ufficio: si pensi a chi taglia le gomme di un’auto in sosta per dispetto.
Questi sono solo alcuni casi: l’elenco completo delle fattispecie interessate dalla riforma è ampio e include, tra gli altri, reati come l’appropriazione indebita, la frode informatica, l’estorsione non aggravata da uso di armi (che oggi è una forma di violenza privata e richiede querela) e vari reati minori contro la persona. Restano sempre procedibili d’ufficio, per ragioni di tutela delle vittime più deboli, i reati commessi contro persone incapaci, minori o in condizioni di particolare vulnerabilità: ad esempio i maltrattamenti in famiglia o la violenza sessuale rimangono d’ufficio, perché si vuole evitare che la paura o la soggezione impediscano alla vittima di denunciare (in questi casi lo Stato interviene comunque). In generale, dunque, dopo la riforma Cartabia la regola tende ad essere: azione penale solo su querela della persona offesa, e l’intervento d’ufficio è l’eccezione riservata ai reati più gravi o di interesse generale.
Termini per sporgere querela e casi particolari
La querela non può essere presentata in qualsiasi momento: la legge fissa un termine preciso, trascorso il quale non è più possibile procedere. L’art. 124 del codice penale stabilisce che la querela va sporta entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato (o sei mesi in alcuni casi particolari, ad esempio per reati come lo stalking). Si tratta di un termine perentorio: “decaduto” il trimestre, la querela tardiva è inefficace e il colpevole non può più essere perseguito per quel fatto. La ratio è evitare che la minaccia di sporgere querela rimanga a tempo indefinito come arma di ricatto sulla testa di una persona.
Va precisato che il termine di tre mesi decorre da quando la persona offesa ha cognizione del reato e di chi ne è il presunto autore. Se quindi inizialmente la vittima non sapeva di aver subìto un reato, o ignorava l’identità dell’autore, il termine può slittare fino al momento della scoperta. Ad esempio: Tizio scopre solo ad aprile che il vicino Caio a gennaio gli ha tagliato le piante del giardino di nascosto; in tal caso Tizio ha tre mesi da aprile, non da gennaio. Tuttavia, bisogna fare attenzione: una volta che gli elementi essenziali sono noti, l’orologio inizia a ticchettare e non si arresta più. I tre mesi vanno calcolati con precisione; ogni incertezza si risolve, di regola, in favore dell’imputato (favor rei). Su questo punto è istruttiva una vicenda decisa dalla Corte di Cassazione nel 2024: in un caso di truffa, la vittima durante il processo aveva dichiarato di aver saputo dell’inganno “nel mese di luglio o agosto” di qualche anno prima; non ricordava il giorno esatto. Ebbene, la Cassazione ha chiarito che se un reato è indicato come commesso genericamente in un certo mese ma senza giorno preciso, ai fini della tempestività della querela si considera la data più favorevole all’imputato, cioè il primo giorno di quel mese. Nel caso concreto la querela era stata presentata il 22 novembre, e così facendo risultava oltre i tre mesi dal 1° agosto: è stata quindi ritenuta tardiva e l’imputato è stato prosciolto per difetto di querela (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 36172/2024). Questo episodio dimostra quanto sia rigoroso il rispetto del termine: anche una querela per certi versi “quasi in tempo” può diventare inutile per pochi giorni di ritardo, se si interpreta la decorrenza in senso sfavorevole. Summum ius, summa iniuria, dicevano i latini: l’applicazione rigorosa della regola (il “sommo diritto”) può apparire sommamente ingiusta in casi come questo, ma è ciò che la legge prevede per tutelare l’imputato dalla minaccia indefinita di azioni tardive.
Come si presenta una querela? È necessario un atto scritto, sottoscritto dalla persona offesa (o dal suo avvocato con procura speciale) e presentato a mano o inviato (per esempio via PEC, se previsto) alla Polizia Giudiziaria o in Procura. Nel documento bisogna descrivere sinteticamente i fatti e dichiarare espressamente “sporgo querela nei confronti di…” indicando il presunto responsabile. La querela può essere proposta anche oralmente, rendendo una dichiarazione davanti a un ufficiale di Polizia o Carabinieri, che ne redige verbale. Importante: una volta sporta, la querela è irrevocabile salvo accordo con l’imputato (vedremo tra poco la remissione). Non è che la vittima può presentare querela e poi ripensarci unilateralmente il giorno dopo: se il querelato non accetta il ritiro, il processo andrà avanti.
Remissione della querela e giustizia riparativa
La remissione della querela è l’atto con cui la persona offesa ritira la querela presentata, facendo cessare il procedimento penale. È prevista dall’art. 152 c.p. e consente, per i reati cosiddetti remissibili, di estinguere il reato prima della sentenza definitiva. Non tutti i reati a querela sono però remissibili: la legge ne esclude alcuni per i quali, una volta avviato il processo, la querela non può più essere rimessa (ad esempio nei casi di violenza sessuale o di stalking dopo una certa fase). In generale però, per la maggior parte dei reati comuni a querela (diffamazione, lesioni, truffa, ecc.) vale il principio che la querela può essere rimessa: significa che vittima e indagato possono “fare pace”, spesso a fronte di un risarcimento o delle scuse, e la vittima dichiara di non aver più interesse alla punizione. La remissione deve essere accettata dal querelato per produrre effetto (non ha senso infatti estinguere il reato se l’imputato vuole comunque il giudizio per essere eventualmente assolto con formula piena). Una volta accettata, la remissione fa calare il sipario: il reato è estinto e l’imputato non può più essere punito.
La possibilità di rimettere la querela anche a processo iniziato è una valvola di sfogo importante: evita molti dibattimenti inutili quando le parti hanno già trovato un componimento. La riforma Cartabia ha voluto incentivare ancor di più queste soluzioni di pacificazione inserendo nel codice il nuovo istituto della giustizia riparativa. Si tratta di percorsi, anche fuori dal processo, in cui vittima e autore del reato possono incontrarsi con l’aiuto di facilitatori per riparare le conseguenze dell’offesa. Se la riparazione ha successo, spesso la vittima decide di rimettere la querela e questo chiude il caso. Ad esempio, in un procedimento per lesioni volontarie tra conoscenti, l’imputato potrebbe proporre di svolgere un programma di mediazione con la vittima: chiarirsi, risarcire i danni e riconciliarsi. Se ciò avviene e la querela viene formalmente ritirata prima della sentenza, il giudice emette un provvedimento di non luogo a procedere per avvenuta remissione.
Attenzione: la remissione di querela è preclusa quando il reato ha una dimensione tale da trascendere l’interesse privato. Ad esempio, nel reato di stalking (atti persecutori) la querela una volta proposta diventa irrevocabile dopo che il processo è iniziato (salvo rarissime eccezioni): questo per proteggere la vittima da eventuali pressioni o ripensamenti dettati dalla paura. Tuttavia, il quadro normativo su questi punti è in evoluzione e talvolta oggetto di interventi della Corte Costituzionale. Proprio nel 2025 la Consulta è intervenuta in tema di stalking connesso ad altri reati: ha giudicato irragionevole mantenere la procedibilità d’ufficio per un caso di atti persecutori commessi insieme a un danneggiamento divenuto nel frattempo a querela, e ha eliminato la norma transitoria che lo prevedeva. Con la sentenza n. 123/2025, dunque, la Corte Costituzionale ha sancito che anche in un processo per stalking se il reato connesso (es. danneggiamento) diventa a querela per legge sopravvenuta, l’imputato va prosciolto se manca la querela e la vittima non intende procedere. In sostanza, viene ribadito il principio di retroattività della legge più favorevole: se oggi per quel fatto sarebbe necessaria la querela, tale requisito vale anche per i processi in corso, dando così modo alla persona offesa di valutare la remissione o il non esercizio dell’azione penale.
Orientamenti recenti della giurisprudenza sulla querela
Le modifiche normative degli ultimi anni hanno sollevato diverse questioni applicative, e la giurisprudenza si è trovata a doverle risolvere. Abbiamo già visto alcuni esempi. Un tema spinoso è stato il coordinamento tra vecchi processi e nuove regole di procedibilità. Per evitare che i procedimenti in corso per reati divenuti nel frattempo a querela venissero annullati dall’oggi al domani, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria: in pratica si è disposto che se un processo era già pendente quando è entrata in vigore la riforma, il giudice dovesse avvisare la persona offesa, concedendole tre mesi per eventualmente sporgere querela (ex novo). Se la vittima non formalizzava la querela entro quel termine, il processo doveva estinguersi. La Cassazione ha interpretato questo regime transitorio in modo sostanziale: ha chiarito che l’avviso va dato solo se la persona offesa non aveva già manifestato in qualche modo la volontà punitiva. Ad esempio, se nel corso del processo la vittima si era già costituita parte civile per chiedere i danni, tale gesto equivale di fatto a una querela e rende superfluo pretendere un’ulteriore conferma. Così ha stabilito la Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza n. 6016/2024.
Un altro problema affrontato dai giudici riguarda il caso in cui un reato inizialmente procedibile a querela venga “convertito” in procedibile d’ufficio perché emerge un’aggravante dopo l’inizio del processo. È accaduto ad esempio per alcuni furti: dopo l’avvio del giudizio (iniziato su querela), il pubblico ministero contestava un’aggravante che avrebbe reso il reato perseguibile d’ufficio sin dall’inizio. Questo ha creato incertezze sulla validità della querela e sulla necessità o meno di chiudere il procedimento. La Cassazione ha risolto il dubbio stabilendo che la contestazione tardiva di un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio “consolida” la possibilità di procedere: in pratica, una volta formulata l’aggravante in udienza, il giudice non deve più dichiarare il non doversi procedere per difetto di querela, perché l’aggravante retroagisce sul regime di procedibilità. Così ha deciso la Cassazione penale, Sez. V, nella sentenza n. 24370/2024, annullando il provvedimento di un tribunale che aveva invece stoppato tutto ritenendo la querela tardiva rispetto all’aggravante contestata. Nello stesso solco si è posta Cass. pen., Sez. IV, n. 41171/2024, affermando che se durante il dibattimento emerge un elemento aggravante che renderebbe il reato procedibile d’ufficio, da quel momento il processo può proseguire indipendentemente dalla querela iniziale. Questi principi garantiscono che non si creino “zone franche” per i colpevoli: l’assenza di querela iniziale non potrà essere strumentalizzata se poi viene alla luce una circostanza che, sin dall’origine, avrebbe reso doverosa l’azione penale d’ufficio.
Conclusioni – In definitiva, l’istituto della querela di parte è sempre più centrale nel sistema penale attuale. La recente evoluzione normativa ha dato maggior peso alla volontà della vittima: oggi molti reati non vengono perseguiti senza un’esplicita istanza punitiva da parte dell’offeso. Ciò comporta una maggiore responsabilizzazione dei cittadini, chiamati a decidere se “far partire” o meno il procedimento penale. Allo stesso tempo, offre opportunità di giustizia riparativa e componimento: la querela può essere uno strumento flessibile, che la vittima può scegliere di utilizzare e anche di ritirare (nei limiti consentiti), magari a seguito di un accordo risarcitorio. Da un lato, dunque, chi ha subìto un torto ha voce in capitolo sulla sorte del procedimento (potendo valutare costi e benefici di un’azione penale); dall’altro, chi ha commesso reati minori ha la chance di evitare una condanna offrendo riparazione e scuse alla vittima prima che il processo giunga a termine. Resta fondamentale agire con tempestività: per i reati a querela la legge non perdona ritardi o disattenzioni, e scaduti i termini ogni possibilità di punizione svanisce, anche se il fatto è accertato. In caso di dubbio sulla procedibilità di un reato o sulla necessità della querela, è sempre opportuno consultare un avvocato penalista, così da non compromettere le proprie chances di giustizia. Dice un adagio: "chi lascia correre la giustizia allenta le briglie all’ingiustizia": in altre parole, conoscere i propri diritti e attivarsi nei modi e tempi giusti è la chiave per ottenere tutela effettiva.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.