

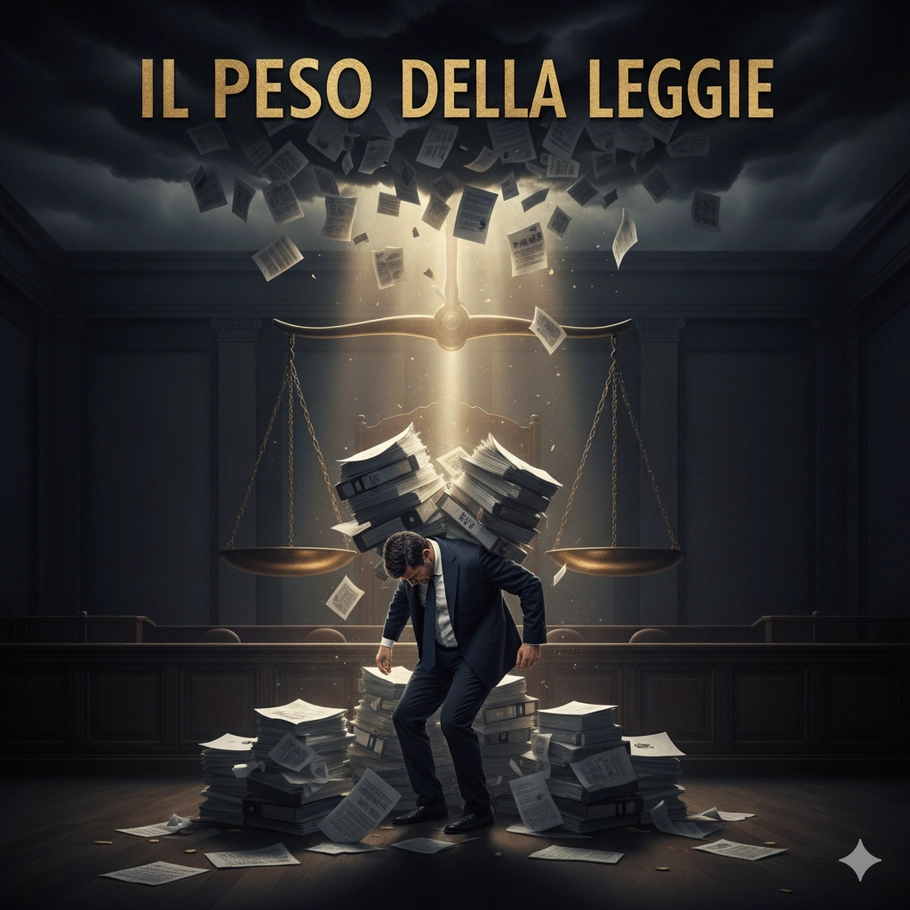
Contesto normativo: dal veto dell’Erario al nuovo Codice della Crisi
Per molti anni, la legge fallimentare ha imposto un approccio rigidissimo al trattamento dei crediti fiscali nelle procedure concorsuali. In un concordato preventivo proposto da un’azienda in crisi, un voto contrario da parte dell’Erario (Agenzia delle Entrate o Enti previdenziali) bastava di fatto a bloccare l’omologazione del piano. L’art. 180 della vecchia Legge Fallimentare prevedeva la possibilità di omologare il concordato senza l’assenso del Fisco solo in caso di silenzio o mancato voto di quest’ultimo – circostanza rara nella pratica. Questo rigore applicativo spesso portava a soluzioni draconiane: piani di risanamento naufragati a causa di un “veto” fiscale, imprese avviate verso il fallimento nonostante offerte concordatarie più vantaggiose per i creditori rispetto alla liquidazione. Si concretizzava quel paradosso del "summum ius, summa iniuria", in cui l’applicazione inflessibile della norma (il “massimo del diritto”) generava la “massima ingiustizia” per il debitore e per la collettività – basti pensare alla perdita di posti di lavoro e valore economico dovuta al fallimento di aziende che avrebbero potuto salvarsi.
Negli ultimi anni, tuttavia, il legislatore ha avviato una svolta culturale in materia di crisi d’impresa. Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore a pieno regime nel 2022) sono state introdotte procedure e principi ispirati a una maggiore flessibilità e alla salvaguardia della continuità aziendale. Tra questi, spicca la transazione fiscale in ambito concordatario: il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, con l’eventuale falcidia di interessi e sanzioni, subordinando però l’efficacia del piano al necessario assenso degli enti pubblici. Finché era richiesto il consenso del Fisco, il rischio di un diniego restava alto. Ma proprio qui interviene la novità: il cosiddetto “cram down fiscale”, ovvero la possibilità per il tribunale di omologare ugualmente il concordato anche senza il voto favorevole dell’Erario, a condizione che ai crediti tributari venga garantito un trattamento non inferiore rispetto a quello che otterrebbero in caso di liquidazione.
La svolta della Cassazione nel 2024
Questo cambiamento epocale ha trovato il suo definitivo riconoscimento giurisprudenziale con una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 27782 del 28 ottobre 2024 (Cass. civ., Sez. I), la Suprema Corte ha aperto la strada all’omologazione forzata del concordato preventivo anche in presenza di voto contrario dell’Erario. In altre parole, il giudice potrà approvare e rendere vincolante un piano di concordato nonostante il “no” dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, purché risulti provato che la proposta garantisce a tali creditori pubblici una soddisfazione economica superiore a quella ricavabile da un fallimento (oggi detto liquidazione giudiziale). Si tratta di una svolta storica per il diritto concorsuale italiano: viene superato un impasse che in passato aveva vanificato molti tentativi di ristrutturazione dei debiti.
La Cassazione, nella sentenza in esame, evidenzia come questo riequilibrio tra interesse pubblico e privato sia coerente con lo spirito del nuovo Codice della Crisi. La vecchia Legge Fallimentare privilegiava una tutela assoluta dell’erario (favor fiscus), ma il prezzo da pagare era spesso la perdita dell’impresa e dei connessi benefici socio-economici. Ora, invece, si afferma il principio che se il piano di concordato è più conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione, il dissenso di quest’ultimo non può prevalere sull’interesse generale alla continuazione dell’attività imprenditoriale. Questa interpretazione innovativa è stata successivamente avvalorata anche dal legislatore: il “secondo correttivo” al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) ha esplicitamente allineato le norme sul concordato preventivo a quelle degli accordi di ristrutturazione, prevedendo che il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dei creditori pubblici se ritiene il piano più vantaggioso della liquidazione.
Implicazioni pratiche e limiti applicativi
Le conseguenze pratiche di questa evoluzione normativa e giurisprudenziale sono di grande rilievo. Innanzitutto, si ampliano le possibilità di risanamento per le imprese indebitate con il Fisco: non è più sufficiente la contrarietà dell’erario a far naufragare un concordato preventivo. Un imprenditore in crisi, oggi, può proporre con maggior fiducia un piano che preveda, ad esempio, il pagamento parziale dei debiti tributari (una falcidia delle somme dovute) o una loro dilazione significativa, sapendo che – se il piano assicura comunque una miglior soddisfazione rispetto al fallimento – il giudice potrà omologarlo anche senza l’accordo dell’Agenzia delle Entrate. Questo riduce il potere di “veto” dell’erario e incoraggia approcci costruttivi: il Fisco, beninteso, mantiene il diritto di voto e può opporsi, ma il suo dissenso non avrà più valore dirimente in ogni caso. In un’ottica di sistema, ciò favorisce soluzioni concordate di gestione della crisi d’impresa, evitando liquidazioni giudiziali distruttive quando esiste un’alternativa migliore per tutti i creditori.
Va sottolineato, però, che il cram down fiscale non è un “liberi tutti”: restano precisi limiti e condizioni a tutela dei creditori. Il tribunale potrà forzare l’omologa solo se rigorosamente dimostrato che la proposta è più conveniente della liquidazione. Ciò implica valutazioni tecniche sulla convenienza economica del piano: sarà necessario comparare i dividendi offerti in concordato con le presumibili percentuali di realizzo in caso di fallimento, tenendo conto dei tempi e costi di quest’ultimo. Inoltre, la soddisfazione “superiore” richiesta non significa che il Fisco debba essere pagato integralmente – anzi, il senso della norma è permettere falcidie – ma che la percentuale offerta sia maggiore di quanto il creditore pubblico otterrebbe dallo scenario liquidatorio.
Un altro aspetto importante riguarda il rispetto delle cause di prelazione e l’equità di trattamento tra i creditori. Anche nell’era del favor verso la continuità aziendale, non tutto è consentito: rimangono paletti per evitare abusi. Ad esempio, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 48/2025, ha bocciato un piano che tentava di trasformare il concordato in un “condono” eccessivamente sbilanciato a favore del debitore, ricordando che il concordato – anche quello “minore” per sovraindebitati – non può tradursi in un regalo unilaterale: i sacrifici imposti ai creditori devono mantenersi nell’alveo della legge. In tale vicenda, il piano era stato omologato in primo grado nonostante un taglio drastico dei debiti fiscali, ma i giudici d’appello hanno revocato l’omologa ritenendo il trattamento dell’Erario illegittimamente penalizzante.
Allo stesso modo, in caso di concordato con continuità aziendale, la giurisprudenza ha chiarito che eventuali utilità generate dalla prosecuzione dell’attività non possono essere sottratte ai creditori prelatizi. La Cassazione (sent. n. 22169/2024) ha ribadito che il “surplus” prodotto dalla continuità deve essere destinato ai creditori secondo le priorità di legge, e non può essere liberamente distribuito al di fuori delle regole concorsuali. Ciò significa che, pur incentivando la continuità dell’impresa, il sistema tutela i creditori privilegiati: ad essi spetta per legge il valore di liquidazione dei beni a garanzia, e solo l’eventuale valore eccedente può essere distribuito con maggiore flessibilità tra le classi di creditori chirografari (l’absolute priority rule temperata dalle norme attuali). In pratica, l’imprenditore che intende mantenere in vita l’azienda proponendo un concordato dovrà rispettare questo equilibrio, senza pretendere di conservare pro domo sua i frutti della continuazione a scapito dei creditori.
In definitiva, l’introduzione del cram down fiscale segna un bilanciamento più maturo tra favor debitoris e favor creditoris. L’ordinamento, senza rinunciare alla responsabilità del debitore verso i propri impegni, riconosce che in certe situazioni una soluzione concordata è preferibile a una pura e semplice esecuzione forzata del patrimonio. “Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia”, scrive Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi: allo stesso modo, il diritto della crisi d’impresa oggi tende a concedere una seconda opportunità a chi, pur avendo accumulato debiti, dimostri trasparenza e impegno nel risanarli. La clemenza del legislatore verso il debitore onesto (si pensi anche alle misure sull’esdebitazione post-procedura) non è buonismo, ma calcolo razionale: talvolta condonare una parte del credito pubblico – se ciò consente di salvare l’azienda e mantenere attiva la fonte economica – è una scelta vantaggiosa anche per la collettività. L’importante è che avvenga cum grano salis, entro limiti equi e sotto la vigilanza rigorosa del tribunale.
Il tema del concordato preventivo e delle nuove aperture verso il cram down fiscale mostra quanto sia delicato equilibrare le esigenze del debitore e dei creditori. Ogni situazione di crisi presenta peculiarità che vanno attentamente valutate. Se la tua impresa sta affrontando difficoltà finanziarie e debiti tributari impegnativi, contatta lo Studio Legale MP per una consulenza sul da farsi. Il nostro team di Verona, con esperienza nel diritto concorsuale e fallimentare, può aiutarti ad analizzare le opzioni disponibili – dal concordato preventivo alle altre procedure di ristrutturazione – e guidarti attraverso le recenti novità normative per individuare la strategia migliore. Non aspettare che la situazione peggiori: un intervento tempestivo e mirato può fare la differenza tra la fine di un’attività e il suo rilancio. Siamo a tua disposizione per valutare il caso concreto e assisterti nel percorso di risanamento, mettendo a disposizione competenza e impegno al servizio della tua impresa.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.