

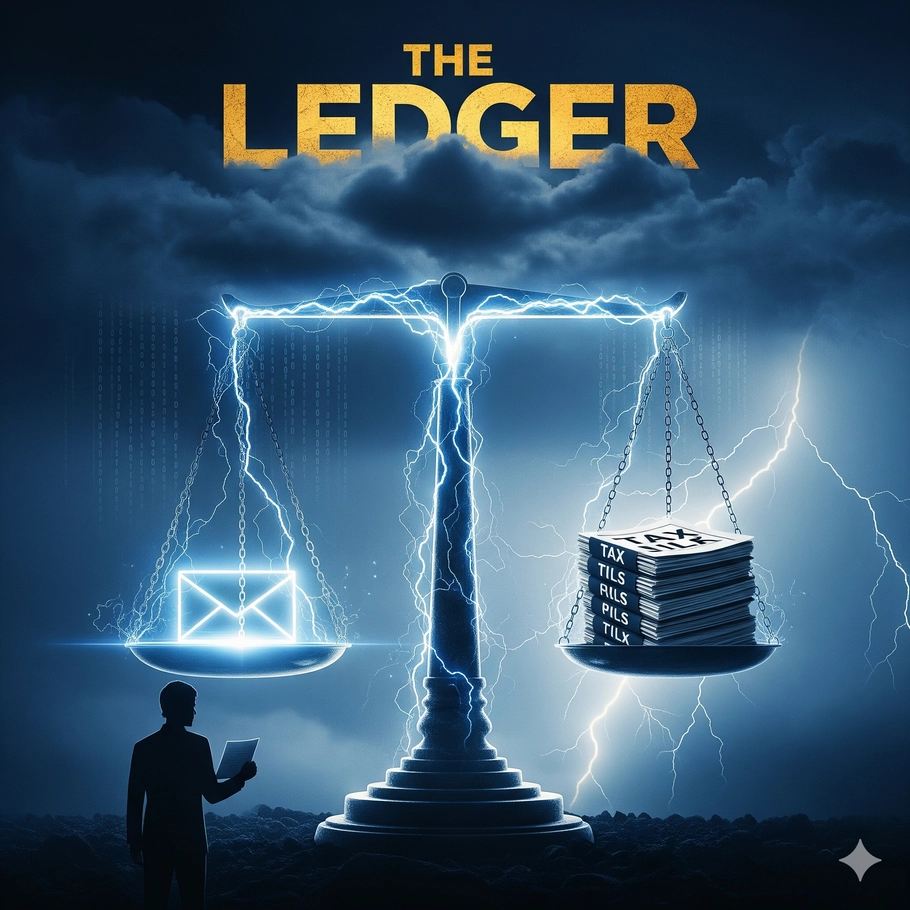
La cartella esattoriale (o cartella di pagamento) è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede al contribuente il pagamento di somme dovute (imposte, multe, contributi). Tradizionalmente notificata a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, oggi la cartella può essere notificata anche per via telematica attraverso la PEC del destinatario. La normativa di riferimento prevede che la trasmissione avvenga all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi ufficiali (es. Registro INI-PEC per imprese e professionisti, elenco della PA per i cittadini che l’hanno comunicato). In teoria, la PEC garantisce una notifica rapida e tracciabile, con valore legale equiparato alla raccomandata cartacea.
Tuttavia, la legge impone alcune regole tecniche specifiche per la notifica via PEC. L’atto da notificare deve essere inviato come allegato al messaggio PEC, in un formato che ne attesti la conformità all’originale. Spesso la cartella viene predisposta come documento PDF con firma digitale in formato .p7m (cioè un PDF firmato digitalmente) oppure come copia informatica con attestazione di conformità se l’originale è analogico. Inoltre, la casella PEC mittente dovrebbe appartenere all’ente creditore e risultare da un pubblico registro. Sulla carta, il mancato rispetto di queste formalità può costituire un vizio di notifica. Ma quali conseguenze ha realmente l’errore formale? Una cartella inviata da una PEC non ufficiale, o priva di firma digitale, è automaticamente nulla? La risposta arriva dalla recente giurisprudenza.
I principali vizi che possono inficiare la notifica via PEC di una cartella esattoriale sono:
Indirizzo PEC del mittente non presente nei registri ufficiali: ad esempio l’ente creditore utilizza una casella PEC diversa da quelle risultanti nei registri pubblici (INI-PEC o Registro PPAA). In tal caso il contribuente potrebbe eccepire di non aver certezza dell’autenticità dell’atto, sostenendo la nullità della notifica ex art. 26 DPR 602/1973 e art. 3-bis L. 53/1994.
Formato dell’allegato non conforme: invio della cartella come semplice PDF non firmato digitalmente, oppure come copia informatica priva dell’attestazione di conformità all’originale cartaceo. Qui il dubbio è se un PDF “semplice” garantisca la provenienza e l’integrità dell’atto come farebbe un PDF con firma digitale (estensione .p7m) o un file con firma PADES/CADES.
Mancata sottoscrizione dell’atto: la cartella esattoriale, per sua natura, non reca la firma autografa di un funzionario (essendo modulistica prestampata). Tuttavia, in caso di notifica telematica, il contribuente potrebbe lamentare l’assenza di firma digitale come elemento di identificazione dell’atto.
Altri vizi procedurali: errori nell’oggetto o nel testo della PEC (che per le notifiche richiede diciture specifiche), mancato invio dell’avviso di deposito se la casella risulta piena o inattiva, ecc. Sono situazioni meno frequenti, ma anch’esse potenzialmente fonti di nullità.
È importante capire che non ogni irregolarità formale comporta automaticamente la nullità. Nel nostro ordinamento processuale vige il principio del “raggiungimento dello scopo” (art. 156 c.p.c.): una notifica, anche se affetta da un vizio, può essere considerata valida se ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè portare effettiva conoscenza dell’atto al destinatario senza pregiudicarne il diritto di difesa. D’altro canto, la notifica è un momento essenziale: un vizio grave (ad esempio un indirizzo PEC errato o un file illeggibile) potrebbe lasciare il destinatario ignaro dell’atto e quindi costituire una lesione dei suoi diritti, giustificando la nullità. La linea di confine tra formalità sanabile e vizio insanabile è sottile: per tracciarla, è intervenuta la Cassazione con varie pronunce recenti.
Negli anni 2024 e 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sui requisiti di validità delle notifiche via PEC delle cartelle, fornendo un orientamento ormai chiaro. In sintesi, le Sezioni Civili (sez. tributaria) hanno affermato che non basta un vizio formale qualsiasi per annullare la cartella, occorrendo valutare in concreto se l’atto ha comunque raggiunto il contribuente e se questi ha subito un pregiudizio nella possibilità di difendersi.
In particolare, con Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26682/2024 (depositata il 14 ottobre 2024), la Suprema Corte ha affrontato il caso di una cartella inviata da un indirizzo PEC dell’Agente della Riscossione non risultante nei pubblici elenchi. La Commissione Tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo essenziale che il mittente PEC fosse ufficiale. La Cassazione invece ha ribaltato la decisione: la notifica da PEC “non ufficiale” non è nulla se comunque: 1) l’email è riconducibile all’ente creditore (es. dominio istituzionale), 2) il contribuente l’ha ricevuta regolarmente, e 3) non vi è incertezza su provenienza e contenuto dell’atto. In altri termini, la mancata iscrizione dell’indirizzo PEC nei registri non comporta nullità a meno che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa derivante da tale irregolarità. Questo orientamento richiama un principio di leale collaborazione: non ci si può avvantaggiare di un cavillo se la sostanza della notifica è chiara e il destinatario ha comunque saputo della cartella.
Analogamente, con Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12997/2025 (15 maggio 2025), la Corte ha affrontato l’eccezione di nullità di alcune cartelle inviate via PEC in semplice formato PDF senza firma digitale né attestazione di conformità. Il contribuente sosteneva che, mancando la firma digitale, non vi fosse garanzia dell’autenticità e integrità degli atti allegati. La Cassazione ha però rigettato questa tesi, sancendo che la cartella notificata via PEC in formato PDF semplice è valida. Ciò perché il protocollo PEC stesso assicura l’autenticità della trasmissione: il messaggio di PEC garantisce l’identità dell’invio, e la cartella allegata – anche se PDF non firmato – è comunque riferibile in modo univoco all’ente mittente, specie se proveniente da un dominio istituzionale. La Suprema Corte ha aggiunto che, per legge, la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione autografa o digitale del funzionario (art. 25 DPR 602/1973 prevede che il modulo di cartella sia prestabilito e non reca firma, solo intestazione dell’ente creditore e numero meccanografico). Di conseguenza, l’assenza di firma digitale non comporta inesistenza né nullità dell’atto, a meno che il destinatario non alleghi e provi che il file è stato alterato o non conforme all’originale. In assenza di contestazioni sostanziali (ad es. difformità nel testo della cartella), il semplice vizio formale non basta per invalidare la notifica.
Questa posizione è stata confermata anche da Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14081/2025 (27 maggio 2025), che ha esaminato proprio la questione del formato .pdf vs .p7m. La Corte ha ribadito che l’invio in “.pdf” senza firma digitale è valido, non essendo obbligatorio per l’Agente della Riscossione utilizzare il formato .p7m. Ciò che conta è che il documento sia “inequivocabilmente riferibile” all’organo che lo ha emesso. Finché nel messaggio PEC risultano chiari il mittente (Agenzia/ente) e l’oggetto (notifica di cartella n. XYZ) e l’allegato è effettivamente la cartella integra, la mancanza della firma non causa alcun pregiudizio: la cartella esiste ed è valida perché proviene dall’ente titolare del potere di riscossione, e il contribuente ne ha ricevuto piena contezza.
Sempre nel 2025, con Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14407/2025 (depositata il 6 giugno 2025), la Corte ha ulteriormente sottolineato che l’uso di un indirizzo PEC non presente nei registri non rende nulla la notifica salvo prova contraria. Il contribuente, per far annullare l’atto, dovrebbe dimostrare quali effetti pregiudizievoli ha subìto a causa di quel vizio (ad esempio, se l’email fosse finita in spam o fosse stata ignorata perché sembrava provenire da soggetto sconosciuto). In mancanza di tale prova, prevale l’effettiva conoscenza: se la cartella è arrivata a destinazione e il destinatario l’ha letta, l’atto ha raggiunto lo scopo e non può essere annullato per un vizio meramente formale.
Da queste pronunce possiamo ricavare un principio univoco: la nullità della notifica via PEC richiede un vizio idoneo a impedire o limitare la difesa del destinatario. I vizi “innocui” – come un mittente PEC non a norma, o un formato difforme ma comprensibile – sono sanati dal risultato, cioè dall’avvenuta conoscenza dell’atto. Solo se l’errore ha creato incertezza sull’atto o ha negato al contribuente la possibilità di reagire (ad esempio, PEC mai ricevuta per casella errata), allora la notifica sarà dichiarata nulla.
Alla luce di quanto sopra, come deve comportarsi un contribuente che riceve una cartella via PEC? Anzitutto, controllare attentamente l’atto e la comunicazione: verificare da quale indirizzo PEC proviene, se l’allegato è leggibile e integro, e la presenza dell’eventuale firma digitale o attestazione. Se la cartella è comprensibile e proviene (anche indirettamente) dall’Agente della Riscossione, è prudente considerarla valida: eventuali vizi formali, come abbiamo visto, difficilmente porteranno all’annullamento se non compromettono la sostanza.
Tuttavia, qualora vi siano irregolarità gravi, il contribuente può valutare di impugnare la cartella per vizio di notifica. Ad esempio, se l’atto è arrivato da un indirizzo PEC totalmente estraneo e non riconducibile al Fisco, oppure se l’allegato risulta illeggibile, corrotto o riferito a un altro soggetto, queste circostanze possono dar luogo a nullità. L’impugnazione avviene presentando ricorso alla competente Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) entro i termini di legge (in genere 60 giorni dalla notifica della cartella). Nel ricorso si dovrà evidenziare il vizio e, seguendo l’insegnamento della Cassazione, argomentare il concreto pregiudizio: ad esempio, dimostrare che l’errore ha impedito di avere piena conoscenza dell’atto o ha creato incertezza sulla sua provenienza.
È importante sottolineare che, se la notifica PEC viene dichiarata nulla, la cartella può essere rinotificata dall’ente entro determinati limiti (salvo decadenze sopraggiunte). In alcuni casi, quindi, far valere il vizio di notifica serve soprattutto a guadagnare tempo o a tentare di rientrare in termini per una definizione agevolata del debito. Se invece la notifica è valida, il contribuente deve procedere nel merito: valutare la legittimità della pretesa fiscale e, se necessario, contestare il contenuto della cartella (es. importi non dovuti, prescrizione, sgravio già avvenuto, ecc.).
In ogni caso, data la complessità della materia, è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in diritto tributario. Un professionista potrà esaminare la vostra cartella esattoriale, verificare se esistono effettivamente vizi di notifica utilmente eccepibili e guidarvi nella strategia migliore – sia essa fare opposizione per vizio formale, procedere con un ricorso di merito, oppure aderire a eventuali misure di definizione agevolata (come saldo e stralcio, rottamazione, rateizzazione) se ancora possibili.
La notificazione via PEC delle cartelle esattoriali è oggi la normalità e, nel complesso, offre vantaggi in termini di celerità e trasparenza. Le più recenti sentenze ci dicono che i giudici valorizzano la sostanza: se il contribuente ha ricevuto e compreso l’atto, non gli sarà consentito di far annullare la cartella per un vizio puramente formale. Ciò non significa che l’Agente della Riscossione possa notificare in modo arbitrario – restano tamquam non essent (come non avvenute) le notifiche totalmente mancate o quelle talmente viziate da risultare incomprensibili o equivoche. Ma gli errori veniali non bastano: la legge, interpretata alla luce dei principi di buona fede e collaborazione, non tutela chi cerca di sfruttare un cavillo se non ha subito un reale pregiudizio. Dunque, “la forma è sostanza” solo fino a un certo punto: oltre, prevale la giustizia del caso concreto.
Se avete dubbi sulla legittimità di una cartella esattoriale ricevuta via PEC o vi occorre assistenza per un ricorso tributario, non esitate a contattare lo Studio Legale MP. Offriamo consulenza in diritto tributario e procedure di riscossione, per valutare insieme la soluzione più efficace – dall’impugnazione degli atti viziati alla definizione agevolata del debito – tutelando i vostri diritti di contribuenti.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.