

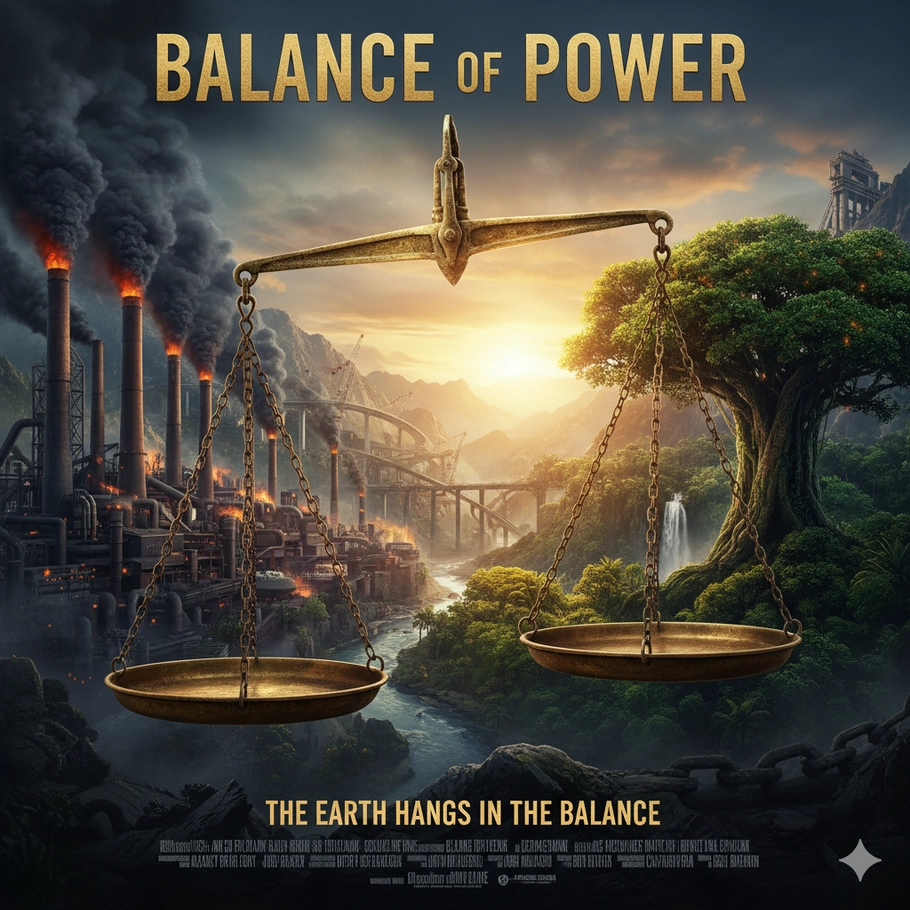
Le ultime pronunce giurisprudenziali hanno dato nuovo vigore al principio cardine del diritto ambientale, “chi inquina paga”. In passato le aziende potevano talvolta evitare sanzioni sfruttando incertezze nel nesso di causalità o assetti societari complessi; oggi questo è sempre più difficile. La Corte di Cassazione e i giudici amministrativi hanno chiarito che l’operatività del principio non può essere elusa con espedienti formali. Emblematica è la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1969/2025, che ha affrontato il caso di un’area industriale contaminata da più società: quando non è possibile attribuire con certezza quote di inquinamento a ciascun soggetto, tutte le imprese coinvolte possono essere obbligate in solido a bonificare l’intero sito. In altre parole, se dai dati raccolti emerge che più aziende hanno altamente probabilità di aver concorso al danno ambientale, l’ordinanza di bonifica può legittimamente colpire tutti i potenziali responsabili. Non si tratta di “punire innocenti”, ma di evitare che – in mancanza di una prova definitiva sulle singole condotte – nessuno risponda della contaminazione. Del resto, il danno ambientale ha carattere permanente: esso perdura finché l’inquinamento non viene eliminato, e ignorarlo non lo farà certo sparire. Naturam expellas furca, tamen usque recurret – puoi cacciare la natura con la forza, ma essa tornerà sempre. Così, se non è possibile stabilire con precisione matematica chi abbia causato cosa, il diritto impone comunque un intervento di bonifica, ripartendo l’onere tra tutti i soggetti presumibilmente coinvolti. Ciascuna impresa avrà poi la facoltà di rivalersi su eventuali ulteriori responsabili scoperti in seguito, ma nell’immediato la priorità è la messa in sicurezza e il ripristino dell’ambiente contaminato.
Questa tendenza a rafforzare gli obblighi ambientali delle imprese emerge anche in altre pronunce chiave del biennio. La Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 30930/2024 ha ribadito, ad esempio, che delegare funzioni ambientali a un responsabile interno non esime automaticamente gli organi apicali dall’obbligo di vigilanza: la delega di funzioni è valida solo se specifica, completa di poteri decisionali e di spesa, conferita a persona qualificata e adottata per reali esigenze organizzative. In ogni caso il vertice aziendale resta tenuto a controllare l’operato del delegato e risponde a titolo di culpa in vigilando qualora non impedisca violazioni ambientali dovute a carenze strutturali dell’impresa. In sostanza, non basta nominare un “responsabile ambientale” per dormire sonni tranquilli: se l’azienda beneficia di prassi inquinanti o risparmia sui costi di prevenzione, i suoi dirigenti ne risponderanno. Gli organi giudiziari stanno quindi convergendo verso un approccio sostanzialistico: guardare alla realtà effettiva dei rapporti economici e gestionali – e non alle sole forme giuridiche – per individuare chi deve farsi carico delle conseguenze di un inquinamento. Già l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2019 aveva introdotto il concetto di unità economica del gruppo d’imprese ai fini ambientali, sancendo che la società capogruppo può essere chiamata a bonificare i siti inquinati dalle proprie controllate, specie se queste sono state poi cedute o liquidate. Oggi questo principio trova ulteriore conferma: dai gruppi societari alle aree industriali con pluralità di operatori, l’ordinamento mira a impedire che il costo del degrado ambientale finisca per gravare sulla collettività o sui proprietari incolpevoli. La responsabilità ambientale segue chi ha tratto vantaggio dall’attività produttiva inquinante, “inchiodando” le imprese alle proprie responsabilità anche a distanza di anni.
Equilibrio tra industria e ambiente: il ruolo dei giudici e del legislatore
L’inasprimento delle responsabilità aziendali in campo ambientale si inserisce in un contesto più ampio di bilanciamento tra sviluppo economico e tutela della salute pubblica e della natura. Non esistono “diritti tiranni” – come ha ricordato la Corte Costituzionale – e persino la continuità produttiva delle imprese di interesse strategico nazionale trova un limite invalicabile nella salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza. Emblematica in tal senso è la recente sentenza Corte cost., n. 105/2024, riguardante il cosiddetto “decreto Priolo”. La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la normativa che consentiva di protrarre sine die l’attività di uno stabilimento industriale strategico nonostante gravi problemi ambientali, senza possibilità per il giudice di sospenderne la produzione. In particolare, la Corte ha imposto un correttivo: le misure speciali che bilanciano lavoro e ambiente nelle imprese strategiche non possono avere durata illimitata, ma devono essere circoscritte a un periodo massimo (nel caso specifico, 36 mesi). Oltre tale termine, se persistono pericoli concreti per la salute o l’ecosistema, l’autorità giudiziaria deve poter intervenire fino a inibire la prosecuzione dell’attività produttiva. Questo pronunciamento si colloca nel solco delle decisioni sui “decreti ILVA” di alcuni anni fa, riaffermando che la legge non può mai sacrificare del tutto la tutela ambientale in nome dell’economia: va sempre trovato un equilibrio ragionevole e temporaneo, perché l’ambiente e la vita delle persone hanno dignità pari – se non superiore – alle pur legittime esigenze produttive. Salus publica suprema lex: la salute pubblica e l’incolumità del territorio restano principi supremi dell’ordinamento, che orientano sia l’azione legislativa che quella giudiziaria. In pratica, l’impresa moderna deve accettare che standard ambientali rigorosi fanno parte del “gioco” e che eventuali scorciatoie a scapito dell’ecosistema non sono più tollerate né dal giudice né dal legislatore.
Stretta sulle imprese: sanzioni più severe e responsabilità ampliate
Accanto all’evoluzione giurisprudenziale, anche il quadro normativo si è recentemente aggiornato per rendere più efficace la tutela ambientale e prevenire condotte illecite da parte delle aziende. A livello europeo, una nuova Direttiva UE in materia di reati ambientali (che sostituirà la precedente 2008/99/CE) richiede agli Stati membri di introdurre sanzioni penali più elevate e nuove fattispecie di ecoreati, adeguando le legislazioni interne entro il 2026. Il legislatore italiano si è mosso di conseguenza con interventi significativi già nel biennio 2024-2025. La Legge 6 giugno 2025 n. 82, ad esempio, ha innalzato le pene previste per i reati ambientali ed esteso il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). In particolare, sono stati inclusi nuovi delitti contro l’ambiente e persino contro gli animali (è stato introdotto l’art. 25-undevicies nel D.Lgs. 231/01 per i delitti a danno di animali), a testimonianza di una crescente sensibilità verso tutte le forme di tutela del mondo naturale. Contestualmente, la legge ha aumentato le sanzioni pecuniarie 231 a carico delle aziende per i reati ambientali commessi nel proprio interesse o vantaggio: le quote di multa sono state innalzate, rendendo il rischio economico di tali illeciti molto più elevato di un tempo.
Un altro provvedimento degno di nota è il recente Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116, battezzato “Terra dei Fuochi”, mirato a contrastare con urgenza lo smaltimento illegale di rifiuti e i roghi tossici. Questo decreto, oltre a prevedere misure straordinarie per la bonifica delle aree maggiormente colpite da inquinamento da rifiuti, introduce nuove figure di reato e aggravanti per chi contamina l’ambiente, nonché poteri ispettivi rafforzati. Vengono stanziati fondi per le bonifiche nei siti più critici e al contempo irrigidite le pene per trafficanti di rifiuti e imprese colluse in tali attività illecite. Il messaggio politico-legislativo è chiaro: le imprese devono dotarsi di un rigoroso sistema di compliance ambientale e prevenzione del rischio, perché le violazioni non solo comportano sanzioni economiche e penali più dure, ma possono compromettere gravemente la continuità aziendale e la reputazione.
In sintesi, oggi più che mai l’attività d’impresa e la realizzazione di infrastrutture devono fare i conti con paletti ambientali stringenti. Dalla fase di progettazione – con obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale sempre più dettagliati e controlli serrati – alla fase di esercizio – con limiti alle emissioni, gestione sicura dei rifiuti e piani di monitoraggio – fino alle eventuali situazioni di crisi ambientale (sversamenti, incidenti, contaminazioni storiche da gestire), l’imperativo è la conformità normativa. Le aziende virtuose, che investono in tecnologie pulite e protocolli di sicurezza ambientale, non solo evitano sanzioni, ma godono di un vantaggio competitivo in termini di sostenibilità e rapporto con le comunità locali. Al contrario, chi sottovaluta gli adempimenti ambientali rischia di pagare un prezzo altissimo: provvedimenti sospensivi, obblighi di bonifica d’urgenza, cause risarcitorie milionarie e anche responsabilità penali e 231 con relative sanzioni interdittive. L’evoluzione in atto, dalle aule di giustizia ai decreti legge, mostra una convergenza verso un modello di sviluppo in cui ambiente e impresa non sono più contrapposti, ma devono procedere di pari passo. “Che senso ha una casa se non hai un pianeta tollerabile su cui posarla?” – si chiedeva provocatoriamente Henry David Thoreau. Oggi questa domanda risuona quanto mai attuale: la sostenibilità ambientale è divenuta condizione imprescindibile per qualsiasi attività economica duratura. Le imprese sono chiamate non solo a perseguire il profitto, ma a farsi custodi responsabili del territorio in cui operano, nell’interesse proprio e delle future generazioni.
Hai una questione ambientale che coinvolge la tua impresa o un progetto infrastrutturale? Lo Studio Legale MP può aiutarti a navigare tra normative complesse, adempimenti e contenziosi in materia di diritto ambientale e amministrativo. Contattaci subito per una consulenza personalizzata: il nostro team di professionisti esperti in tutela ambientale è pronto ad affiancare la tua azienda, garantendo soluzioni legali efficaci e orientate alla salvaguardia del territorio e dei tuoi interessi.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.