

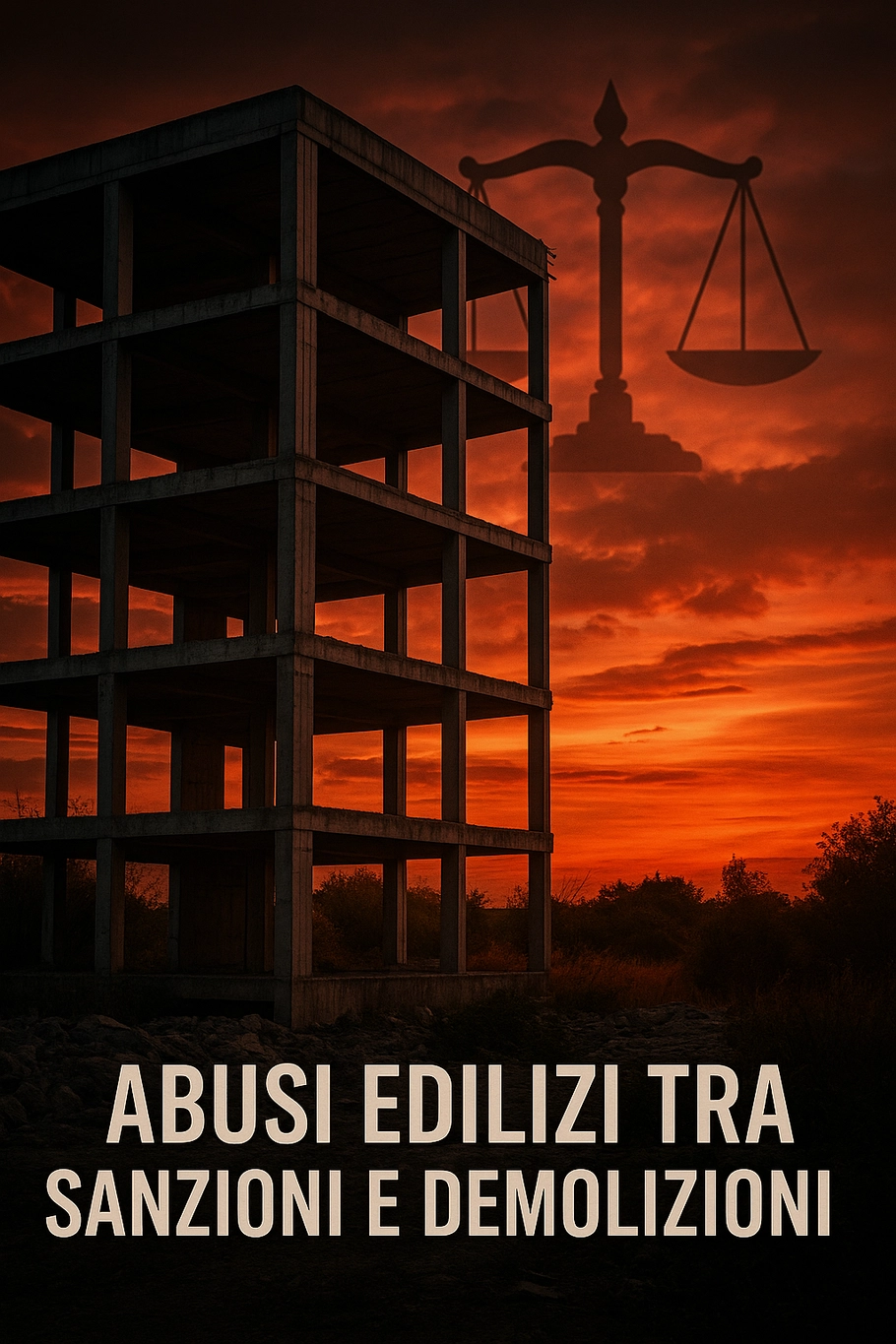
Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.
Questa famosa citazione dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa ben descrive la storia italiana degli abusi edilizi: normative che cambiano di continuo nel tentativo di conservare lo status quo delle costruzioni illegali. Oggi, però, la giustizia amministrativa sembra invertire la rotta. Recenti pronunce del Consiglio di Stato nel 2024 hanno chiarito quando è possibile evitare la demolizione di un’opera abusiva con una sanzione pecuniaria e quando invece un’opera edilizia incompiuta va rimossa senza sconti. Vediamo queste novità, utili a cittadini e imprese, in un’ottica tecnico-giuridica ma accessibile, con riferimenti reali alla giurisprudenza più recente.
In Italia il fenomeno dell’abusivismo edilizio è da sempre terreno di scontro tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela rigorosa del territorio e della legalità urbanistica; dall’altro, l’interesse privato a conservare il costruito, spesso supportato da provvedimenti di condono edilizio o sanatorie che negli anni hanno “sanato” molte opere fuori legge. Proprio in questo equilibrio delicato si inserisce il concetto di fiscalizzazione dell’abuso edilizio, ovvero la possibilità di evitare la demolizione di opere difformi attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria. Tale meccanismo, introdotto già dall’art. 33 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), consente di lasciare in loco l’immobile abusivo quando la demolizione risulti impossibile o troppo gravosa, a fronte di una multa pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente alle opere stesse. In altre parole: pagare invece di radere al suolo.
Questo compromesso (“multa in luogo di ruspa”) è stato spesso criticato perché visto come un favor verso chi viola la legge. Ecco perché la giurisprudenza recente ne sta ridefinendo i confini, per assicurare che la sanzione sia davvero deterrente ed efficace. Emblematica è la triplice pronuncia con cui il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria nn. 1, 2 e 3 del 2024, ha risolto importanti dubbi interpretativi proprio sull’applicazione dell’art. 33 T.U. Edilizia. La Plenaria ha ribadito che questa sanzione alternativa non deve trasformarsi in un premio per l’abusivo, ma garantire una risposta proporzionata all’illecito. Significativamente, i giudici hanno sottolineato come il calcolo della sanzione pecuniaria debba tenere conto dell’effettivo valore aggiornato delle opere abusive, e non di valori superati e risalenti al passato. Solo così la multa riflette realmente il vantaggio economico ottenuto con l’abuso, evitando di essere irrisoria. In altri termini, secondo il Consiglio di Stato la sanzione pecuniaria deve costituire una risposta punitiva omogenea ed effettiva, equivalente all’alternativa demolitoria. Dura lex, sed lex: la legge può anche apparire dura, ma è pur sempre legge – e dev’essere applicata in modo da non vanificare la tutela del territorio.
Giova ricordare che la possibilità di fiscalizzare l’abuso edilizio è limitata a casi tassativi. Ad esempio, l’art. 33 d.P.R. 380/2001 si applica solo quando non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio. Situazioni tipiche sono quelle in cui l’abbattimento di una parte abusiva comprometterebbe la stabilità dell’intero fabbricato. In tali ipotesi la legge consente all’amministrazione di riscuotere una somma di denaro in luogo della demolizione materiale. Dopo le sentenze della Plenaria, è chiaro però che questo “male minore” economico non può essere calcolato al ribasso: va aggiornato ai costi correnti e al reale valore di mercato del costruito.
In definitiva, sul fronte delle sanzioni pecuniarie la giurisprudenza amministrativa del 2024 ha alzato l’asticella: pagare al posto di demolire resta possibile in alcuni casi, ma il conto sarà salato e commisurato al beneficio economico effettivo tratto dall’opera illegittima. Ciò rende il sistema più equo e rigoroso, scoraggiando chi sperava di poter costruire fuori regola mettendo in conto, al massimo, una multa minima.
Un altro importante principio affermato di recente riguarda le opere edilizie incompiute a seguito di decadenza del permesso di costruire. Immaginiamo un caso frequente: il Comune rilascia un permesso per costruire un edificio, i lavori iniziano ma poi si interrompono e trascorrono anni. Il termine per ultimare l’opera scade, il permesso decade, e sul terreno rimane un triste scheletro di cemento incompiuto. Il proprietario potrebbe pensare che quanto realizzato resti acquisito, ma la giurisprudenza non è più di questo avviso.
La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 30 luglio 2024. Il verdetto ha fatto chiarezza in modo netto: se l’opera non è completata e non può esserlo legittimamente, quella struttura parziale va considerata abusiva a tutti gli effetti e ne va ordinata la demolizione. Non conta che originariamente vi fosse un permesso di costruire: una volta decaduto il titolo, ciò che rimane a metà è un manufatto diverso da quello assentito, privo di autonoma funzionalità e non conforme alle norme vigenti; in una parola, un abuso.
La Plenaria ha motivato questa conclusione richiamando un principio di conformità: il permesso di costruire autorizza solo la realizzazione integrale dell’opera descritta nel progetto approvato. Qualunque edificio realizzato in modo difforme – sia in eccesso, sia in difetto per mancato completamento – esula da quanto consentito e ricade nel regime sanzionatorio degli abusi. In particolare, i giudici hanno introdotto il concetto di “incompiuto architettonico” come ipotesi di difformità totale: quando i lavori si fermano allo scheletro o comunque prima di rendere l’edificio utilizzabile, il risultato finale è un aliud pro alio, qualcosa di diverso dall’opera progettata.
Il principio che emerge è chiaro: lasciare un’opera incompiuta sul territorio comporta di per sé un degrado ambientale e paesaggistico intollerabile. L’Amministrazione non può rilasciare un permesso solo per costruire “metà edificio”, e di conseguenza deve ordinare la rimozione di quello scheletro qualora il progetto non sia stato portato a termine nei tempi e non sia più autorizzabile. In sintesi, non esiste un diritto a lasciare a metà: se la costruzione non viene ultimata e non è regolarizzabile, va demolita perché equivale a un abuso sopravvenuto.
Queste pronunce del 2024 hanno un forte impatto pratico. Il messaggio che emerge è chiaro: la Pubblica Amministrazione ha gli strumenti e l’obbligo di ripristinare la legalità violata, sia attraverso sanzioni economiche severe, sia attraverso demolizioni senza esitazioni. Non c’è spazio per “zone grigie” dove l’abuso possa rimanere impunito o tollerato a metà. Chi realizza opere senza permesso o chi non completa i lavori entro i termini rischia concretamente di perdere quanto costruito o di dover pagare importi molto onerosi.
Come diceva Victor Hugo, «La forma di una città cambia più in fretta, ahimè, del cuore di un mortale». Le città e il territorio cambiano, ma il diritto amministrativo urbanistico è lì proprio per guidare questo cambiamento e guarire le cicatrici, garantendo uno sviluppo ordinato ed equo.

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.